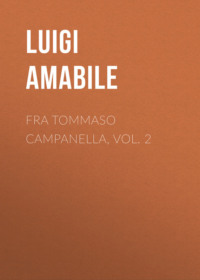Kitabı oku: «Fra Tommaso Campanella, Vol. 2», sayfa 33
Fermandoci alle mosse del Campanella nel 1605, riuscita inutile quella fatta in gennaio presso il Vicerè, dicevamo che in luglio ne fece un'altra presso il Nunzio e il Vescovo di Caserta: e qui innanzi tutto dobbiamo avvertire che Nunzio era ancora l'Aldobrandini, ma Vescovo di Caserta era fra Diodato Gentile, successo già al Tragagliolo nel Commissariato generale del S.to Officio in Roma, e poi successo al Mandina defunto nel Vescovato di Caserta, con exequatur del 24 luglio 1604, occupando del pari la carica di Ministro della S.ta Inquisizione nel Regno. Senza dubbio per far uscire il Nunzio dalla sua apatia verso di lui, il Campanella disse di volersi accusare, onde il Vescovo di Caserta fu chiamato ad intervenire egli pure; e così il Campanella potè anche dire di averli chiamati «con arte». Naturalmente, più o meno presto, essi doverono recarsi a S. Elmo, ed ivi in qualche sala ascoltare il Campanella, ma non videro la sua prigione: questo leggesi in un altro brano della lettera a Paolo V, ove il Campanella racconta che Mons.r Nunzio vide il carcere di fuori, e per non avere a contradire al Vicerè non entrò nè mandò a vederlo, e disse che era buono, «nel modo ch'ogni sepoltura par buona di fuori». Ecco ora il discorso del Campanella e le osservazioni de' due Vescovi; sarà meglio far parlare il Campanella medesimo: «M'accusai come, per mancanza dello spirito, che trovai tra' Cristiani molto difformi dell'antichità e profession nostra, mi risolsi ad esaminar la fede con la filosofia Pitagorica, Stoica, Epicurea, Peripatetica, Platonica, Telesiana e di tutte sètte antiche e moderne, et con la legge delle genti antiche e d'Ebrei, Turchi, Persiani, Mori, Chinesi, Cataini, Giaponesi, Bracmani, Peruani, Messicani, Abissini, Tartari, et com'ho con tutte le scienze finalmente humane e divine assicurato me stesso et gli altri che la pura legge della natura è quella di Christo, a cui solo li Sacramenti son aggiunti per aiutar la natura a ben operare con la gratia di chi l'ha dati; et che son pur simboli naturali et credibili: et vidi come Dio lasciò tante sètte caminare, e la mancanza dello spirito in noi, e lo scompiglio della natura e suo fine. Onde son fatto possente a difensar con tutto il mondo il Christianesmo; che fui sentinella fin mò dell'opere di Dio. E come la divina Maestà disegna in questo tempo far una greggia et un Pastore, e 'l giudicio dell'errore di tante nationi, e quel che soprastà al Christianesmo: e li sintomi celesti et terrestri del mondo morituro per fuoco, contra li filosofi con S. Pietro et Heraclito. La difficoltà del mondo nuovo, e dell'incarnatione et altri articuli difficultosi, l'esamina delle profetie e miracoli veri e falsi d'ogni setta. Et com'io et altri fummo ingannati dal diavolo aspettando scienza e libertà da lui, credendoci che fosse Angelo, e poi Dio, secondo si fingeva; e come, dopo lunga dieta, Dio benigno condescese al mio desiderio, che mai non fu maligno, se fu erroneo: e presentai memoriale di questa, e molti capi di cose faciende ad utile del Christianesmo. Nondimeno Monsignore Nuntio rispose ch'io era poco humile. Non so se l'ha fatto per provarmi: perchè ben so ch'è scritto nella Sapienza: Qui intuetur illam permanebit confidens: et che l'humiltà è magnanima et non vile, et io certo so che mai non ho bramato dignità nè honori, et a tutti vilissimi servitii ho posto mani. Sed neque me ipsum judico. Monsignor di Caserta fece conseguenza, ch'havendo io vagato per tante sètte, e cercato li miracoli veri e falsi, e le profetie e la novità del secolo, com'egli lesse nel mio processo in Roma, non havevo cattivato me ad ossequium Christi: e che mò voglio far miracoli falsi per scampare o allungar la vita. Ben fanno a non creder subbito; ma negarmi l'esperienza, o scriver a V. B. che «non la voglia vedere, è un negar lo spirito di Dio, che ubi vult spirat, et seguir lo spirito degli huomini: Venite cogitemus adversus Jeremiam» etc. Così il Campanella mostrava anche da questo lato che la sua pazzia era finita e già da qualche tempo, tanto che avea visto anche con altri il diavolo, e poi, dopo lungo aspettare in penitenza, Dio l'aveva esaudito ed oramai si sentiva in grado di far cose mirabili ad utile del Cristianesimo. Quali abbiano dovuto essere queste cose, delle quali diè «molti capi», si può comprenderlo dagli elenchi più volte indicati, estraendo da essi i capi relativi appunto all'utile del Cristianesimo: dovè quindi promettere di far il libro in dimostrazione della prossima fine del mondo coll'unione di tutte le genti costituendo una gregge ed un solo pastore, far il libro contro i politici e Machiavellisti, un libro per convertire i Gentili delle Indie orientali, un libro contro i Luterani, ed andare in Germania ottenendovi la conversione di due Principi protestanti e il discredito completo di Calvino, fare al ritorno 50 discepoli contro gli eretici etc. etc. Di certo egli dovè promettere anche di far miracoli, come non cessò poi di prometterli più o meno esplicitamente fino al 1611; ed anche nella sua prima lettera al Papa e in una lettera posteriore allo Scioppio, pubblicate entrambe dal Centofanti, si dolse che il Nunzio e il Vescovo di Caserta avessero chiamato finzioni, delirii od astuzie, per uscire dal carcere, i suoi presagi, i suoi segni nel sole, luna e stelle, e i miracoli che avrebbe fatto per costringere ogni anima a riconoscere il Vangelo. Questo d'altronde emerge dalle osservazioni medesime fatte da costoro, quali il Campanella le narrò al Papa, da doversi dire in verità rispondenti a quanto sappiamo del carattere dell'Aldobrandini, che ci è abbastanza noto, e del Gentile, che parecchi documenti ci mostrano spietato ed esorbitante non meno del Mandina457. Secondo il nuovo Vescovo di Caserta, il Campanella voleva «far miracoli falsi per scampare od allungar la vita»; sicchè, nel concetto di questo Vescovo, pel disgraziato filosofo si trattava sempre di avere a perdere la vita più o meno presto. Dobbiamo intanto dire che il Vescovo di Caserta, per parte sua, ebbe a scrivere qualche cosa a Roma intorno a tale colloquio, ma il Nunzio non scrisse certamente nulla, come ci mostra il suo Carteggio del 1605, ultimo anno di ufficio per lui: che anzi in una sua lettera del 24 agosto 1605 al Card.l Valenti, tenuto allora provvisoriamente da Papa Paolo «nel luogo che si sogliono adoperare i proprii nipoti», passando a rassegna, per sua giustificazione, i casi di torto giurisdizionale da lui trattati, egli non citò punto il caso del Campanella, e quindi dalla parte del Nunzio, non meno che dalla parte di Roma, rimaneva non curato il torto ricevuto in persona del povero filosofo, contentandosi che la sua causa non fosse spedita. Dalla parte del Campanella poi ognuno avrà notato come, tanto presso il Vicerè, quanto presso il Nunzio, egli non fece la menoma richiesta che la sua causa fosse spedita; nè veramente espresse mai più un desiderio simile per lungo tempo, se non sotto certe condizioni.
Scorsero non meno di 10 mesi dal detto colloquio, e il 13 agosto 1606 il Campanella si spinse a rivolgersi direttamente al Papa, moltiplicando anche questa volta i reclami e le lettere in più sensi e non trovando requie per molto tempo. Sicuramente tanto ritardo non provenne dall'essersi rassegnato, e lo dimostrano i gridi di dolore che sovente erompono nelle dette lettere; ma bisogna dire che egli non nutriva alcuna speranza di essere ascoltato, e però non si mosse di nuovo se non quando avvenne un fatto tale da tenere in agitazione vivissima l'animo del Papa; fu questo l'interdetto scagliato a Venezia, seguito dalla superba resistenza del Governo Veneto, e dall'abbandono del Papa in una pessima condizione da parte di coloro medesimi che gli aveano offerto aiuto. Allora appunto il Campanella tentò di profittare dell'occasione e scrisse la sua lettera, nella quale comincia col giustificarsi degli stratagemmi usati durante la causa (e certamente del principale tra essi che era stato la pazzia, come risulta dal veder citata l'autorità di S. Geronimo), si appella mostrando la necessità di venir tradotto a Roma e l'impossibilità di consentire che il giudizio della congiura ed anche dell'eresia termini in Napoli, fa un racconto delle cose di Calabria e degli avvenimenti posteriori come può farlo un giudicabile, riconosce commessa da lui la colpevole imprudenza di aver servito alla «revelation presente» ed esservi stato un «voluto, non fatto, eccesso», chiede per giudici il Bellarmino e il Baronio ma non in Napoli, coll'affermare che ha cose grandi, parole di cielo, da dire al Papa e alla Chiesa, ed aggiunge un poscritto in cui dichiara avere avuto nuova delle cose di Venezia, occorrere una guerra spirituale e la chiamata di tutte le persone sante a Roma, per parte sua obbligarsi a mostrare con miracoli stupendi la verità del Vangelo ed allungare le profezie laddove sia necessario. Questo poscritto apparisce l'occasione vera della lettera, la quale è seguita poi da un'altra, o, se piace meglio, da un allegato, in cui pel fatto di Venezia insiste sempre più sulla necessità di venir tradotto a Roma, narra le rivelazioni avute dal diavolo fintosi angelo tre anni prima, e per esse la caduta di Venezia nel 1607 con la perdita di gran parte dell'autorità del Papa, la caduta della dignità Pontificale e del Senato Cardinalizio dietro uno scisma dopo il 1625; narra poi la comparsa successiva di altri diavoli che l'afflissero, e in sèguito, dietro preghiere a Dio, le rivelazioni vere che ebbe con gli avvertimenti da dover dare a S. S.tà, e suggerisce consigli, e cita profezie, e dichiara di voler parlare a S. S.tà e poi morire etc. etc.
Importa commentare quest'altra mossa del Campanella, sempre più degna di attenzione comunque rimasta senza il menomo effetto. Non a torto dovè sembrargli molto opportuna l'occasione per rivolgersi al Papa. Fin da' primordii del suo Pontificato Paolo V si era mostrato assolutamente deciso a far rispettare ad ogni costo l'immunità ecclesiastica, e dopo di aver fatta e facilmente vinta una quistione con Lucca e poi con Genova in condizioni davvero esorbitanti, avea voluto farne un'altra anche con Venezia, che non si era mai adattata a riconoscere l'immunità ecclesiastica negli Stati suoi458. Annunziato dapprima con un Breve fin dal dicembre dell'anno precedente, emanato dappoi nel solenne Concistoro del 17 aprile 1606 il gran Monitorio, che dichiarava incorsi nelle scomuniche il Doge e il Senato Veneto per essersi rifiutati a consegnare al Nunzio due scellerati malfattori, il Canonico Saracino e il Conte Brandolino Abate di Narvese, Venezia si era mostrata inflessibile, si che il Papa avea stimato opportuno radunare un grosso esercito, e Venezia avea dovuto fare altrettanto. Napoli, così vicina, non poteva rimanersi indifferente, e dal Carteggio del Residente Veneto Agostin Dolce si rilevano, con le rispettive date, i fatti avvenuti allora nella città. I Gesuiti, irritati anche per essere stati espulsi da Venezia i frati del loro ordine insieme co' Teatini e Cappuccini ossequenti al Papa, gridavano nelle scuole contro Venezia e diffondevano per la città alcuni presagi tratti specialmente dal libro di M.o Antonio Arquato medico (in ciò i Gesuiti s'incontravano col Campanella). Il Nunzio Mons.r Guglielmo Bastoni Vescovo di Pavia, successo all'Aldobrandini fin dal dicembre passato, benediceva pubblicamente la capitana delle galere che partivano sotto il comando del Marchese di S.ta Croce per fare una dimostrazione ostile a Venezia, mentre un inviato, Ugo de Moncada, andava a Roma per dichiarare il Vicerè pronto a vendicare con la persona e col Regno le offese che fossero fatte a S.ta Chiesa, emulando le offerte del Conte di Fuentes Governatore di Milano e de' Duchi di Modena e di Urbino. Ma appunto a' primi di agosto si venne a sapere che il Marchese di S.ta Croce si era limitato a veleggiare nelle acque di Brindisi, ciò che in realtà non era tollerato da' Veneziani, ma avea finito poi col rivolgersi contro i pirati di Durazzo ed espugnare questa città; che per armare le galere si era preso il danaro de' privati dal Banco di S. Eligio; che bisognava pensare a provvedersi di grano poichè quello promesso, da doversi estrarre dalla Marca d'Ancona, non sarebbe più venuto; che mancando il danaro, ed essendo le gabelle divenute insopportabili, già si pensava di sospendere il pagamento degli interessi agli assegnatarii (creditori dello Stato) come poi si verificò; che per tutte queste ragioni non si sarebbe passato alle armi, e in ultima analisi da Spagna erano venuti anche ordini di non passare alle armi459. Naturalmente il Campanella dovè giudicare che oramai poteva provarsi presso un Papa tanto attaccato all'immunità da pretenderla anche là dove non c'era mai stata, e tanto poco avveduto da compromettere a quel modo l'autorità Pontificia, riducendosi poi a supplicare almeno l'invio da Napoli di un'Ambasciata a Venezia per trattare la pace, ciò che fu commesso a D. Francesco de Castro accompagnato dal Duca di Vietri, due nostre vecchie conoscenze.
Egli credè pertanto necessario rannodare la sua mossa alle precedenti, dare alla sua lettera l'impronta di un «appello», che secondo lui dovea render nullo il giudizio compiuto, siccome disse tanti anni dopo nella sua Narrazione, e credè anche necessario rifare la storia delle cose di Calabria, spingendosi ad affermazioni che crediamo inutile dimostrare insussistenti dopo tutto ciò che abbiamo visto nel corso della narrazione nostra. Basterà citar quelle, che l'eresia fu trovata da' frati, che il negozio de' turchi fu inventato da lui per non morire, che furono appiccati sul molo uomini per altra causa, che fecero confessare a Maurizio sub verbo regio mille bugie, che tutti morendo si ritrattarono. Ma gioverà notare due cose: l'una, il bisogno che sentì sempre di non essere messo a fascio con fra Dionisio divenuto maomettano, «di cane fatto lupo pe' gridi di mali pastori»; l'altra il nessun desiderio ed anzi il rifiuto di vedere spedita la sua causa in Napoli. Su quest'ultimo punto egli si espresse recisamente: non consentirebbe in Napoli a giudizio alcuno, perchè era odiatissimo, perchè non vi erano aequa jura, perchè avrebbero detto al Nunzio che era finita la causa e lo condannasse senza ascoltarlo (così difatti avrebbe dovuto accadere). Nè si trattenne dallo scrivere: «questi giudici anche ecclesiastici più tosto mi vorrebber trovar nocente che innocente, perchè… non si fidano nè ponno difensarmi la innocenza, se in me la trovano, come Nicodemo non difese Christo; ma sendo colpevole senza briga ponno starsi e gratificarsi con questi Signori», mentre «non hanno alcuna autorità se non di farmi male, perchè son ligati al farmi bene». In somma la sua causa era straordinaria e dovea trattarsi in Roma, annullando, s'intende, ciò che si era fatto sin allora, ed egli volea che si dimandasse la persona sua, anche con l'obbligo di restituirla a Napoli qualora fosse trovata in falso. Più tardi poi disse che non aveano potuto conchiudere la causa della congiura in Napoli, perchè non aveano in che condannarlo: questa contradizione non ha bisogno di commento.
Ma un po' di commento occorre al fatto della comparsa del diavolo tre anni prima, invocato da una persona che egli aveva istrutta a pigliar l'influsso divino (sicuramente il Gagliardo), delle rivelazioni avutene anche circa Venezia e il Papato, e poi della comparsa di altri diavoli nella fossa, col sèguito delle grazie ottenute per via di flagelli e di studii, dell'avere avute altre rivelazioni, dell'esser divenuto capace di far miracoli, o, secondochè disse poco dopo, dell'aver visto angeli ed avuto autorità come quella di S. Giovanni a' farisei e potestà di far miracoli più stupendi che quelli di Mosè460. La frequenza ed asseveranza, con le quali il Campanella parlò in prosa ed in versi della comparsa del diavolo, delle rivelazioni avute e delle conseguenze di esse, non possono non fare un certo peso; e la cosa riesce di tanto maggiore interesse, in quanto che segna il punto di partenza del suo passaggio definitivo, reale o simulato, nel campo delle credenze cattoliche pure, e quindi riflette il vero problema difficilissimo della vita del Campanella, cioè l'essenza delle sue intime convinzioni religiose. Potrebbe ammettersi un'allucinazione, ma non mai la «lunga aberrazione mentale», che il Centofanti ha invocata e che si vede ricordata ancora da altri, mentre il Campanella medesimo non fece poi un mistero che la sua pazzia era stata simulata, e lo ripetè egualmente in prosa ed in versi troppe volte, sebbene in qualche determinata circostanza siasi contraddetto461. Ci sembra pertanto che invece dell'allucinazione riesca più verosimile trattarsi di un fatto molto semplice, dell'evocazione de' diavoli esercitata dal Gagliardo, amplificata e messa innanzi dal Campanella così per premunirsi contro qualche nuova denunzia al S.to Officio specialmente da parte del Gagliardo, come per procacciarsi qualche via di uscita nelle sue tristissime condizioni, giustificando il suo ritorno nel retto sentiero con un evento straordinario, ed eccitando la curiosità e l'interesse del Papa, mentre poi, alla peggio, avrebbe potuto tutt'al più acquistarsi una riputazione di stravagante, che sarebbe sempre riuscita giovevole alla conclusione della sua causa. Benchè si possa dire aver lui veramente professata l'esistenza di spiriti buoni e rei, o «più o meno buoni», custodi de' pianeti e delle stelle ed anche vaganti pel mondo, dal processo di eresia conosciamo che con gli amici suoi avea sempre riso del diavolo nelle condizioni e forme comunemente ammesse; e conosciamo che il Gagliardo si era occupato realmente di diavolerie, con ogni probabilità sotto gli occhi del Campanella, ma nemmeno possiamo dire che l'avesse fatto con quella larghezza e serietà che dalle affermazioni del Campanella emergerebbero, poichè egli non si sarebbe trattenuto dal farne parola nelle sue ultime deposizioni in S.to Officio, almeno per tentare di allungar la vita; forse egli attese alle scene di comparsa del diavolo, secondo il suo solito, per profitto, non che per acquistarsi la considerazione e l'ossequio de' carcerieri, e fu in questo agevolato dal Campanella che ne avea bisogno egualmente, laonde non dovè poi dare a quelle scene tanta importanza, e riesce un po' duro ad accettare che invece abbia dovuto darcela sul serio il Campanella. Conosciamo poi che non appena pose mano a comporre poesie ed opere nella fossa di S. Elmo, il Campanella attestò dapprima il fatto puro e semplice dell'apparizione evidente di diavoli a lui occorsa, ma con la circostanza un po' singolare nel fondo e nella forma, che per quel fatto era divenuto più uomo da bene (come abbiamo visto in qualche poesia e nell'opera Del Senso delle cose); più tardi, nell'Ateismo, tornò sul fatto corredandolo di molti particolari misteriosi già più volte menzionati, nè si trattenne dall'affermare nelle lettere che gli era stata con inganno promessa dal diavolo scienza e libertà, e dall'affermare nelle poesie che gli era stato pure promesso che «sarebbe esaudito», che «si canterebbe Viva Campanella nel fine del suo carcere»462; d'altronde in un brano dello stesso Ateismo debellato, lasciando chiaramente intendere essere stato lui medesimo in relazione co' diavoli per mezzo del Gagliardo, reca un'altra delle risposte avute là dove dice, «Astrologo per juvenem interroganti de multis dixerunt, quod ipse scripsisset de libero arbitrio, sed rectius Calvinum». Dopo tutto ciò si ammetta pure che tra le bizzarrie del Gagliardo, durante l'evocazione de' diavoli, vi sia stata quella di far pronostici su Roma e su Venezia; ma nessuno vorrà credere che il Campanella abbia prese sul serio altrettali visioni, e non le abbia rivedute e corrette, aggiungendovi del suo tante singolari particolarità oltrechè una coda non indifferente, in vista de' suoi gravi bisogni. Nè ci sembra punto temerario il ritenere che le visioni consecutive degli angeli, e le facoltà ottenute da Dio, siano del medesimo stampo; e tutto il garbuglio ci apparisce consentaneo all'indole del Campanella, perpetuamente motteggiatrice anche nelle circostanze più terribili, rimanendo vero soltanto che Dio gli avea concesse facoltà intellettive ed operative straordinarie, atte a costituirlo, secondo il suo concetto, condottiero della umanità con un migliore indirizzo.
Ma dunque il Campanella potè mentire a tal segno? Eh sì, non c'è da farne le meraviglie, e c'è da farle invece perchè si sia mancato di riconoscerlo, mentre egli non mancò di dichiararlo, segnatamente nelle sue Poesie; nè adoperò alcuna circumlocuzione nel dichiararlo, e se i posteri non hanno voluto capirlo, la colpa senza dubbio non fu sua. Egli disse nettamente che era «bello il mentire» in determinate circostanze, appellandosi agli esempî della storia sacra e profana, e non meno nettamente pure disse che i savii, per schifar la morte, «furon forzati a dire e fare e vivere come gli pazzi, se ben nel lor segreto hanno altro avviso»463. Nè fu propriamente lui che inventò la trista massima «intus ut libet, foris ut moris est», bensì egli fu costretto a seguirla; nè ci sorprenderebbe che si gridasse allo scandalo, comunque pur oggi si tolleri con la più grande indifferenza che quella massima sia seguita gloriosamente da tanti e tanti, senza pur l'ombra delle condizioni del Campanella; basta considerare il numero grandissimo degli spiriti forti in religione, e de' partigiani de' cosi detti grandi principii in politica, che quasi sempre «nel lor segreto hanno altro avviso» per onta e malanno dell'umanità. Ma bisogna anche guardarsi dal comparare le cose grandi alle meschine, e però aggiungiamo di non credere che possa rimanerne vulnerata la fama del Campanella presso le persone non volgari. A niuno è venuto in mente mai che la fama di Galileo Galilei sia rimasta vulnerata dall'avere, con la sua abiura, affermato il contrario di ciò che pensava: l'infamia è ricaduta su coloro che ve lo costrinsero, e pel Campanella, travolto in un abisso di miserie che non ha riscontro nella storia de' nostri uomini di lettere, non è possibile avere un concetto diverso senza manifesta ingiustizia. Aggiungasi che egli si credeva nato per una missione altissima, per «debellare i tre mali estremi, tirannide, sofisma, ipocrisia», nè semplicemente con lo scriver libri, come potrebbe supporsi dietro monche notizie della sua vita; ed ebbe poi a provare, nel modo più efferato, «il senno senza forza de' savii esser soggetto alla forza dei pazzi» non solamente dall'alto, ma anche dal basso, non solamente da parte de' grandi, ma anche da parte del popolo le cui sorti egli si era sforzato di rialzare, ciò che gli diede amarezza infinita, come si rileva da più punti delle sue poesie. Eppure non disperò nè si arrestò mai, ciò che prova la ricchezza e la nobiltà della sua natura; ma necessariamente tutte le maniere di astuzia doverono sembrargli accettevoli, anche quelle che agli animi nostri, tanto distanti dal suo, recano molto dolore. Così coloro i quali ebbero l'opportunità o la sagacia di saperne o penetrarne i pensieri intimi, lo apprezzarono maggiormente o lo vituperarono secondo i proprii umori diversi; e son note certe qualificazioni denigranti assegnate specialmente a talune delle sue opere più caratteristiche, certi epiteti ingiuriosi affibbiati alla sua persona, quando non si volle o non si seppe intendere che egli aveva idee riposte, nemmeno tenute addirittura sepolte ed erompenti sempre, perfino mentre era obbligato ad esternare idee di tutt'altro colore per uscire dalla sua tristissima condizione. Egli non tacque le sue idee riposte in politica e in religione, che trovò modo di esporre con un vero stratagemma, secondo una maniera non nuova ma più che ardita nello stato suo, facendo la descrizione della immaginaria Città del Sole; e poichè nella sua estrema vecchiezza ne curò la ristampa e vi aggiunse ancora le Quistioni sull'ottima repubblica, composte veramente da un pezzo e poi messe da parte, si ha motivo di ritenere che a queste idee, con poche varianti, egli sia stato attaccato fino alla morte. Intanto è costretto a salvarsi dall'ira universale, è costretto a mostrarsi diverso da quel che è; non giunge per questo a nascondere le sue interne credenze, e più volte anzi s'ingegna di farle rilevare almeno a' savii, ma pur troppo i savii riescono vigilanti solo tra' suoi avversarii o sonnecchiano affatto. Perfino nella lettera che egli scrive in appello al Papa, lo si vede deplorare «l'ecclisse di spirito» e che «bisogna credere o andar prigione», lo si vede annunziare che il Cristianesimo è «la pura legge della natura, a cui solo li sacramenti son aggiunti per aiutare la natura a ben operare», non lodando così certamente lo spirito della Curia, ed attribuendo a Dio creatore una parte affatto preponderante su Dio salvatore. Nelle opere poi, nello stesso Ateismo debellato, destinato a rappresentare la sua rumorosa professione di fede atta a salvarlo, sia quando impiega la maniera di esposizione ad utramque partem, sia quando adotta la maniera di esposizione ordinaria ed obiectionibus occurrit, lo si vede produrre con tanta larghezza gli argomenti degli avversarii, da aggiungerne perfino molte volte taluni non prodotti mai e suggeriti propriamente da lui. Il fatto trovasi notato da un pezzo quasi come una scoperta, mentre, se fossero state sempre lette con attenzione le cose del Campanella, si sarebbe visto che da lui medesimo non era stato taciuto464: pertanto esso ti rimane molte volte incerto se l'autore abbia veramente voluto convincerti appieno sull'opinione che sostiene, o invece illuminarti meglio su quella che combatte; sempre poi ti obbliga a riflettere su quello che espone e su quello che non può esporre, su quello che spesso accenna doversi fare e che s'intende non poter fare. Ma il nostro assunto ci trattiene dall'affisare lo sguardo in questo orizzonte elevato, e ci richiama al penoso viaggio pedestre che abbiamo intrapreso: solo dimandiamo di poter dichiarare ancora una volta, che a nostro modo di vedere è indispensabile farlo questo viaggio prima di librarsi a volo, in caso contrario si correrà il rischio di una falsa strada465.
IV. Noi potremmo fermarci qui, bastandoci di aver mostrato non senza una certa larghezza le tre principali occasioni e maniere, nelle quali il Campanella, dando un termine manifesto alla sua pazzia, tentò successivamente ed infruttuosamente, presso lo Stato e presso la Chiesa, di essere ascoltato per non rimanere sepolto nella fossa di S. Elmo. Ci parrebbe tuttavia di non avere esaurito il nostro còmpito, se non narrassimo anche il sèguito de' tentativi da lui fatti ulteriormente ed a breve intervallo, non solo presso la Curia Romana, ma anche presso la Corte di Madrid e presso le Corti Cattoliche di Germania, con tutte quelle lettere e mediante tutte quelle persone che abbiamo avuto bisogno di citare più volte.
Nello stesso anno 1606, quasi immediatamente dopo di essersi rivolto al Papa, egli invocò l'aiuto del Card.le d'Ascoli (fra Girolamo Bernerio Domenicano, protettore dell'Ordine), e poi anche quello de' Card.li Farnese e S. Giorgio. Non è pervenuta fino a noi la lettera diretta al Card.le d'Ascoli, ma n'è rimasta soltanto la notizia nelle altre dirette agli altri Cardinali. Queste furono scritte in data del 30 agosto 1606, cioè 17 giorni dopo che era stata scritta la lettera al Papa, ed offrono gli argomenti medesimi addotti al Papa, con poche varianti ed un cenno fugace delle rivelazioni intorno a Venezia. Sempre rifacendo la storia delle cose di Calabria in una maniera adattata alla sua difesa, dichiarando di essersi salvato con la stoltezza dove era odiosa la virtù e di aver finto contro la violenza dietro l'esempio di David, annunziando grandi rivelazioni avute e le grazie de' miracoli per beneficio della Chiesa, supplicò che fosse ascoltato de jure e che l'aiutassero a farlo chiamare a Roma anche condizionatamente; aggiunse l'elenco delle promesse fatte ad utile del Re e della Chiesa, come pure l'elenco dei libri fin allora composti per dimostrare che egli era in grado di mantenere le sue promesse466. È superfluo dire che non ottenne nulla; probabilmente non ebbe nemmeno una risposta da qualcuno de' Porporati suddetti.
Ma ne' primi mesi del 1607 nuove e più forti speranze si destarono nel Campanella, avendo già potuto acquistare la conoscenza di Gaspare Scioppio oltre quella di Giovanni Fabre, spinti da' Fuggers in aiuto suo. Qui alle notizie dell'Epistolario che diremo napoletano, pubblicato in parte dal Centofanti e in più gran parte da noi, son venute or ora ad unirsi le notizie dell'Epistolario romano del Fabre dateci dal Berti, ma è a deplorarsi che la massa dei documenti di quest'ultimo Epistolario giaccia pur sempre inedita, sicchè nemmeno si è in grado di parlare del periodo in quistione con tutta l'esattezza che si richiede467. Cristoforo Pflugh, che aveva eccitato in favore del Campanella i Fuggers e tra essi principalmente Giorgio, eccitò pure lo Scioppio, avendo con ogni probabilità già prima impegnato il Fabre. La lettera autografa del Campanella allo Pflugh, da noi pubblicata, ci mostra fuori contestazione che lo Scioppio venne eccitato da Cristoforo: e possiamo ben dire che le relazioni tra il Campanella e lo Scioppio cominciarono non prima del 1607. Per certo il brano di lettera del Campanella allo Scioppio, posto dal Centofanti innanzi tutte le lettere Campanelliane da lui pubblicate, perfino innanzi a quella del 13 agosto 1606, fu così posto arbitrariamente, e non può servire a dimostrare una relazione tra' due personaggi anteriore al 1607: parlandosi, in quel brano, dell'impresa di convertire due Principi non che di allettare i savii di Germania mercè le nuove dottrine, risulta abbastanza chiaro che debba riferirsi al 1607, al tempo in cui lo Scioppio era destinato a partire per la Germania in missione presso la Dieta di Ratisbona468. Gaspare Scioppio di Neumark, giovane grammatico eruditissimo, se ne stava da 8 o 9 anni in Roma, dove aveva abiurato il Protestantismo, e spiegando un fervore rabbioso contro gli antichi correligionarii, scrivendo successivamente panegirici al Papa e al Re di Spagna, Commentarii sulla verità Cattolica, sull'Anticristo, sul primato del Papa ed anche su' Priapei, era venuto in fama e al tempo stesso in molto favore presso la Curia Romana, tanto che dovendosi mandare qualcuno invece di un Nunzio alla Dieta di Ratisbona, Paolo V decise mandarvi lui con la veste di Consigliere di casa d'Austria; e possiamo affermare che già nel febbraio 1607 era Consigliere Austriaco, poichè con questo titolo lo troviamo nominato appunto nella Disputa del Fabre «De Nardo et Epithimo adversus Scaligerum, Rom. 1607» a lui diretta in data del 1o febbraio di tale anno. Quanto a Giovanni Fabre di Bamberga, domiciliato in Roma dal 1600, egli era medico dell'Ospedale di S. Spirito, lettore di Anatomia alla Sapienza, inoltre Prefetto dell'Orto Vaticano onde s'intitolava Semplicista di N. S.re; è noto poi che venne più tardi ascritto alla famosa Accademia dei Lincei insieme col Persio (1611), e divenutone Cancelliere (1614) ebbe a scrivere le «Praescriptiones Lynceae» etc. etc. Lo scopo di Giorgio Fugger nel proteggere tanto vivamente il Campanella, era sopratutto quello di adoperarlo a' servigi del Cattolicismo in Germania, giudicandolo per la sua dottrina, eloquenza ed attività, il più capace di combattere con successo i Protestanti. Si sa che nelle feroci dissensioni religiose di Germania i Fuggers erano tra' Cattolici più caldi, e che un Ottone Enrico Fugger, giovinetto al tempo del quale trattiamo, distintosi poi in molte fazioni militari sotto le bandiere di Spagna, fu quello che in ultima analisi prese Augusta, vi depose il Senato Luterano e ve ne istituì uno Cattolico. Non fa quindi meraviglia l'ardore di Giorgio per liberare il Campanella, non conosciuto da lui come colpevole di eresia ed invece stimato vittima di malevoli, onde lungamente tentò tutti i mezzi per averlo in Augusta, lo soccorse in danaro e in commendatizie, lo protesse e lo fece proteggere, lo fece visitare e lo visitò egli medesimo, destinò una forte somma per farlo fuggire o liberare: le promesse di miracoli, le affermazioni di possedere segreti meravigliosi, le esagerazioni di ogni maniera, che il Campanella avea poste innanzi per acquistarsi la grazia e l'interesse de' potenti, non destavano allora le diffidenze di oggidì se non presso i ben pochi spregiudicati; si può dire che esse giovarono più che nocquero, e forse contribuirono sopra ogni altra cosa ad infervorare i Fuggers nella protezione del Campanella. Lo Scioppio riusciva pel filosofo un uomo provvidenziale, essendo confidente della Curia Romana e destinato ad avvicinare l'Imperatore Rodolfo, l'Arciduca Massimiliano di Baviera, l'Arciduca Ferdinando di Austria e tutti que' Principi di Germania che erano impegnati con Spagna a sostenere gl'interessi del Cattolicismo; il Fabre poi riusciva sempre un buono assistente ed un utile intermediario per la corrispondenza, la quale era già avviata da un pezzo tra i Fuggers residenti in Augusta e il Campanella, venendo le lettere dirette a un Marco Velsero gentiluomo di molta levatura ed influenza e non a' Fuggers, e d'allora in poi doveva allargarsi comprendendo anche le lettere dello Scioppio. Motori di tutte queste pratiche erano, come ben si vede, i Fuggers, e di essi specialmente Giorgio, mentre in Napoli si prestava con tenera sollecitudine fra Serafino di Nocera, che il Campanella chiamava suo «tutore»; per altro Giorgio mandò talvolta anche qualche suo agente particolare, dapprima forse un Sigismondo, che trovasi nominato nell'Epistolario napoletano ma che potrebb'essere veramente un incaricato dello Scioppio, più tardi poi un Daniele Stefano di Augusta, che trovasi nominato nell'Epistolario romano e che deve dirsi con sicurezza un agente di Giorgio.
«Bruto e Solon furor finto copersee Davide temendo il re Geteo.Però là dove Jona si sommersetrovandosi l'Astratto, quel che feoal santo Senno in sacrificio offerse». S'intende bene che l'Astratto qui è il Campanella, il quale si trovava in faucibus Orci, come sovente si espresse; e che avrebbe potuto dire di più nelle sue condizioni? Pur troppo, segnatamente nella Narrazione, disse anche essere stato pazzo «non finto»: questo pertanto mostra solo che le sue circostanze l'obbligarono molte volte a nascondere il vero, e che però le sue assertive debbono essere vagliate con molta circospezione.
«Bello è il mentir, se a far gran ben si prova». E nella nota quivi annessa citò la menzogna di Ulisse a Polifemo, e di Sifra e di Puha a Salomone. In un'altra nota annessa al Madrigale 4.o della «Canzon II al Primo Senno», parlando dello Spirito impuro, disse che esso è per natura mendace, ma aggiunse che «è segno di natura corrotta e viziosa, quando mente non per industria, bisogno e sagacità». L'essere poi stato costretto a fingere, e l'aver finto, si rileva dal Sonetto intitolato «Senno senza forza de' savii esser soggetto alla forza de' pazzi», dove il filosofo ci apparisce ritratto con la maggior fedeltà, essendo quivi citati i suoi presagi, le sue «Regie imprese» e le conseguenze di esse.