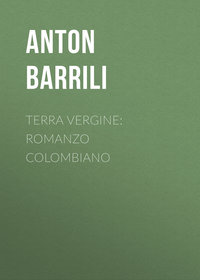Kitabı oku: «Terra vergine: romanzo colombiano», sayfa 20
Con questi ragionamenti, fatti a pezzi e bocconi, quando l'occasione si offriva, Martino Alonzo Pinzon credette di giustificare la sua dimora prolungata a Palos. Ma intanto ch'egli si consumava di rimorsi e di rabbia, gli giungeva una lettera dalla Corte. I sovrani non tenevano verun conto delle sue millanterie; lo rimproveravano in quella vece della sua disobbedienza all'almirante, e finivano dispensandolo da una visita che sarebbe stata penosa per tutti.
Martino Alonzo Pinzon non rèsse a quel colpo. Già poco ci voleva per abbattere quella rovina d'uomo. Vittima dell'invidia sua, dei rimorsi, della vergogna ond'era stato oppresso così duramente, il comandante della Pinta in capo a pochi giorni fu trovato morto nel suo letto. Gli stenti del fortunoso viaggio, un vizio del cuore, un insulto apoplettico, diedero ragione sufficiente di quella morte improvvisa.
La storia non sarà disumana con Martino Alonzo Pinzon. Essa, obbligata ad essere la più umana di tutte le scienze, poichè ha per sua materia gli uomini e le opere loro, ha certamente il diritto di ridurre a più giusta misura gli eroi, fabbricati o ingranditi da vecchi narratori sulla traccia dei grandi eventi a cui ritrovarono il loro nome associato. Ma essa può e deve essere compassionevole, senza tralasciare di esser giusta, con quei modesti cooperatori delle grandi imprese, i quali ebbero il torto di voler parere più alti del vero. Quanti eroi della leggenda, ed abbastanza rispettati dalla critica, non si mostrano da meno di quel povero Martino Alonzo Pinzon! Intrepido marinaio, ma di poca coltura, in un tempo che ai suoi pari non se ne richiedeva nessuna, egli cedette in un cattivo momento ai demoni della superbia e della cupidigia. In lui erano potentissimi gl'istinti, e non dominati dalla ragione. Ma la storia non dimenticherà che Martino Alonzo Pinzon, in un felice momento, udì le voci del suo buon genio, che lo chiamava ad una nobile impresa, avversata dagli invidiosi, non approvata dai dotti. Fu egli il primo marinaio di Spagna che si persuase della verità e della grandezza delle idee di Cristoforo Colombo. Se egli non era, il povero Martino Alonzo, se egli non si persuadeva, se egli non dava l'esempio di avventurare la sua vita col navigatore Genovese, nessun marinaio di Palos, di Huelva, di Moguer, avrebbe osato prendere il mare per quella nobile impresa, ed ogni ordinanza reale sarebbe rimasta lettera morta. Quell'atto redime molti falli, e può farne dimenticare molti altri. E noi deponiamo un fiore sulla tomba del povero Martino Alonzo Pinzon.
Capitolo XIX.
Il commiato
Cristoforo Colombo avrebbe voluto recarsi a Barcellona con la sua caravella. E sarebbe stato, agli occhi della Corte di Spagna, un bel contrasto fra la importanza della scoperta e la povertà dei mezzi con cui la scoperta era stata fatta da lui. Ma la povera Nina imbarcava acqua da tutte le commessure, e bisognò rinunziare al disegno. L'almirante si recò dunque per terra a Siviglia, per aspettare colà gli ordini del re Ferdinando e della regina Isabella.
A Siviglia lo accompagnarono sette dei dieci naturali che egli aveva condotti da Guanahani e da Cuba. Uno era morto in viaggio; due erano infermi, e furono lasciati a Palos, affidati alle cure amorevoli di don Francisco Garcia. Ma l'almirante volle con sè tutti i suoi ufficiali e tutti i marinai che avevano partecipato ai rischi e alla gloria dell'impresa, così quelli della Pinta e della distrutta Santa Maria, come quelli della Nina, diventata la nave capitana.
Dei marinai che lo seguivano, due mutarono spoglie, appena giunti a Siviglia. Erano i due genovesi, Cosma e Damiano, che apparvero alla presenza del signor almirante in veste da gentiluomini. La cosa non doveva parer strana a nessuno. Tutta la marinaresca sapeva da un pezzo che quei due erano marinai per celia; sebbene, lavorando e faticando come gli altri, non avessero fatto niente per celia.
L'almirante era da pochi giorni nella capitale dell'Andalusia, quando ricevette la lettera dei sovrani, che lo pregavano di dare immediatamente, a Siviglia, o dove gli piacesse meglio, gli ordini necessari ad affrettare la sua partenza per un nuovo viaggio, informandoli a volta di corriere di ciò che avessero a fare dal canto loro, per agevolare gli apparecchi. S'intende che lo invitarono anche a recarsi alla Corte, in Barcellona; ma questo era il meno. E certamente a Cristoforo Colombo doveva piacere, assai più del cortese invito, la fretta con cui Ferdinando e Isabella miravano ad assicurarsi la conquista di un nuovo impero di là dall'Atlantico; una conquista che per tanti anni si erano peritati d'intraprendere.
Il ricapito della lettera regia era questo: «A Don Cristoval Colon, nostro almirante sul mare Oceano, vicerè e governatore delle isole scoperte nelle Indie». Anche questi titoli, come erano stati lesinati, un anno addietro! Per la insistenza di Cristoforo Colombo a domandarli, era pericolata all'ultimo momento la spedizione. Tempi mutati! Ma il marinaio genovese non serbava rancori nell'anima, e ad altro non pensò che ad eseguire i comandi delle Loro Altezze, inviando a volta di corriere, come chiedevano, una minuta descrizione delle navi, degli uomini e delle munizioni necessarie al suo secondo viaggio.
Dopo di che, si pose in cammino per andare a Barcellona. La via non era lunga; ma dovevano renderla lunghissima le numerose fermate, di cui egli non poteva passarsi, essendo costretto a traversare molte delle più belle e popolose città della Spagna.
Il suo viaggio parve la marcia trionfale di un conquistatore. Ovunque egli passava vedeva affollarsi la gente dei luoghi circonvicini, che fiancheggiava le strade maestre ed ingombrava borghi e villaggi. Nelle grandi città, le vie, le finestre, i terrazzini, i tetti, brulicavano di spettatori curiosi che facevano suonar l'aria dei più lieti clamori. Ad ogni tratto era fermato dalla calca, che voleva veder lui da vicino, per imprimersi bene i suoi lineamenti negli occhi. Con molta maraviglia erano anche osservati gl'Indiani, che veramente erano facce dell'altro mondo, e parevano piovuti in terra da qualche pianeta.
Così trattenuto ad ogni punto, obbligato a passare un giorno nei luoghi più importanti, a passare almeno qualche ora nei luoghi più piccoli, affinchè fosse appagata la curiosità di tutti, l'almirante non giunse a Barcellona che il 14 di aprile. Colà tutti gli apparecchi erano fatti per accoglierlo con solennità e magnificenza. Ad una certa distanza dalla città, gli mosse incontro una splendida cavalcata di gentiluomini, con gran moltitudine di popolo, per fargli onoranza.
Il suo ingresso nella nobile capitale della Catalogna fu paragonato al trionfo che solevano concedere gli antichi Romani ai loro consoli vittoriosi. Andavano primi gli Indiani dipinti d'ocra a vari colori, secondo la foggia del loro paese, adorni di armille alle braccia, di piastrelle e di cerchietti d'oro alle nari. Dopo di questi, che camminavano portando i loro archi, le loro frecce e le loro zagaglie, venivano i marinai, portatori dei pappagalli vivi, dalle molte varietà e dai più lieti colori, delle piante rare, e sopratutto dell'oro in polvere, o in masse più o meno vistose. Giungeva ultimo l'almirante a cavallo, accompagnato dai suoi ufficiali, e seguito da quella splendida cavalcata di gentiluomini, che era venuta ad incontrarlo.
La calca era così fitta, che spesso era impossibile di farsi largo per via. Le dame sventolavano i fazzoletti dalle finestre e dai terrazzini; dai tetti al basso della strada era un agitarsi di teste, un levarsi di grida festose. Sembrava che il popolo non potesse saziarsi di contemplare i trofei di un Nuovo Mondo, e l'uomo maraviglioso che aveva saputo indovinarlo, che aveva potuto scoprirlo.
Per accoglierlo con maggior pompa, Ferdinando e Isabella avevano ordinato che il loro trono fosse incalzato in una gran loggia aperta, accessibile al maggior numero di persone, sotto un ricco baldacchino di broccato d'oro. Ivi il re e la regina attendevano l'arrivo dell'eroe; vicino ad essi stava il principe Giovanni; tutto intorno gli uffiziali della corona e la prima nobiltà di Castiglia, di Valenza, di Catalogna e d'Aragona.
Cristoforo Colombo entrò nella sala, accompagnato dai suoi ufficiali, in mezzo ai quali si distingueva egli per l'alta statura, la nobiltà del portamento e il raggio di viva allegrezza che gli sfavillava dagli occhi. Superbo non era, in quell'ora; e avrebbe potuto esserlo, vedendosi davanti la più parte di coloro che più fieramente avevano avversati i suoi disegni, negata la sua dottrina, disprezzata la sua persona e calunniate le sue intenzioni! Non era superbo; ma poteva farlo apparir tale la solennità del momento, e quel suo ritorno di trionfatore, da una impresa che era seguita punto per punto quale egli l'aveva immaginata e proposta.
Del resto, il legittimo orgoglio che poteva dipingersi nel suo viso radiante d'allegrezza, era ancora un giusto omaggio a coloro che in lui avevano creduto, a coloro che lo avevano consolato e confortato nei più tristi momenti della sua vita, nei giorni troppo lunghi e troppo frequenti delle sue amarezze. Certo, non vedeva di mal occhio quell'aria di onesta alterezza la regina Isabella, che tanto si era adoperata per appagare i voti del navigatore Genovese; di quella alterezza doveva compiacersi, come di propria vittoria, quella nobile dama che stava in piedi accanto allo scanno della regina, la marchesa di Moya, Beatrice di Bovadilla.
Qual turbamento, e come dolce, in quel cuore di donna! Ci sono le gioie che opprimono, tanto sono violente; pure, chi vorrebbe rinunziarci? A buon conto, non voleva rinunziarci la nobile signora, che aveva aspettato quel giorno e quel turbamento profondo, come il premio di tutte le sue fatiche, come il compenso di tutte le sue ansietà, di tutti i suoi terrori, di tutti i suoi scoramenti.
Comprimendo a stento i battiti del suo cuore, Beatrice di Bovadilla guardava davanti a sè. Non aveva da muoversi, non aveva da voltare la faccia; l'argomento di tutte le sue cure doveva giunger là, in quel breve spazio, rimasto vuoto per lui. E quell'uomo era giunto, quello spazio era finalmente ripieno, della persona, della luce, della gloria di lui. In mezzo a quella gran folla di dame e di cavalieri, nessuno badava a lei, in quel punto; neanche don Francisco di Bovadilla, il suo scontroso e sdegnoso fratello; neanche don Fernando Talavera, il burbanzoso ed ignorante vescovo di Granata; neanche don Giovanni Cabrera, marchese di Moya, suo signore e padrone. Tutti gli sguardi, come tutti i pensieri, erano rivolti al trionfatore; la curiosità, la commozione, e tutti gli ardori che può comunicare in certi momenti una moltitudine giubilante al cuor più ribelle, usurpavano il campo ad ogni altro sentimento. I vigilatori sospettosi di Beatrice Bovadilla, perfino i suoi molestissimi innamorati, le davano tregua per quell'ora di animazione straordinaria, di commozione solenne. Ella era dimenticata, come perduta, in quella folla che aspettava un uomo, che lo sentiva avvicinare, che lo vedeva presente. Qual gioia, poterlo guardare liberamente anche lei! poter cercare con avida cura su quel volto la traccia dei pericoli corsi, degli stenti patiti, e in quegli occhi la visione dei grandi segreti strappati all'Oceano! Perchè egli era partito con tre navi, ed era ritornato con una, con la minore delle tre, portando sovr'essa la sua fortuna, la sua gloria. Egli trionfava, finalmente; ma era anche un po' lei la vincitrice di quella guerra, e sentiva di trionfare con lui.
Nessuno guardava Beatrice di Bovadilla, di tanti gentiluomini che si affollavano intorno ai gradini del trono. Ma quell'uomo, su cui si fissavano gli occhi di tutti, dove volgeva egli i suoi? Si era avanzato fino ai gradini del trono; il re e la regina si erano alzati per riceverlo; ed egli, prendendo rispettosamente le destre di Ferdinando e d'Isabella, si era inginocchiato per baciar quelle destre. Lo avevano amorevolmente rialzato, pregandolo di voler sedere davanti a loro, sopra uno scanno che due valletti si erano affrettati a mettere innanzi. Ma egli, prima di sedere, aveva fatto il gesto di chi vuol guardare intorno, come per raccapezzarsi, in una compagnia che veda la prima volta. Pure, non aveva girato molto con gli occhi; il suo sguardo era andato diritto al fianco della regina, si era incontrato nello sguardo di Beatrice Bovadilla, e sul volto di lui era corsa una vampa. Ah, bene facevano tutti, non guardando che lui; meglio aveva fatto egli, non cercando altro sguardo che quello di lei.
– Don Cristoval, nostro amico, voi state bene? Vi siete rimesso di tante fatiche? – diceva la regina Isabella. – Abbiamo palpitato di profonda ansietà, leggendo nella vostra lettera il racconto di ciò che avete sofferto nel ritorno dal vostro maraviglioso viaggio. Ma ora siete con noi, e ci sentiamo più tranquilli. Vorrete voi raccontarci di tutte le grandi cose che avete operate?
– Con l'aiuto di Dio e sotto il padronato delle Vostre Altezze, – rispose Cristoforo Colombo, – l'impresa non poteva sortire un esito migliora. Umile istrumento della provvidenza celeste, io la ringrazio ogni giorno di avere inspirato ai Sovrani di Castiglia tanta benevolenza per me. —
Benevolenza un po' tarda, non è vero? e sopra tutto, ben misera negli effetti! Ma il navigatore Genovese era sincero, ringraziando i reali di Castiglia di quanto avevano fatto per lui. Chi pensa alle difficoltà, agli indugi, ai contrasti, quando l'impresa è compiuta e il trionfo l'ha coronata?
Cristoforo Colombo, per obbedire al desiderio della regina, incominciò a raccontare il suo viaggio. Era facondo, come sappiamo, ed anche spesso eloquente, di una eloquenza che toccava in certi punti il sublime, nella sua stessa semplicità. Quella volta, poi, doveva riuscire più eloquente d'Iperide, usando a più nobile fine un famoso argomento dell'oratore ateniese. Egli, infatti, poteva presentare i documenti della sua gloria, in quelle sette creature umane, tanto diverse da ogni specie conosciuta, alle quali, oltre il rosso colore della pelle, dava tant'aria di novità lo strano costume di tingersi il corpo, segnandolo di svariate figure, e quell'altro, non meno strano, di portare al sommo della nuca quei ciuffi di penne dai vivaci colori.
E non era men bello vedere quei selvaggi sgranar tanto d'occhi, per contemplare quella società europea, tutta coperta di seta, di broccato e di trine. I cortigiani di Castiglia godevano, senza darsene ragione, di quel naturale contrasto fra due razze, una delle quali, ignota fino a quei giorni, e padrona di sè, doveva cadere in servitù dell'altra, e a mala pena conosciuta, e a mala pena assoggettata, sparire dalla faccia della terra. Poveri selvaggi del Nuovo Mondo! Ignorando la loro sorte, contemplavano attoniti la grandezza, la maestà dei reali di Spagna, offrendo loro nei canestri di vimini, intessuti con la loro arte bambina, la polvere d'oro che doveva destare tante cupidigie, ed esser cagione di tanti delitti all'uomo civile.
Della attenzione con cui tutta la Corte era stata ad udire il racconto, non occorre parlare. Erano così nuove le cose che diceva l'almirante del mare Oceano; e ciò che tutti vedevano riusciva a così vivo commento delle parole sue, che due ore trascorsero senza che alcuno di tanti ascoltatori se ne fosse avveduto. Pure, egli non aveva raccontato che sommariamente. Ma tutti si ripromettevano di udirlo ancora, e di avere da lui in tutti i più minuti particolari ciò che per sommi capi era stato esposto, quasi a sfiorare il tema, ad acquetare la prima sete, ma senza spegnerla ancora.
Com'ebbe finito di raccontare, Cristoforo Colombo presentò ad uno ad uno i suoi compagni di viaggio. Isabella e Ferdinando ebbero una cortese parola per tutti.
Quando venne la volta dei due amici, che sappiamo, Cristoforo Colombo non potè dire, naturalmente, che due nomi di battesimo, e per giunta non i veri ed autentici.
– Cosma e Damiano, – diss'egli, – miei concittadini; due nobili genovesi, che hanno voluto venire con me, nell'umil veste di semplici marinai. —
Ferdinando salutò graziosamente con un cenno del capo e con un sorriso i due marinai gentiluomini.
– Nobili uomini, – rispose egli, – e più nobili cuori! Qui troveranno in buon punto due loro illustri concittadini, a noi inviati per ambasciatori della eccelsa Repubblica di Genova. Signori, – soggiunse, volgendosi a due gravi personaggi che erano sulla sua destra, – vogliate riconoscere ad abbracciare i vostri concittadini, che si son fatti compagni di fatiche, di pericoli e di gloria del nostro grande almirante e vicerè, don Cristoval Colon. —
I due personaggi uscirono dalle prime file. Erano essi messer Francesco Marchesio, legista, e Giovanni Antonio Grimaldo, ambasciatori mandati da Genova alla Corte di Castiglia, per negoziare un trattato di pace e di alleanza fra i due Governi.
Il Grimaldo riconobbe Cosma alla bella prima, e già aveva incominciato a dirgli:
– Siete voi, messer Gia… —
Ma un'occhiata di Cosma gli mozzò in bocca il nome che egli stava per proferire.
– Siamo Cosma e Damiano, qui; – soggiunse Cosma, a guisa di commento, e parlando il vernacolo di casa; – due amici, due fratelli, come i santi di cui abbiamo assunti i nomi. Le nostre famiglie non sono d'accordo laggiù; ma voi non vi maravigliate, messer Giovanni Antonio, se noi due ci ritroviamo amicissimi qui. Siamo fuori di casa; e fuori di casa possiamo anche incontrarci volentieri con gli ambasciatori del doge Adorno.
– Una bella gloria per voi, messeri, di aver partecipato a questo miracoloso viaggio! – disse Francesco Marchesio, cercando di sviare il discorso dalle cose di Stato.
– E per il nostro insigne concittadino Colombo d'averlo ideato e compiuto; – aggiunse Damiano. – Vedete intanto, messeri? Gli hanno già smozzicato il cognome. E questo mi pare il primo rimprovero alle nostre discordie, le quali non hanno consentita la gloria di scoprire il Nuovo Mondo ai figli di quei Genovesi che avevano pure scoperte le isole Canarie, quelle degli Astori, del Legname e del Capo Verde.
– Di chi la colpa? – mormorò Giovanni Antonio Grimaldo.
– Non vostra, messere, nè del vostro onorando compagno; nè la nostra, a buon conto; – replicò Damiano. – Ad un per uno, siamo tutti innocenti; ma posti a mazzo…
– È vero; non dite di più! – interruppe il Grimaldo. – Ma qui, fuori di casa, tutti amici, non è vero messer Bar…
– Damiano, per ora, e felicissimo al pari di Cosma, di aver salutati due valentuomini della nostra cara Genova. —
Le presentazioni erano finite, e il re Ferdinando aveva fatto un cenno. A quel cenno risposero dall'alto i gravi accordi di un organo. La regina, il re, le dame e i gentiluomini della Corte s'inginocchiarono. I cantori della cappella reale intuonarono il Tedeum, e ad essi fecero eco le voci di tutta quella gente adunata. Il maraviglioso inno Ambrosiano, vera elevazione delle anime a Dio creatore, a Dio consolatore, a Dio datore d'ogni bene, non fu mai cantato con tanta pienezza di gratitudine, con tanta commozione di cuore. Le lagrime corsero più volte agli occhi della regina; di lagrime, per tutto il tempo che durò la modulata preghiera, si mostrarono rigate le guance del navigatore Genovese.
Finito il canto si levarono tutti, e incominciò la sfilata. Accompagnati dal vicerè delle isole scoperte, dal grande almirante del mare Oceano, Ferdinando ed Isabella si avviarono al palazzo reale, in mezzo ad una moltitudine acclamante.
In più ristretti colloqui il grand'uomo raccontò partitamente ai reali di Castiglia la fatte scoperte. E allora gli toccò di ricevere le congratulazioni, le lodi, le strette di mano di tutti i più eminenti personaggi. Molto egli gradì l'abbraccio di don Pedro di Mendoza, cardinale e primate di Spagna, che era stato il più autorevole dei suoi difensori al tempo del consiglio di Salamanca. Ma egli non potè reprimere un atto di stupore, vedendosi prendere tanto amorevolmente per tutt'e due le mani da don Fernando Talavera, vescovo di Granata, confessore della regina, e già presidente di quel famoso consiglio in cui l'ignoranza aveva fatta una delle sue più solenni comparse.
– Figliuol mio! – gli diceva il Talavera, con una voce chioccia che voleva parer soffocata dalle lagrime della consolazione. – Figliuol mio dilettissimo, è una grande contentezza per me, di potervi abbracciare! Che uomo, signori! – soggiungeva, voltandosi a guardare intorno; e non lasciando tuttavia sfuggire le mani del figliuolo suo dilettissimo. – Che uomo! Lo avevo sempre detto, io, che un grande onore ci sarebbe venuto da lui. Lumen veniet e coelo et hoc lumine implebitur terra. Che uomo! che uomo! Don Cristoval, voi dovete andar superbo dell'opera, vostra. E noi dobbiamo andar superbi di avervi conosciuto, di avervi indovinato.
– Questo io non dimenticherò mai, – disse Cristoforo Colombo, inchinandosi.
E liberatosi finalmente dalle strette del vescovo di Granata, si volse a don Alonzo Quintanilla e a don Luigi Santangel, che aspettavano la volta loro. Questi, poi, li abbracciò, e li baciò con effusione di cuore.
– A voi, consolatori, a voi confortatori miei nei tristi giorni d'abbattimento, io ho pensato ogni giorno, come a don Juan Perez Marcena, il degno guardiano della Rabida, e al fisico Francisco Garcia; – disse l'almirante, non curandosi più del Talavera, che ancora non si era allontanato di là, – Siete stati voi, buoni amici, i miei quattro punti cardinali; da ognuno di voi, se è lecita a cuori allegri una celia, – soggiunse egli ridendo, – vorrei intitolata una delle quattro parti del mondo.
– Ma per opera vostra, don Cristoval, son diventate cinque; – rispose il Santangel. – Mi è parso di capire dal vostro racconto che le isole occidentali son molte, e che non sia il caso di regalarle all'Asia.
– È un dubbio, questo, che altri viaggi risolveranno; – replicò l'almirante. – Ma se una quinta parte sarà, non dubitate, troveremo da cui intitolarla.
– Saranno tanti oramai quelli che vi hanno protetto! – esclamò il Quintanilla, – che vi troverete molto impacciato a ringraziarli tutti. —
Così dicendo, l'ottimo don Alonzo non potè trattenersi dal volgere un'occhiata al vescovo di Granata; il quale, scuotendo la testa nella sua pappagorgia, rotando gli occhietti astuti e succhiandosi le labbra, si tirò gravemente in disparte.
Più dignitoso a gran pezza si mostrò don Francisco di Bovadilla, il fiero commendatore di Calatrava. Non isfuggì il suo nemico, non negò il saluto riverente al fortunato uomo, che i suoi sovrani festeggiavano, che tutta la sua nazione acclamava; ma altro non fece, non mentì con le labbra una allegrezza, una amicizia, che non aveva nel cuore.
Fu molto cortese don Giovanni Cabrera, il marchese di Moya. Il vecchio cavaliere, dopo tutto, non aveva che da inchinarsi in quella stessa guisa che tutti gli altri avevano fatto al nuovo astro sorgente; da buon cortigiano, non aveva che da seguire l'esempio dei suoi eccelsi padroni. Aggiungete che la nube occorsa tra lui e don Cristoval, o piuttosto tra lui e la sua nobile compagna, era stata così lieve! Si poteva dir quasi che niente fosse avvenuto. Se poi era avvenuto qualche cosa, quel poco era stato facilmente dimenticato.
Per tanto, non fu difficile a don Cristoval di vedere la marchesa di Moya, in privato colloquio. Quel colloquio, nessuno dei due poteva cercarlo, nessuno dei due poteva fuggirlo: era naturale che se ne offrisse l'occasione; era naturale che ambedue l'accettassero.
Pure, non era il colloquio più naturale del mondo. Chi ci ha seguiti nella prima parte di queste istorie, facilmente lo immagina. Donna Beatrice aveva veduto giungere quel momento solenne; non aveva fatto nulla per affrettarlo; e là, davanti a quell'uomo, era rimasta come inchiodata al pavimento, guardandolo senza vederlo, rispondendo al suo inchino con un cenno del capo, e con un moto delle labbra, a cui non rispondeva alcun suono di voce. Gli sorrideva, intanto, gli sorrideva placidamente, come a persona amica, da cui si fosse separata a mala pena il giorno prima. E tanto tempo era passato! tante cose erano avvenute, dopo il loro ultimo colloquio! e del dramma dei loro cuori così poca parte era stata confidata alle labbra!
Don Cristoval doveva fare tutta la strada che intercedeva fra lui e Beatrice di Bovadilla. L'obbligo era tutto del cavaliere; e da buon cavaliere, don Cristoval si avvicinò alla bella marchesa di Moya.
– Signora… – incominciò, ma senza andare più oltre.
Era, lo sapete, tutto ciò ch'egli sapesse dire, rivolgendo il discorso a donna Beatrice; tanto che un giorno la bella dama spazientita gli aveva risposto: «non sapete voi dirmi altro, don Cristoval?»
Ma per quella volta la bella dama non gli disse così; anzi, non gli disse nulla di nulla. Gli porse in quella vece la mano. E don Cristoval prese quella mano; la tenne a lungo tra le sue; poi, chinatosi divotamente, v'impresse un bacio anche più lungo della stretta.
Quello era il suo premio, e il buon cavaliere lo gustava intiero. Ed era anche il tributo della riconoscenza e dell'amor rispettoso per lei. Nè ella ritirò la sua mano, sebbene la sentisse ardere come per febbre violenta.
Ma quella scena muta non poteva durare eterna. Don Cristoval, facendo uno sforzo, aveva levata la fronte, guardando la sua protettrice. Davanti a quegli occhi aperti che la fissavano, Bovadilla socchiuse i suoi, e timidamente gli chiese:
– Avete pensato a me, qualche volta?
– Oh! – disse il buon cavaliere. – Più di qualche volta; ogni giorno; tutte le volte che m'era dato di rientrare col pensiero in me stesso. Ed anche, ve lo confesserò, mi accadeva di adirarmi con me, di ritrovarmi assai debole, di scacciare l'immagine…
– Importuna? – soggiunse Bovadilla.
– Non importuna, pericolosa: – rispose don Cristoval. – Voi foste il mio buon angelo, donna Beatrice, quando io disperavo di raggiungere l'intento. Là, sull'Oceano, eravate ancora la mia forza interiore. Ma voi lo intenderete; c'erano i momenti in cui la viltà degli uomini o la collera degli elementi richiedeva ogni mia cura; ed io allora dovevo temere che quella immagine, troppo… presente al mio spirito, non mi facesse dimentico degli obblighi miei. Perdonate, signora, voi che intendete sicuramente più che io non dica. Ma a voi pensavo, quando mi venne sui flutti il primo saluto delle terre sconosciute… un ramoscello di spino fiorito; e nel mio pensiero io l'ho dedicato a voi, come l'omaggio dovuto a colei che mi difese a viso aperto, alla nobile donna per il cui patrocinio costante fu possibile a me di tentare l'impresa. Eccolo, signora; – soggiunse don Cristoval, traendo da un piccolo astuccio di cordovano il ramoscello di spino; – era fiorito, quando io lo destinavo a voi. Oggi, il poveretto non ha più che le punte. Io spero tuttavia che non ferisca la nostra amicizia.
– Esso invece la suggellerà; – disse Bovadilla.
Così dicendo, Bovadilla accostò prontamente il ramoscello alla bocca. Si punse le labbra, come vi sarà facile immaginare; ma fu pronta anche a premervi su col suo fazzoletto di seta. E quel fazzoletto, tinto di alcune piccole gocce di sangue, porse tosto a don Cristoval.
– Prendete, – gli disse, – sia questo il pegno d'amicizia eterna fra noi. —
Seguì un lungo silenzio; l'ineffabile silenzio che accompagna le grandi gioie, come i grandi dolori. Noi lo rispetteremo, ben sapendo che ogni parola, comunque studiata e riguardosa, guasterebbe. Quando il vicerè delle isole dell'Oceano partì dalle stanze della marchesa di Moya, egli aveva gli occhi ancor bagnati di lagrime.
Quel giorno, ritirandosi nel suo appartamento, Cristoforo Colombo ebbe una pena, a cui del resto era già preparato. Cosma e Damiano, i suoi concittadini, i suoi compagni di stenti e di pericoli, venivano a prendere commiato da lui.
– Messere, – gli disse Damiano, – avete comandi da darci per Genova?
– Come? voi volete già andarvene?
– Sì, oggi stesso, se non vi dispiace. L'occasione è qui, l'afferriamo per il classico ciuffo. In altre parole, – soggiunse Damiano, – salpa di qui, nella notte, la Bella Maghellona, una galeotta genovese; io la sposo, e Cosma mi accompagnerà nel viaggio di nozze.
– Beato voi! sempre di buon umore; – disse l'almirante.
– Ma sì! perchè mi guasterei il sangue con le malinconie? – rispose Damiano. – Ho studiato tanto di medicina da intendere che non me lo aggiusterebbe più nessuna ricetta.
– E non ci rivedremo più, miei signori?
– Chi sa? – disse Cosma. – Non verrete voi mai a salutare la patria?
– La patria! – esclamò sospirando il navigatore Genovese. – Ora, la patria mia è quello spazio di mare che va dalla foce del Guadalquivir al porto del Natale. Lo scopritore è incatenato alle sue scoperte, come il Titano alla sua rupe.
– Con la giunta dell'avvoltoio; la grazia! – rispose Damiano. – E tuttavia, messere… Cosma vi ha detto: chi sa? Io vi rispondo: sicuramente. Ci rivedremo, messere. Vado a Genova e torno.
– Ah, bene! Faccio assegnamento su voi. Ma non saprò io per intanto chi siete voi due?
– È giusto; – disse Cosma. – Nell'atto di ringraziarvi, il meno che possiamo fare è di dirvelo. Giano di Campo Fregoso è il mio nome.
– E il mio, Bartolomeo Fiesco; – disse Damiano.
– Due nemici, una volta, e due rivali; – riprese Giano Fregoso; – ora due fratelli nella vostra gloria, a cui siamo orgogliosi di essere stati compagni.
– Bravi! e siate fratelli sempre; – rispose Cristoforo Colombo, dopo averli abbracciati. – E ciò sia per conforto di quella povera patria, a cui vi prego di portare il mio reverente saluto. Vedevo ieri gli ambasciatori di Genova non lieti, e mi pareva d'intenderne la cagione. Essi certamente pensavano che la bella impresa da cui eravamo tornati noi, si sarebbe potuta compiere con forze genovesi, se ai grifi di Genova non avessero tarpate le ali le sue maledette discordie. Ma io pensavo in pari tempo un'altra cosa, e più grave. A danno delle repubbliche Italiane i grandi Stati si vanno formando e fortificando in Europa. Oggi, neanche la nostra concordia basterebbe più a scongiurare quel danno. La nostra Repubblica non ha terra, alle spalle, e va perdendo l'imperio dei mari; intanto i suoi cittadini non pensano neanche a prepararle un glorioso tramonto. Questo, per Genova, è peggio del non aver favoriti essa i disegni di un suo figlio devoto. Come ci rialzeremo noi, Italiani, da questa miseria? e quando? Non è dato a noi di prevedere il tempo e le vie; perciò siamo tristi. Ma voi, amici, voi gentiluomini, non fate nulla che aggravi le tristezze e accresca i danni alla madre comune. Tristi morrete anche voi, ma senza rimorsi. Andate ora, nel nome di Dio, ricordate ed amate. —