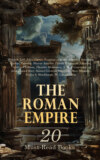Kitabı oku: «Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 8», sayfa 8
CAPITOLO XLIV
Idea della Giurisprudenza Romana. Leggi dei Re. Dodici Tavole dei Decemviri. Leggi del Popolo. Decreti del Senato. Editti dei Magistrati e degl'Imperatori. Autorità dei Giureconsulti. Codice, Pandette, Novelle, ed Instituta di Giustiniano: I. Diritto delle persone. II Diritto delle cose. III Ingiurie ed Azioni private. IV Delitti e Pene.
Stritolati nella polvere sono i varj titoli delle vittorie di Giustiniano: ma il nome del legislatore vive inscritto sopra un nobile e perpetuo monumento. Sotto il Regno e per cura di lui, la Giurisprudenza civile fu ordinata e raccolta nelle immortali opere del Codice, delle Pandette, e della Instituta196. La ragione pubblica dei Romani tacitamente o studiosamente si trasfuse nelle instituzioni domestiche dell'Europa197, e le leggi di Giustiniano tutt'or riscuotono il rispetto o l'obbedienza delle indipendenti nazioni. Ben saggio o fortunato è il Principe che collega la sua propria riputazione con l'onore e l'interesse di un ordine d'uomini destinato a perpetuarsi nella società. La difesa del fondatore è la prima causa che in ogni secolo ha esercitato lo zelo e l'industria dei Giureconsulti; piamente essi rammemorano le sue virtù; dissimulano, o negano i suoi falli, e rigorosamente puniscono il delitto o la demenza dei ribelli che ardiscono di macchiare la maestà della porpora. L'idolatria dell'amore ha provocato, come d'ordinario avviene, il rancore dell'opposizione; il carattere di Giustiniano è stato esposto alla cieca veemenza dell'adulazione e dell'invettiva, e l'ingiustizia di una setta (gli Anti-Triboniani) ha rifiutato ogni lode ed ogni merito al Principe, ai suoi ministri ed alle sue leggi198. Non attaccato ad alcuna parte, non interessato che alla verità ed al candore dell'istoria, e diretto dalle più moderate ed abili guide,199 io entro con giusta diffidenza nel soggetto della legge civile, che ha consumato tutta la vita di tanti eruditi, e tappezzato le pareti di tante spaziose biblioteche. In un solo, e se è possibile in un breve capitolo, io mi accingo a delineare la Giurisprudenza Romana, da Romolo sino a Giustiniano200, ad apprezzare il lavoro di questo Imperatore; poi mi farò a contemplare i principj di una scienza che tanto importa alla pace ed alla felicità del viver sociale. Le leggi di una nazione formano la parte più instruttiva della sua istoria, e, quantunque io mi sia dedicato a scrivere gli annali di una Monarchia nel suo declinare, di buon animo abbraccerò l'occasione di respirare la pura e fortificante aria della Repubblica.
Il Governo primitivo di Roma era composto, con qualche politica avvedutezza201 di un Re elettivo, di un Consiglio di nobili, e di una Assemblea generale del popolo. Il Magistrato supremo amministrava la guerra e la religione; egli solo proponeva le leggi, le quali venivano discusse nel Senato, e finalmente ratificate o rigettate da una pluralità di voci nelle trenta Curie o parrocchie della Città. Romolo, Numa, e Servio Tullio, vengono celebrati come i legislatori più antichi, e ciascuno di loro ha diritto alla sua parte nella triplice divisione della Giurisprudenza202. Le leggi del matrimonio, l'educazione dei figliuoli, e l'autorità paterna, che pajono trarre la loro origine dalla stessa natura, sono attribuite alla rozza sapienza di Romolo. Numa disse di aver ricevuto dalla Ninfa Egeria, nei notturni loro colloquj, le leggi delle nazioni e del Culto religioso che egli introdusse. All'esperienza di Servio si ascrivono le leggi civili: egli bilanciò i diritti e le fortune delle sette classi di Cittadini; ed assicurò, col mezzo di cinquanta nuovi regolamenti, l'osservanze dei contratti, e la punizione dei delitti. Lo Stato ch'egli avea piegato verso la democrazia, fu dall'ultimo Tarquinio trasformato in un dispotismo arbitrario, ed allorchè l'uffizio di Re fu abolito, i Patrizj presero per sè tutti i profitti della libertà. Odiose ed anticate divennero le leggi reali; i Sacerdoti ed i Nobili conservarono in silenzio il misterioso deposito, ed in capo a sessant'anni, i Cittadini di Roma ancora si lamentavano ch'erano retti dalla sentenza arbitraria dei Magistrati. Tuttavia le instituzioni positive dei Re si erano miste coi costumi pubblici e privati della città; si compilarono203 alcuni frammenti di quella veneranda giurisprudenza204, mediante la diligenza degli antiquarj, e più di venti testi parlano anche al presente la rozzezza dell'idioma Pelasgo dei Latini205.
Io non ripeterò la storia ben nota dei Decemviri206 i quali macchiarono colle loro azioni l'onore d'incidere sul rame, sul legno o sull'avorio le Dodici Tavole delle leggi Romane207. Dettate esse furono dal rigido e geloso spirito di un'aristocrazia, che con ripugnanza aveva ceduto alle giuste richieste del Popolo. Ma la sostanza delle Dodici Tavole si attagliava allo stato della Città; ed i Romani erano usciti dalla barbarie, poichè erano capaci di studiare e di adottare le instituzioni dei loro più colti vicini. Un savio cittadino di Efeso fu dall'invidia cacciato fuori dal suo nativo Paese. Innanzi che toccasse i lidi del Lazio, egli aveva osservato le varie forme della natura umana e della società civile. Egli compartì i suoi lumi ai legislatori di Roma, ed una statua fu innalzata nel Foro per immortalare la memoria di Ermodoro208. I nomi e le divisioni delle monete di rame, unico denaro coniato di Roma fanciulla, erano di origine dorica:209 le messi della Campania e della Sicilia provvedevano a' bisogni di un Popolo, l'agricoltura del quale era spesso interrotta dalla guerra e dalle fazioni, e poscia che stabilito fu il commercio210, i deputati che salpavano dal Tevere, potevano ritornare da quei porti con un carico più prezioso di sapienza politica. Le colonie della Magna Grecia aveano trasportato in Italia, e migliorato le arti della lor madre patria: Cuma e Reggio, Crotona e Taranto, Agrigento e Siracusa, erano nel numero delle più fiorenti città. I discepoli di Pitagora applicarono la filosofia all'uso del Governo; le leggi non scritte di Caronda si giovavano della Poesia e della Musica211, e Zaleuco stabilì la Repubblica dei Locresi, la quale durò senza alterazione per più di due secoli212. Fu un somigliante motivo di orgoglio nazionale che trasse Tito Livio e Dionisio a credere, che i deputati di Roma visitassero Atene al tempo della saggia e splendida amministrazione di Pericle, e che le leggi di Solone fossero trasfuse nelle Dodici Tavole. Se Atene avesse effettivamente ricevuto una tale ambasceria dai Barbari dell'Esperia, il nome Romano sarebbe stato familiare ai Greci prima del Regno di Alessandro213, e la curiosità dei tempi susseguenti avrebbe indagato e celebrato la più lieve testimonianza che fosse rimasta di un simil fatto. Ma taciono i monumenti Ateniesi, nè par credibile che i Patrizj si esponessero ad una lunga e pericolosa navigazione, per copiare il purissimo modello di una democrazia. Paragonando le Tavole di Solone con quelle dei Decemviri, si può scoprire qualche accidentale rassomiglianza: alcune regole che la natura e la ragione hanno rivelato ad ogni società; alcune prove di una comune discendenza dall'Egitto, o dalla Fenicia214. Ma in tutti i gran tratti della Giurisprudenza pubblica e privata, i Legislatori di Roma e di Atene compariscono stranieri o contrarj fra loro.
Qualunque esser possa l'origine od il merito delle Dodici Tavole,215 esse ottennero appresso i Romani quel cieco e parziale ossequio che i Legislatori di ogni paese sono desiderosi di compartire alle municipali loro instituzioni. Cicerone216 ne raccomanda lo studio, come piacevole ugualmente ed instruttivo. «Esse dilettano l'animo colla rimembranza di antichi vocaboli, e col ritratto di antichi costumi; esse inculcano i più sodi principj di Governo e di morale; ed io non temo di affermare che la breve composizione dei Decemviri supera il valore effettivo di tutti i libri della filosofia Greca. Quanto ammirabile», soggiunge Tullio, con onesto od affettato pregiudizio, «è mai la sapienza dei nostri antenati! Noi soli siamo i maestri della prudenza civile, e la nostra preminenza sempre più risplende se volgiamo lo sguardo alla rozza e quasi ridicola giurisprudenza di Dracone, di Solone, e di Licurgo». Le Dodici Tavole furono commesse alla memoria dei giovani ed alla meditazione dei vecchi, esse furono trascritte ed illustrate con dotta accuratezza; esse scamparono alle fiamme accese dai Galli; esse sussistevano al tempo di Giustiniano, e la successiva lor perdita venne imperfettamente restaurata dalle fatiche dei critici moderni.217 Ma benchè questi venerabili monumenti fossero considerati come la norma del diritto e la fonte della Giustizia,218 furono però soverchiati dal peso e dalla varietà delle nuove leggi, che, in capo a cinque secoli, divennero un male più intollerabile che i vizj della città.219 Il Campidoglio racchiudeva tremila tavole di bronzo, contenenti gli atti del Senato e del Popolo;220 ed alcuni di questi atti, come la Legge Giulia contro l'estorsione, comprendevano più di cento capitoli221. I Decemviri aveano trascurato di trapiantare in Roma quello Statuto di Zeleuco che per sì lungo tempo mantenne l'integrità della sua Repubblica. Un Locrese che proponeva una nuova legge, si doveva presentare all'Assemblea del Popolo con una corda al collo, e se rigettata era la legge, il novatore veniva strangolato immantinente.
I Decemviri erano stati nominati, e le loro Tavole approvate da un'Assemblea delle Centurie, nella quale le ricchezze preponderarono sopra il numero. La prima classe dei Romani, composta di quelli che possedevano centomila libbre di rame222 ottenne novantotto suffragj, e non ne rimasero che novantacinque per le sei classi inferiori, distribuite secondo le loro sostanze dalla politica artifiziosa di Servio. Ma i Tribuni ben presto stabilirono una massima più speciosa e popolare, cioè che ogni cittadino ha un egual diritto a stabilire le leggi a cui gli è forza obbedire. In luogo delle Centurie, essi convocarono le Tribù; ed i Patrizj, dopo un'impotente contesa, si sottoposero ai decreti di un'Assemblea, in cui i loro voti erano confusi con quelli degli infimi della Plebe. Non pertanto, sinchè le Tribù passarono successivamente sopra i piccoli ponti,223 e diedero il loro suffragio ad alta voce, la condotta di ogni Cittadino rimase esposta agli occhi ed agli orecchi de' suoi amici e compatriotti. Il debitore insolvente consultava il volere del suo creditore; il cliente avrebbe arrossito di opporsi alle mire del suo patrono; il Generale era seguito dai suoi Veterani, e l'aspetto di un grave Magistrato serviva di ammaestramento alla moltitudine. Un nuovo metodo di dar le voci in segreto abolì l'influenza del timore e della vergogna, dell'onore e dell'interesse, e l'abuso della libertà accelerò i progressi dell'anarchia e del dispotismo224. I Romani avevano ambito di essere eguali; essi furono posti a livello dall'uguaglianza della servitù; ed il formale consentimento delle Tribù o Centurie pazientemente ratificò i dettati di Augusto. Una volta, ed una volta sola, egli provò un'opposizione sincera e gagliarda. I suoi sudditi avevano ceduto tutta la libertà politica; essi difesero la libertà della vita domestica. Si rigettò con grandi clamori una legge che imponeva l'obbligazione e più stretti rendea i vincoli del matrimonio. Properzio, tra le braccia di Delia applaudiva alla vittoria dell'amor licenzioso; e il divisamento della riforma venne sospeso, finchè sorse al mondo una nuova e più trattabile generazione225. Non era necessario un tale esempio per mostrare ad un prudente usurpatore il pericolo delle Assemblee popolari; ed il loro abolimento, che Augusto aveva tacitamente preparato, si compì senza resistenza, e quasi senza che alcun ne parlasse, all'avvenimento del suo successore.226 Sessantamila legislatori plebei, formidabili pel numero, e fatti sicuri dalla povertà, furono soppiantati da sei cento Senatori che tenevano gli onori, le sostante e le vite loro dalla clemenza dell'Imperatore. Alleviata fu pel Senato la perdita del potere esecutivo mediante il dono dell'autorità legislativa, ed Ulpiano dietro la pratica di due secoli poteva asserire che i decreti del Senato avevano la forza e la validità delle leggi. Nei tempi di libertà, la passione o l'errore del momento aveva spesso dettato le risoluzioni del Popolo; la legge Cornelia, la Pompea, la Giulia, furono adattate da una sola mano ai disordini che prevalevano: ma il Senato, sotto il Regno dei Cesari, era composto di magistrati e di legisti, e di rado, nelle questioni di Giurisprudenza privata, il timore o l'interesse corrompevano l'integrità del loro giudizio227.
Al silenzio od all'ambiguità delle leggi si suppliva, sopraggiungendo l'occasione, cogli EDITTI di que' Magistrati ch'erano investiti degli onori dello Stato228. Questa antica prerogativa dei Re di Roma fu trasferita ai Consoli e Dittatori, ai Censori e Pretori nei rispettivi loro uffizi, ed i Tribuni del Popolo, gli Edili ed i Proconsoli si arrogarono un sì fatto diritto. In Roma e nelle province gli editti del Giudice supremo, il Pretore della città, facevano ogni anno conoscere i doveri dei sudditi e l'intenzione del Governatore, e riformavano la giurisprudenza civile. Tosto che saliva sul Tribunale, egli significava colla voce del banditore, e quindi faceva scrivere sopra un muro bianco, le norme a cui egli si prefiggea di attenersi nella decisione dei casi dubbii, ed il mitigamento che la sua equità poteva apportare al preciso rigore degli antichi statuti. S'introdusse nella Repubblica un principio di discrezione più conforme al genio della Monarchia: l'arte di rispettare il nome e di eludere l'efficacia delle leggi fu accresciuta dai successivi Pretori; s'inventarono sottigliezze e finzioni per travisare le più chiare intenzioni dei Decemviri, ed anche quando salutare era lo scopo, assurdi per lo più spesso erano i mezzi. Si permetteva che il segreto o probabile volere dei defunti prevalesse sopra l'ordine di successione e le forme dei testamenti; ed il pretendente, il quale era escluso dal carattere di erede, non accettava con minor piacere dalle mani di un indulgente Pretore il possesso dei beni del morto suo parente o benefattore. Nella riparazione dell'ingiurie private, si sostituirono compensi ed ammende all'obsoleto rigore delle Dodici Tavole; immaginarie supposizioni annientavano il tempo e lo spazio, e le ragioni della gioventù, della frode, o della violenza cassavano l'obbligo, o scusavano l'adempimento di uno sconveniente contratto. Una giurisdizione così vaga ed arbitraria era esposta ai più pericolosi abusi: la sostanza ugualmente che la forma della giustizia venivano spesso sacrificate ai pregiudizi della virtù, o all'obbliquo impulso di una lodevole affezione, ed alle più grossolane seduzioni dell'interesse o del risentimento. Ma gli errori od i vizj di ciascun Pretore spiravano insieme colle sue funzioni di un anno. I Giudici suoi successori non copiavano che quelle massime che avevano la conferma della ragione e dell'esperienza; la soluzione di nuovi casi definiva la norma di procedere, ed allontanate erano le tentazioni di operar l'ingiustizia dalla legge Cornelia, che costringea il Pretore dell'anno a seguire la lettera e lo spirito del primo suo bando229. Era serbato alla sollecitudine ed alla dottrina di Adriano l'ufficio di compiere il disegno concepito dal genio di Cesare; ed immortalata fu la pretura di Salvio Giuliano, eminente Giureconsulto, mediante la composizione dell'EDITTO PERPETUO. L'Imperatore ed il Senato ratificarono questo codice, saviamente meditato; riconciliossi alfine il lungo divorzio della legge e dell'equità; ed in luogo delle Dodici Tavole, si stabilì l'Editto Perpetuo qual invariabil norma della giurisprudenza civile230.
Da Augusto fino a Trajano, i modesti Cesari si contentarono di promulgare i loro editti ne' vari caratteri di un Magistrato romano; e ne' decreti del Senato s'inserivano rispettosamente le epistole e le orazioni del Principe. Pare che Adriano fosse il primo231 ad assumere, senza velo, la pienezza del potere legislativo. E questa innovazione, così grata all'attiva sua mente, fu favorita dalla pazienza de' tempi e dal lungo dimorar ch'egli fece lungi dalla sede del Governo. Si attennero all'istessa politica i susseguenti monarchi, e secondo la rozza metafora di Tertulliano, «la tenebrosa ed avviluppata selva delle leggi antiche fu dilucidata dalla scure de' mandati e delle costituzioni reali232». Per lo spazio di quattro secoli, da Adriano a Giustiniano, la giurisprudenza pubblica e privata venne foggiata a norma del voler del Sovrano; ed a poche instituzioni, sì divine che umane, si permise di rimanere sulle prische lor basi. L'origine della legislazione imperiale fu nascosta dalle tenebre de' tempi e dal terrore di un dispotismo armato; e si propagò una doppia finzione dalla servilità e forse dall'ignoranza de' legisti che si scaldavano al sole delle corti di Roma e di Bisanzio. I. A preghiera degli antichi Cesari, il Popolo od il Senato avea spesso conceduto loro un'esenzione personale dagli obblighi e dalle pene degli statuti particolari; ed ogni concessione era un atto di giurisdizione esercitato dalla repubblica verso il primo de' suoi cittadini. L'umile privilegio di costui venne finalmente trasformato nella prerogativa di un tiranno; e l'espressione latina di sciolto dalle leggi233 supponevasi che innalzasse l'Imperatore sopra tutti i raffrenamenti umani, e lasciasse la sua coscienza e ragione come la sacra misura della sua condotta. II. I decreti del Senato, che, ad ogni regno, determinavano i titoli ed i poteri di un Principe elettivo, significavano essi pure la dipendenza dei Cesari: nè fu se non dopo che le idee ed anche la lingua dei Romani erano state corrotte, che Ulpiano, o più probabilmente Triboniano stesso234 immaginò e la legge Reale235, ed una concessione irrevocabile per parte del Popolo. Allora i principj di libertà e di giustizia servirono a sostenere l'origine del potere Imperiale, quantunque falsa nel fatto, e fonte di schiavitù nelle sue conseguenze. «Il piacere dell'Imperatore, dicevano, ha il vigore e l'effetto di legge, poichè il Popolo Romano, mediante la legge Reale, ha trasferito ne' suoi Principi la piena estensione del suo potere e della sua sovranità236». Si permise che il volere di un solo uomo, di un fanciullo forse, prevalesse sopra la sapienza dei secoli, e i desiderj di milioni di uomini; ed i Greci degenerati si recarono a gloria di dichiarare che nelle sole mani del Principe si poteva sicuramente depositare l'esercizio arbitrario della legislazione. «Qual interesse o passione», esclamava Teofilo nella corte di Giustiniano, «può toccare il Monarca nella tranquilla e sublime altezza in cui siede? Egli è già signore delle vite e delle sostanze de' suoi sudditi; e coloro che gli sono caduti in disgrazia, sono già noverati tra gli estinti237». Tenendo a vile il linguaggio dell'adulazione, lo storico dee confessare che, nelle questioni di giurisprudenza privata, il Sovrano assoluto di un grande Impero può di rado esser mosso da alcuna considerazione personale. La virtù, od anzi la ragione suggerirà all'imparziale sua mente, che egli è il custode della pace e dell'equità, e che l'interesse della società inseparabilmente è vincolato col suo. Nel Regno più debole e più vizioso, la sede della giustizia fu occupata dal senno e dall'integrità di Papiniano e di Ulpiano238; ed i nomi di Caracalla e de' suoi ministri stanno scritti in fronte ai più puri materiali del Codice e delle Pandette239. Il Tiranno di Roma era alle volte il benefattore delle province. Un pugnale pose fine ai misfatti di Domiziano; ma la prudenza di Nerva confermò gli atti di lui, che un Senato, commosso da sdegno, avea cassato nel giubilo della sua liberazione.240 Non pertanto nei rescritti241 ossia risposte ai consulti dei Magistrati il più savio dei Principi potea venir tratto in errore da un'esposizione parziale del caso. È questo abuso il quale metteva le frettolose lor decisioni al livello de' maturi e deliberati atti della legislazione, fu senza frutto condannato dal buon senso e dall'esempio di Trajano. I rescritti dell'Imperatore, le sue concessioni, i suoi decreti, i suoi editti e le sue prammatiche sanzioni, erano sottoscritti con inchiostro purpureo242, e trasmessi alle Province come leggi generali o speciali, che i Magistrati dovevano eseguire, ed a cui il popolo doveva obbedire. Ma siccome il lor numero di continuo si moltiplicava, la regola dell'obbedienza divenne ogni giorno più dubbia ed oscura, sintanto che il Codice Gregoriano, quello di Ermogene e quel di Teodosio determinarono ed asserirono la volontà del Sovrano. I due primi, de' quali salvaronsi pochi frammenti, furono composti da due Giureconsulti privati, ad oggetto di conservare le costituzioni degli Imperatori Pagani, da Adriano sino a Costantino. Il terzo, che ci rimane intero, fu compilato in sedici libri per ordine di Teodosio il Giovine, onde consacrare le leggi dei Principi Cristiani, da Costantino fino al proprio suo Regno. Ma i tre Codici ottennero un'eguale autorità ne' Tribunali; ed il Giudice potea tenere in conto di spurio243 o andato in disuso ogni atto che non si racchiudesse in quel sacro deposito.
Fra le nazioni selvagge, si supplisce imperfettamente alla mancanza delle lettere coll'uso di segni visibili, i quali destano l'attenzione, e perpetuano la rimembranza di ogni transazione pubblica o privata. La giurisprudenza dei primi Romani presentava le scene di un pantomimo; le parole erano adattate ai gesti, ed il più lieve errore, la più tenue negligenza nelle forme della procedura, era sufficiente per annullare la sostanza dei più fondati diritti. La comunione del matrimonio si denotava col fuoco e coll'acqua, elementi necessarj della vita244: e la moglie ripudiata restituiva il mazzo delle chiavi, mediante la consegna delle quali era stata investita del governo della famiglia. La manumissione di un figlio o di uno schiavo si faceva col percuoterlo leggermente in volto: si proibiva un'opera col gettarvi sopra una pietra; s'interrompeva la prescrizione, col rompere un ramoscello. Il pugno chiuso era il simbolo di un pegno o di un deposito; si presentava la mano destra per impegnar la parola o mostrare la confidenza. Si spezzava un fil di paglia per indicare ch'era stabilito un contratto. S'introducevano i pesi e le bilance in ogni pagamento, e l'erede che accettava un testamento era alle volte obbligato di scoppiettar colle dita, di gettar via gli abiti, e di saltare e ballare con reale ed affettata allegrezza245. Se un cittadino reclamava nella casa di un vicino qualche effetto rubatogli, egli nascondea la sua nudità con un pezzo di tela di lino, e si copriva il volto con una maschera o con un bacino per timore d'incontrar gli occhi di una vergine o di una Matrona246. In un'azione civile, il querelante toccava l'orecchio del suo testimonio, afferrava per la gola il suo riluttante avversario, ed implorava, con solenni lamenti, l'ajuto de' suoi Concittadini. I due competitori si abbrancavan per le mani, come se fossero pronti a combattere innanzi al Tribunal del Pretore: egli ordinava loro di produrre l'oggetto del litigio; essi discostavansi, poi ritornavano con passi misurati, e gettavano a' suoi piedi una zolla, per rappresentare il Campo che si contendevano. Questa occulta scienza delle parole e delle azioni della legge, era il retaggio dei Pontefici e dei Patrizj. Non diversamente dagli Astrologi Caldei, essi annunciavano ai loro clienti i giorni d'operare e quelli di riposare; queste importanti bagattelle erano intrecciate colla religione di Numa, ed anche dopo la pubblicazione delle Dodici Tavole, l'ignoranza delle forme giudiziarie continuò a tenere i Romani in una specie di servitù. Il tradimento di alcuni uffiziali plebei rivelò finalmente questi fruttuosi misterj: venne un secolo più illuminato che osservò le azioni legali, ridendosi di loro: e la stessa antichità che santificò la pratica, cancellò dalla memoria l'uso ed il significato di quella primitiva favella247.
Si coltivò nondimeno un'arte più liberale dai savj di Roma, i quali, in un senso più stretto, si possono riguardare come gli autori della legge civile. L'alterazione dell'idioma e de' costumi dei Romani rendè lo stile delle Dodici Tavole sempre meno famigliare ad ogni generazione novella, ed i passi dubbiosi imperfettamente furono schiariti dalle cure degli antiquarj legali. Più nobile ed importante studio era quello di definire le ambiguità delle leggi, di circoscriverne l'effetto, di applicarne i principj, di estenderne le conseguenze, di riconciliarne le contraddizioni apparenti o reali; e la provincia della legislazione fu tacitamente occupata dagli espositori degli antichi statuti. Le sottili loro interpretazioni concorsero con l'equità del Pretore, a riformare la tirannia delle più rozze età. Una giurisprudenza artificiale, ajutata da mezzi intricati e bizzarri, si applicò a far risorgere i semplici dettami della natura e della ragione, e l'abilità di molti cittadini privati utilmente adoperossi a sottominare le istituzioni pubbliche del loro paese. La rivoluzione di quasi mille anni, dalle Dodici Tavole sino al Regno di Giustiniano, può dividersi in tre periodi quasi eguali in durata, e distinti l'un dall'altro pel metodo d'instruzione, e pel carattere dei legisti248. L'orgoglio e l'ignoranza contribuirono, durante il primo periodo, a ristrignere dentro angusti confini la scienza della legge Romana. Nei giorni pubblici di mercato o di assemblea, si vedeano i maestri dell'arte passeggiar pel Foro, pronti a dare il necessario consiglio all'infimo dei loro concittadini, dal cui suffragio essi potevano ricercare il contraccambio della gratitudine, al porgersi dell'occasione. Quando cresciuti erano negli anni o negli onori, essi stavano in casa, assisi sopra una sedia od un trono, ad aspettare con paziente gravità le visite dei loro clienti, i quali, al romper del giorno, venivano in folla dalla città o dalla campagna ad assediarne le porte. I doveri della vita sociale, e gl'incidenti di una procedura giudiziale, formavano l'ordinario argomento di queste consultazioni, e l'opinione verbale o scritta dei giureconsulti era concepita secondo le regole della prudenza e della legge. Si permetteva di stare ascoltando ai giovani del loro ordine o della loro famiglia; i loro figliuoli godevano il benefizio di più private lezioni, e la famiglia Mucia fu rinomata gran tempo per l'ereditario conoscimento della legge civile. Il secondo periodo, la dotta e splendida età della giurisprudenza, si può estendere dalla nascita di Cicerone sino al Regno di Alessandro Severo. Si formò un sistema; s'instituirono scuole; si composero libri, e sì i vivi che i morti servirono all'ammaestramento dello studioso. Il Tripartito di Elio Peto, soprannominato il Cauto, ci pervenne come la più antica opera di giurisprudenza. Catone il Censore aggiunse qualche cosa alla sua fama, mercè de' suoi studi legali e di quelli di suo figlio. Tre uomini dotti in legge illustrarono il nome di Muzio Scevola. Ma la gloria di aver perfezionata la scienza fu attribuita a Servio Sulpizio, loro discepolo, ed amico di Tullio; e la lunga successione di Giureconsulti che con egual lustro fiorirono sotto la Repubblica e sotto i Cesari, vien finalmente chiusa dai rispettabili caratteri di Papiniano, di Paolo e di Ulpiano. I nomi loro, ed i titoli delle diverse loro opere, minutamente furono conservati, e l'esempio di Labeone può porgere qualche idea della diligenza e fecondità loro. Questo eminente Giurisperito del secolo di Augusto, spendea il suo anno, parte in città parte in campagna, tra il lavoro degli affari e quel del comporre, e si annoverano quattrocento libri, frutto dei solitari suoi studi. Si cita il libro duecento e cinquantanove della raccolta del suo rivale Capitone, e pochi Professori potevano esporre le loro opinioni in meno di un centinajo di volumi. Nel terzo periodo, tra i regni di Alessandro e di Giustiniano, quasi muti restarono gli oracoli della giurisprudenza. Appagata era la curiosità; il Trono occupato era da' Tiranni e da' Barbari; le disputazioni religiose traevano a sè gli spiriti attivi; ed i Professori di Roma, di Costantinopoli, e di Berito umilmente si contentavano di ripetere le lezioni dei loro più illuminati predecessori. Dai tardi avanzamenti e dalla rapida declinazione di questi studi legali, si può inferire che essi ricerchino uno stato di pace e di raffinamento sociale. Dalla moltitudine de' luminosi legulei che riempiono lo spazio di mezzo, si chiarisce che si può attendere a tali studi, e comporre somiglianti opere, con una dose comune di giudizio, di sperienza e d'industria. Il genio di Cicerone e di Virgilio più manifesto si fece a misura che ogni nuova età si mostrò incapace di produrne un simile od un secondo: ma i più eminenti maestri di giurisprudenza erano certi di lasciare discepoli, che gli uguaglierebbero o supererebbero in merito ed in celebrità.
Nel settimo secolo di Roma, l'alleanza della filosofia greca venne ad ingentilire e perfezionare la giurisprudenza che grossolanamente si era adattata ai bisogni dei primi Romani. Gli Scevola s'erano formati mediante l'uso e l'esperienza; ma Servio Sulpizio fu il primo legista che stabilisse l'arte sua sopra una teorica certa e generale249. Egli applicò, qual infallibil regola, la logica di Aristotile e degli Stoici, al discernimento del vero e del falso; ridusse a generali principj i casi particolari, e diffuse sopra la massa informe la luce dell'ordine e dell'eloquenza. Cicerone, suo contemporaneo ed amico, non cercò il nome di legulejo di professione; ma la giurisprudenza della sua patria trasse ornamento dal suo incomparabile ingegno che trasforma in oro ogni oggetto cui tocca. Seguendo l'esempio di Platone, egli compose una Repubblica, e ad uso della sua Repubblica compilò un trattato di leggi in cui si sforza di dedurre da celeste origine la sapienza e la giustizia della costituzione Romana. L'intero Universo, secondo la sublime sua ipotesi, forma un'immensa Repubblica: i Numi e gli uomini che partecipano della stessa essenza sono membri della stessa comunità; la ragione prescrive la legge della natura e delle nazioni, e tutte le instituzioni positive, quantunque modificate dall'accidente o dal costume, sono tratte dalla norma del retto, che la Divinità ha stampato in ogni animo virtuoso. Da questi misteri filosofici, dolcemente egli esclude gli Scettici, i quali ricusano di credere, e gli Epicurei, i quali non hanno volontà di operare. Questi ultimi disdegnano le cure della Repubblica; egli dà loro il consiglio di abbandonarsi al sonno negli ombrosi lor orti. Ma umilmente prega la nuova Accademia di tenere il silenzio, poichè le audaci obbiezioni di essa tosto distruggerebbero l'elegante e ben ordinata struttura del suo grande sistema250. Egli rappresenta Platone, Aristotele e Zenone come i soli maestri che armino ed ammaestrino un cittadino pei doveri della vita sociale. Si riconobbe poi che la più salda tempra di queste diverse armature era quella degli Stoici251; e le scuole di giurisprudenza sen valsero più che delle altre, sì per l'uso che per l'ornamento. I Giureconsulti romani impararono dal Portico a vivere, a ragionare ed a morire: ma succhiarono in parte i pregiudizi della setta, l'amore del paradosso, il pertinace abito del disputare, ed un minuto attaccamento alle parole, ed alle distinzioni verbali. S'introdusse la superiorità della forma sopra la materia per fondare il diritto di proprietà: e l'eguaglianza dei delitti viene sostentata da un'opinione di Trebazio252, il quale asserisce che chi tocca un orecchio, tocca tutto il corpo, e che chi ruba alcun che da un mucchio di grano o da una botte di vino, è colpevole dell'intero furto253.
Γης και θαλασσης σκηπρα και μοναρχιανΔαβοντες.Della terra e del mar gli scettri e il regnoPigliando. Predizione ardita avanti il fine della prima guerra punica.
Pomponio (De origine juris Pandect. l. 1 tit. 2) indica la successione de' giureconsulti romani; ed i moderni hanno fatto prova di sapere e di critica nella discussione di questa parte d'Istoria e di Letteratura. Io mi servii specialmente di Gravina (p. 41-79) e di Eineccio (Hist. J. R. n. 113, p. 351). Cicerone (De Oratore, de Claris orator., de Legibus) e la Clavis Ciceroniana d'Ernesti (sotto il nome di Mucio ecc.) offrono molte particolarità originali e piacevoli. Orazio fa spesso allusione alla laboriosa mattinata de' legisti (Serm. l. 1, 10; epist. 2, 1, 103 ec.).
Agricolam laudat juris legumque peritusSub galli cantum consultor ubi ostia pulsat.· · · · · · · · · · · ·Romae dulce diu fuit et solemne, reclusaMane domo vigilare, clienti promere jura.
[Закрыть]