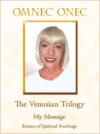Kitabı oku: «I figli dell'aria», sayfa 9
I LEOPARDI DELLO SCIAMO
Nonostante le parole rassicuranti del capitano, Rokoff tardò molto a chiudere gli occhi, parendogli sempre di udire le unghie dell’orso contro la parete esterna del fuso.
Non fu che dopo la mezzanotte, quando il vento cominciava a scemare di violenza che, si decise a spegnere il lume e ad abbandonarsi tra le braccia di Morfeo.
Tutta la notte però non sognò che battaglioni di orsi accampati intorno al fuso, per impedire agli aeronauti di uscire e di riprendere il volo.
Quando i primi albori cominciarono a diffondersi nell’interno delle cabine, passando attraverso le grosse lenti di cristallo incastrate sui fianchi del fuso, il capitano svegliò il russo e il cosacco, gridando:
– In piedi, signori; spero di potervi offrire per colazione un eccellente zampone d’orso, un boccone da re.
Si era armato di tre carabine Express armi di corta portata, non superando i quattrocento metri, preferibili a tutti gli altri fucili da caccia, perché le loro palle, vuote internamente, oltre a raggiungere una grande velocità, producono delle ferite terribili in causa della loro larga espansione.
Ne diede una a ciascuno, poi fece aprire il boccaporto e, dopo aver ascoltato qualche po’ salì sul ponte, girando all’intorno un rapido sguardo. L’orso non doveva più essere tornato. Gli strumenti, bussole, barometri e termometri sospesi alla balaustrata, occupavano ancora il medesimo posto di prima, mentre sarebbero stati per lo meno guastati dal plantigrado, nel superare la murata.
Solamente una cassa era stata rovesciata, probabilmente nella fuga precipitosa dell’animale.
– Non ha più osato arrampicarsi sul fuso, – disse il capitano – che sia stato ferito?
Si diresse verso prora e scorse sul ponte alcune gocce di sangue.
– L’avete colpito – disse volgendosi verso Rokoff. – Può essere già morto in mezzo a qualche macchia. Andiamo a cercarlo.
Discesero dal fuso e si avventurarono fra i cespugli che ingombravano la cima della collina.
Procedevano cauti, non essendo certi che quell’orso fosse stato solo, anzi Rokoff sospettava il contrario, avendo udito contemporaneamente raschiare la parete e il ponte.
A cinquanta metri dall’aerotreno s’alzava una fitta macchia di betulle, circondata da cespugli di noccioli selvatici. I tre aeronauti, supponendo che l’animale si fosse rifugiato là dentro, si diressero a quella volta, tenendo pronte le carabine, onde evitare qualunque sorpresa.
Avevano già superata mezza distanza, quando udirono improvvisamente il macchinista urlare:
– Aiuto, capitano! Aiuto!
– Per centomila orsi! – esclamò Rokoff, facendo un rapido voltafaccia. – Chi assale il nostro giovane?
Il macchinista, con un solo salto, si era precipitato giù dal fuso e correva a tutte gambe verso i cacciatori, cogli occhi strabuzzati dal terrore e i lineamenti sconvolti.
– Cos’hai? – chiese il capitano, muovendogli rapidamente incontro.
– Là!… là!… sul fuso… un animale!… – rispose il giovanotto, con voce strozzata. – Stava per balzarmi addosso!…
– Un animale sul nostro «Sparviero»! – esclamò il capitano.
– Hai sognato?
– No, signore… l’ho veduto… usciva di sotto la tenda che copre le casse di poppa
– Un orso? – chiese Rokoff.
– No… non era un orso… pareva una tigre.
– È impossibile! – esclamò il capitano.
– Vi dico invece che è possibile – disse Fedoro. – Non è raro trovarle anche nella Manciuria.
– La cosa diventa seria – rispose il capitano. – Preferirei affrontare una coppia d’orsi. L’hai veduta fuggire?
– Non so se sia rimasta sul ponte o se sia balzata fra i cespugli – rispose il macchinista. – Appena l’ho veduta comparire sono saltato a terra.
– Signori – disse il capitano, volgendosi verso il russo e il cosacco. – Siete bravi tiratori?
– Entrambi – rispose Fedoro.
– Non mancate ai vostri colpi; le tigri non hanno paura e si gettano coraggiosamente sui cacciatori.
– Le ho già conosciute in India – disse Fedoro.
– E io farò la loro conoscenza ora – aggiunse Rokoff.
– Dove si trovava nascosta? – chiese il capitano al macchinista.
– A poppa, signore.
– Attaccheremo dalla prora.
Tenendosi curvi per non farsi vedere dal sanguinario felino, si diressero lentamente verso l’aerotreno, seguiti a breve distanza dal macchinista, il quale si era armato d’un grosso ramo di pino che aveva trovato al suolo.
La tigre, (supposto che fosse veramente tale) non dava segno di vita. Era fuggita approfittando del terrore del macchinista o si teneva nascosta dietro alla macchina e alle casse, per poi piombare improvvisamente sui cacciatori?
– Pare che non sia troppo coraggiosa – disse Rokoff. – Che si sia accorta che noi siamo uomini capaci di levarle la pelle? Non riesco a vederla.
– Si terrà nascosta – rispose il capitano.
– La vigliacca! Saremo costretti ad andarla a prendere per la coda.
– Un’impresa che affiderò a voi solo, signor Rokoff.
– Se si ostinasse a non mostrarsi, bisognerà andarla a cercare.
– La snideremo egualmente prendendola alle spalle.
Erano giunti dinanzi alla prora del fuso, ma la tigre non si scorgeva sul ponte.
Il capitano fece il giro del tribordo per vedere se si trovava rannicchiata dietro la macchina.
– Nulla, – disse – deve essere fuggita.
– Peccato – rispose Rokoff. – Sarei stato contento di vederla balzare fuori.
– Sarà per un’altra volta – disse il capitano. – Saliamo.
– E l’orso? – chiese il cosacco, che voleva assolutamente affrontare qualche animale.
– Passeremo sopra le macchie e se lo vedremo scenderemo. Macchinista innalziamoci.
– Non domando che due minuti, signori.
Salirono sul fuso e si accertarono che il pericoloso animale non vi fosse più. Sotto la tela, però, trovarono alcuni fiocchi di pelo che non appartenevano certo a un orso.
– La briccona si era nascosta lì sotto – disse Rokoff. – Contava di fare colazione colle nostre bistecche.
Deposero i fucili a prora, appoggiandoli alla balaustrata e si radunarono a poppa per sorseggiare una eccellente tazza di tè, che il capitano aveva preparato servendosi d’una lampadina ad alcool.
Lo «Sparviero» intanto s’innalzava lentamente, descrivendo una specie di spirale, onde raggiungere i trecento metri.
– Adagio – disse al macchinista. – Cerchiamo di scoprire l’orso. Mi rincrescerebbe non mantenere la promessa.
– Quale, signore? – chiese Rokoff.
– Di offrirvi per colazione uno zampone squisitissimo. Aprirò per bene gli occhi. Le macchie non sono molto folte e, se è vero che l’orso è stato ferito, non deve essere andato molto lontano.
Lo «Sparviero», raggiunta l’altezza voluta, stava filando sopra i pini e gli aceri, quando Rokoff e il capitano videro il macchinista abbandonare precipitosamente la macchina.
– Che cosa c’è ancora? – chiese il comandante, stupito.
– Signore… – balbettò il giovane pallido come un morto. – La tigre è a bordo!…
– Ma tu vaneggi, giovanotto mio – disse Rokoff. – Tu hai una tigrite acuta indosso.
– Ho udito… un grido rauco… là… sotto il boccaporto…
– Per l’inferno! – esclamò il capitano, impallidendo. – Possibile!
Stava per slanciarsi a prora onde prendere le carabine, quando vide sorgere dal boccaporto una testa che lo fece retrocedere precipitosamente.
Un animale si era aggrappato al margine della botola e tentava di giungere sul ponte. Era una bestia superba che rassomigliava un po’ alle tigri, di corporatura massiccia, con zampe corte, la testa allungata col muso sporgente e il pelame grigio biancastro a riflessi giallastri, sparso di macchie nere di forma circolare.
Un animale pericoloso senza dubbio. Se non raggiungeva la mole delle grandi tigri reali, non la cedeva di certo, per grossezza, a quelle comuni. Pareva molto sorpreso e fors’anche spaventato di sentire il fuso ondulare. I suoi grandi occhi dalle pupille giallastre, manifestavano un vivo terrore e il suo pelame era irto.
– Un irbis! – aveva esclamato il capitano. – Un leopardo delle nevi! Badate! Vale una tigre!
– Per le steppe del Don! – gridò Rokoff. – E i fucili sono a prora!…
– Non muovetevi! – Comandò il capitano. – L’irbis potrebbe precipitare l’assalto.
II cosacco, invece di obbedire, fece due passi innanzi e s’impadronì rapidamente d’una specie d’arpione, che serviva al macchinista per tendere la seta dei piani inclinati.
– Almeno servirà a qualche cosa – disse, raggiungendo sollecitamente i compagni. – La punta è acuta e forerà la pelle della belva.
– Se potessimo abbassarci, l’irbis sarebbe ben contento d’andarsene – disse Fedoro. – Mi pare che sia più spaventato di noi.
– Bisognerebbe avvicinarsi alla macchina – rispose il capitano. – Chi oserebbe farlo?
– Volete che provi io? – chiese Rokoff.
– No, sarebbe troppo pericolosa una tale mossa.
– Volete continuare il viaggio con un simile compagno? Non oserei chiudere gli occhi.
– Come abbassarci? – chiese Fedoro. – Non v’è alcun mezzo, capitano?
– Nessuno se non rallentiamo la battuta delle ali – rispose il comandante. – Ah! Pare che si decida a sgombrare! Se si provasse a saltare!
– Un capitombolo di quattrocento metri! Non lo tenterò di certo – disse Rokoff.
L’irbis, dopo essere rimasto qualche minuto immobile presso il boccaporto, rannicchiato su se stesso, aveva fatto un passo indietro, senza staccare gli occhi dai quattro aeronauti.
Non pareva troppo contento di quel viaggio intrapreso involontariamente.
Brontolava sordamente, arricciava il pelo e agitava nervosamente la lunga coda inanellata. Di quando in quando un brivido lo faceva sussultare e girava la testa a diritta e a manca come se cercasse di scorgere qualche albero su cui slanciarsi.
Aveva cominciato a indietreggiare lentamente allungando, con precauzione, prima una zampa e poi le altre, senza abbandonare tuttavia la sua posa d’assalto. Vedendo Rokoff fare un passo innanzi coll’arpione teso, arrestò la sua marcia retrograda e si raccolse su se stesso come fanno i gatti quando si preparano a slanciarsi sul topo.
Aprì le formidabili mascelle, mostrando due file di denti, bianchi come l’avorio e aguzzi come triangoli, mandando un rauco brontolio che finì in un soffio poderoso.
– No, Rokoff! – disse Fedoro. – Si prepara ad assalirci.
– Fermatevi – comandò il capitano, il quale si era impadronito d’una pesante cassa per scaraventarla contro la belva, nel caso si fosse slanciata innanzi. – Lasciatela indietreggiare.
– Finiamola – disse il cosacco. – Siamo in quattro.
– E tre sono inermi – disse Fedoro. – Vuoi farci sbranare?
– Lasciate che si allontani dalla macchina – rispose il capitano. – Poi scenderemo.
L’irbis stette qualche po’ immobile, continuando a brontolare, poi con un balzo di fianco si avventò verso la balaustrata, aggrappandosi ai ferri e guardando abbasso. Per un momento i quattro aeronauti credettero che si slanciasse nel vuoto; la loro speranza però ebbe la durata di pochi secondi.
La fiera, spaventata dall’abisso che le si apriva dinanzi, si era lasciata ricadere sul ponte. Tremava, come se avesse la febbre e gettava all’intorno sguardi smarriti, nei quali però balenava sempre un lampo di ferocia.
Ricominciò a retrocedere verso la prora, guatando cupamente gli aeronauti che non osavano ancora muoversi e si rannicchiò dietro una cassa, manifestando la sua rabbia con frequenti brontolii e con un incessante agitare della coda.
– La macchina è libera – disse Rokoff. – Approfittiamone.
– Lasciate fare a me – rispose il capitano. – Voi non muovetevi.
– Non vi assalirà?
– Può darsi.
– Allora signore vi domando il permesso di affrontare io il pericolo. Voi siete il capitano e dovete essere l’ultimo a esporre la vostra vita.
– Ma anch’io reclamo l’onore di farmi divorare per salvare voi – disse Fedoro.
– Né l’uno né l’altro – rispose il comandante. – D’altronde voi non sapete maneggiare la macchina.
Vedendo poi che il russo ed il cosacco aprivano le labbra per replicare, aggiunse con voce quasi dura:
– Basta, signori. Mi rincresce ricordarvi che il capitano sono io e che perciò voi mi dovete obbedienza assoluta.
Poi con un sangue freddo ed un’audacia ammirabile, s’avanzò verso la macchina, dardeggiando sulla fiera uno sguardo che pareva di sfida.
L’irbis non si era mosso; solamente le sue poderose unghie si erano infisse profondamente sulla cassa, sgretolando il legno.
Il capitano fece agire la leva, poi retrocesse tranquillamente, senza staccare i suoi occhi dal feroce avversario.
– Ecco fatto – disse con una voce perfettamente tranquilla. – Fra cinque minuti saremo a terra.
Lo «Sparviero» cominciava infatti a discendere. Il movimento delle eliche era stato arrestato e le ali non battevano più che leggermente.
– Dove cadremo? – chiese Rokoff. Il capitano si curvò sulla balaustrata.
La collina era stata attraversata e l’aerotreno scendeva sul deserto che in quel luogo era coperto da un lieve strato di neve già indurita dal gelido vento del settentrione.
– Tutto va bene – disse. – Tenetevi pronti ad afferrare le carabine, appena il leopardo ci lascerà.
Lo «Sparviero», sorretto solamente dai piani inclinati, continuava ad abbassarsi dolcemente.
L’irbis sempre più spaventato dalle ondulazioni che subiva il fuso, continuava a brontolare e a dare segni d’inquietudine. S’alzava sulle zampe posteriori fiutando rumorosamente l’aria e girava continuamente la testa in tutti i sensi. A un tratto avvenne un urto: lo «Sparviero» aveva toccato terra.
– Attenzione! – gridò il capitano.
Il leopardo con un salto immenso aveva varcata la balaustrata precipitandosi sulla neve.
Stette un momento immobile, stupito forse di trovarsi a terra, poi spiccò tre o quattro salti dirigendosi verso un gruppetto di betulle nane.
Il capitano, Rokoff e Fedoro si erano precipitati sulle carabine.
– Fuoco!…
Tre spari rimbombarono formando quasi una sola detonazione.
Il leopardo che si trovava a solo cento passi dal fuso, si rizzò di colpo mandando un urlo prolungato, girò due volte su se stesso, poi cadde in mezzo alla neve, agitando pazzamente le zampe.
Quasi nel medesimo istante si udirono dei clamori selvaggi, poi degli spari.
– Mille folgori! – esclamò Rokoff. – Che cosa succede ancora?
– I mongoli! – gridò il capitano. – Su, alziamoci!
– E il leopardo?
– Lo lasceremo a quei banditi; ci manca il tempo di raccoglierlo. Presto: grandina e s’avanzano al galoppo.
Un istante dopo lo «Sparviero» s’alzava maestosamente, salutato da una scarica di fucili.
L’INSEGUIMENTO DEI MONGOLI
Una banda di cavalieri era uscita improvvisamente dalle macchie di betulla e s’era slanciata, a corsa sfrenata, verso lo «Sparviero», urlando a piena gola e scaricando all’impazzata colpi di fucile.
Erano quaranta o cinquanta, tutti di statura bassa ma vigorosi, coperti per la maggior parte di pelli di montone, colla lana all’infuori e di ermellini, con lunghi stivali di feltro nero simili a quelli che usano i manciuri, ed il capo difeso da berrettoni di pelo di cane o di zibetto.
Brutti tipi d’altronde, con facce lunghe e piatte color dei meloni, cogli occhi obliqui e sporgenti, con lunghe barbe arruffate e code pure lunghissime, adorne di nastri sbrindellati.
Erano tutti armati di fucili antichissimi, parte a miccia e parte a pietra, di pistoloni, di scimitarre dalla lama larghissima e di coltellacci somiglianti un po’ agli jatagan degli afgani e montavano dei cavallucci magrissimi, colle teste molto allungate, dalle gambe secche e nervose che correvano come il vento, agitando le lunghe code.
In mezzo a loro saltellavano abbaiando, degli splendidi molossi di razza tibetana, dai dorsi poderosi, le labbra penzolanti, il muso raggrinzato, reso maggiormente feroce da due profonde piegature, e le code villose, terribili animali usati per guardare gli armenti e che non temono di affrontare gli orsi delle steppe, vincendoli facilmente.
– Chi sono costoro? – chiese Rokoff, il quale aveva introdotta una nuova cartuccia nella carabina. – Dei briganti?
– Nomadi mongoli – rispose il capitano, che li osservava attentamente. – Se non sono veramente dei briganti, sono egualmente da temersi e non vorrei trovarmi fra le loro mani.
– E vogliono darci la caccia?
– Spereranno d’impadronirsi del mio «Sparviero».
– Si vede che non lo hanno scambiato per un mostruoso drago come i cinesi. Sono meno superstiziosi e più coraggiosi.
– E poi ci hanno veduti – aggiunse Fedoro. – Avranno pensato che un drago non si lascia montare dagli uomini e avranno indovinato che questa è una superba macchina volante.
– Rovineranno inutilmente i loro cavallucci – disse Rokoff. – Non possono lottare con noi, è vero capitano?
– Speriamolo – rispose il comandante, con un certo accento però che colpì vivamente il russo e il cosacco.
– Perché dite «speriamolo» signore? – chiese Rokoff, guardandolo.
Una banda di cavalieri s’era slanciata a corsa sfrenata scaricando colpi di fucile…
– Temo che dovremo respingerli con le armi.
– Se corriamo con una velocità di trenta e più miglia all’ora?
– Durerà?…
– Ah! Signore! Forse che è avvenuto qualche guasto nella macchina?
– No, è ancora l’ala spezzata dalla palla dei manciù che non resisterà a lungo – rispose il capitano, il quale teneva gli sguardi fissi in alto. – Temo che il vento che è soffiato violentissimo la scorsa notte abbia danneggiata la saldatura, fatta troppo frettolosamente.
– Per le steppe del Don!
– La vedo oscillare sempre più e non oso forzare la corsa, anzi saremo costretti a rallentarla. Guardate, signori.
Rokoff e Fedoro, molto inquieti per quelle parole scoraggianti, alzarono gli sguardi.
L’ala, indebolita dai soffi poderosi del vento siberiano, e saldata alla meglio dal macchinista a cui era mancato il tempo, in causa dell’improvviso arrivo della giunca, subiva delle oscillazioni violentissime, accennando a piegarsi.
– Che cosa ne dici macchinista? – chiese il capitano.
– Che finirà per cadere nuovamente – rispose l’interrogato. – Temendo che i manciù ci piombassero addosso, non ho potuto completare il mio lavoro e non ho fatto che delle rilegature, signore. La colpa è mia, ma il tempo stringeva ed il pericolo incalzava.
– Tu hai fatto quello che hai potuto, mio bravo ragazzo – rispose il capitano. – La colpa è dei manciù.
– O meglio di quel cane di tartaro che io avrei appiccato con molto piacere – disse Rokoff.
– Rallenta la corsa.
– Sì, signore – rispose il macchinista.
– Ed i mongoli? – chiese Rokoff.
– Lasciamo che ci corrano dietro, per ora. Vedo all’orizzonte delle colline e se potremo superarle li lasceremo indietro – disse il capitano. – Tuttavia prepariamoci a far parlare i fucili. Ho delle carabine di lunga portata, degli ottimi Remington che a millecinquecento metri non sbagliano il bersaglio e anche dei fucili americani da sedici per mitragliare cavalli e cavalieri a duecentocinquanta passi.
– Voi possedete un vero arsenale, signore!…
– E che come vedete ci serve. Lasciate le carabine Express che hanno una portata troppo limitata e che sono più adatte ad affrontare le fiere che a combattere gli uomini e armiamoci coi Remington.
Mentre il macchinista, abbandonata la ruota al capitano, andava a prendere le armi, i mongoli continuavano vigorosamente la caccia, sferzando e speronando le loro cavalcature.
Dopo il primo slancio dello «Sparviero», erano rimasti subito indietro, ma da qualche minuto, rallentata la marcia dell’aerotreno per non compromettere l’ala già troppo malferma, avevano cominciato a guadagnare qualche centinaio di passi.
Si trovavano però ancora a mille e duecento o trecento metri, ossia troppo lontani perché le palle dei loro moschettoni potessero giungere fino allo «Sparviero». Tuttavia di quando in quando, forse per entusiasmarsi o forse per intimorire gli aeronauti, sparavano qualche colpo, assolutamente inoffensivo, perché quelle vecchie armi non dovevano avere che una portata molto limitata, malgrado le grosse cariche di polvere.
– Pare che siano proprio decisi a prenderci – disse Rokoff a Fedoro.
– Finché i loro cavalli non cadranno, continueranno a darci la caccia.
– Sono cattivi questi mongoli?
– Forse no, anzi sono ospitali, tuttavia non c’è da fidarsi di loro.
– L’hanno più collo «Sparviero» che con noi.
– Vorranno impadronirsene.
– Resisterà l’ala?
– Lo dubito, Rokoff. Oscilla sempre più forte e m’aspetto di vederla cadere da un momento all’altro.
– E precipiteremo anche noi dopo.
– Vi sono le eliche.
– Non basteranno ad innalzarci.
– Impediranno o almeno ritarderanno molto la nostra discesa.
– Se potessimo raggiungere prima quelle colline che occupano tutto l’orizzonte settentrionale!
– Riusciremo a superarle?
– Non mi sembrano molto alte – rispose Fedoro, che le osservava attentamente.
– E noi ci troviamo?
– A quattrocento metri d’altezza.
– Se potessimo innalzarci di più!
– Il capitano non osa forzare troppo le ali.
– Ah,
– Cos’hai Rokoff?
– I mongoli accelerano la corsa e riprendono il fuoco.
– Sono ancora troppo lontani perché le loro palle giungano fino qui.
– E noi siamo abbastanza vicini per fucilarli – disse il capitano che li aveva raggiunti, portando tre splendidi Remington. – Volete provare! Il bersaglio non è che a mille metri ed è molto visibile. A voi, signor Rokoff; i cosacchi sono, in generale, dei buoni tiratori.
– Cercherò di non smentire la loro fama, capitano. Mirerò il capofila, quello che monta quel cavalluccio morello. L’uomo o l’animale?
– Il cavallo prima; d’altronde il mongolo a piedi è come il gaucho della pampa argentina. Non conta più, essendo un pessimo camminatore.
– Vediamo – disse Rokoff.
S’appoggiò alla balaustrata di poppa, si piantò bene sulle gambe, poi abbassò lentamente il fucile mirando con grande attenzione.
L’arma rimase un momento ferma, tesa quasi orizzontalmente, poi uno sparo risuonò lungamente fra le collinette sabbiose del deserto.
Il cavallo morello s’impennò violentemente rizzandosi sulle gambe posteriori e scuotendo la testa all’impazzata, poi cadde di quarto, sbalzando a terra il cavaliere prima che questi avesse avuto il tempo di sbarazzare i piedi dalle staffe. Altri tre cavalli che venivano dietro a corsa sfrenata, inciamparono nel caduto, stramazzando l’uno addosso all’altro e scavalcando gli uomini che li montavano.
– Ben preso, signor Rokoff – disse il capitano. – Scommetterei un dollaro contro cento che la vostra palla ha colpito quell’animale in fronte. Vi ammiro.
– Tiro come un cosacco delle steppe – rispose Rokoff, ridendo.
I mongoli, sorpresi e anche spaventati da quel colpo maestro si erano arrestati intorno ai caduti urlando. La loro sosta fu brevissima. Appena videro i compagni rialzarsi, ripartirono al galoppo, sparando e vociando.
– Ah! Non ne hanno abbastanza! – esclamò il capitano. – Vogliono farsi smontare? Sia!
Stava per puntare il fucile, quando in aria si udì uno scricchiolio, poi il fuso si spostò, piegandosi un po’ su un fianco.
– Maledizione! – gridò il capitano. – L’ala ha ceduto! Macchinista, le eliche prima che la discesa cominci!
Il fuso non si era ancora abbassato, quantunque il movimento delle ali fosse stato subito arrestato. Soffiando un fresco venticello i piani inclinati lo avevano sorretta in modo da far conservare al fuso la sua altezza di quattrocento metri.
– Ci raggiungeranno, è vero capitano? – chiese Rokoff.
– I mongoli?
– Sì.
– Guadagnano già.
– Ed il vento è debole – aggiunse Fedoro.
– Signori, si tratta di non risparmiare le cartucce, almeno fino a quando avremo raggiunto o superate quelle colline.
– Rokoff – disse Fedoro. – A me il cavaliere di destra; a te quello di sinistra.
– Ed a me quello che li segue – aggiunse il capitano. – Vediamo se possiamo arrestarli.
Puntarono le armi appoggiandole sulla balaustrata, poi fecero fuoco a pochi secondi d’intervallo.
Questa volta non erano stati tutti cavalli a cadere. Due avevano continuata la loro corsa senza i loro padroni, i quali giacevano sulla neve senza moto. Il terzo invece era stramazzato come fosse stato fulminato, facendo fare al suo signore una superba volata in avanti.
I mongoli, vedendo quel massacro, per la seconda volta si erano arrestati, urlando ferocemente e scaricando i loro moschettoni, le cui palle non potevano ancora giungere fino allo «Sparviero».
La paura cominciava a prenderli. Passarono parecchi minuti prima che si decidessero a continuare l’inseguimento.
Conoscendo ormai l’immensa portata delle armi degli aeronauti, non si avanzavano più colla foga primitiva e rallentavano sovente lo slancio dei loro cavalli.
– La nostra scarica ha prodotto un buon effetto – disse il capitano.
– È stata una vera doccia fredda che ha calmato i loro entusiasmi bellicosi – rispose Rokoff. – Volete continuare capitano?
– È inutile sacrificare altre vite umane. Sono dei poveri selvaggi che meritano compassione. Finché si tengono lontani e non ci fucilano, lasciamoli galoppare. D’altronde, fra una mezz’ora noi li perderemo di vista; le colline sono poco lontane.
– Non potranno superarle? – chiese Fedoro.
– Non credo. Le ho osservate poco fa col cannocchiale e mi sono accertato che sono assolutamente impraticabili per cavalli. Sono dei veri ammassi di rocce colossali, quasi tagliate a picco, senza passaggi – rispose il capitano. – Prima che i mongoli possano girarle, trascorreranno molte ore e noi guadagneremo tanta via da non temere più di venire raggiunti.
– Nondimeno teniamoci pronti a fare una nuova scarica – disse Rokoff, il quale tormentava il grilletto del fucile. – Ce la prenderemo ancora coi cavalli.
I mongoli invece si tenevano ad una distanza considerevole, pur continuando la caccia. Che cosa attendevano? Che lo «Sparviero» si decidesse a scendere o che, esausto capitombolasse?
Magra speranza, perché l’aerotreno non accennava ad abbassarsi nemmeno d’un metro. Sorretto dai piani inclinati e dalle eliche orizzontali e rimorchiato da quella proviera, continuava la sua marcia, quantunque il vento non accennasse ad aumentare.
Solamente la sua velocità da trenta miglia all’ora era discesa ad appena dieci e se i mongoli avessero voluto, avrebbero potuto facilmente raggiungerlo e moschettarlo. Alle dieci le colline non si trovavano che a cinquecento metri. Formavano una immensa doppia collina, la quale si estendeva dall’est all’ovest per parecchie decine di miglia.
Più che colline erano rocce colossali e aridissime. Non si vedeva spuntare, né sui loro fianchi né sulle loro cime, la menoma pianticella ed erano così rigide da non permettere la scalata nemmeno a una scimmia.
Non essendo alte più di trecento metri lo «Sparviero», che manteneva i suoi quattrocento metri, poteva facilmente sorpassarle senza urtarvi contro.
I mongoli, accorgendosi che la preda agognata stava loro per sfuggire, sferzavano violentemente i cavalli e raddoppiarono i loro clamori, ricominciando un fuoco violentissimo, quantunque ancora inefficace per la poca portata delle loro armi. Si agitavano furiosamente sulle loro cavalcature, snudavano le loro scimitarre trinciando colpi a destra ed a manca ed insultavano gli aeronauti i quali si accontentavano di sorridere a quell’impotente rabbia.
– Ci prenderete un’altra volta? – gridò a loro Rokoff, minacciandoli col fucile. – Per ora non abbiamo tempo di occuparci di voi.
Una scarica violentissima fu la risposta, ma ormai lo «Sparviero» filava maestosamente sulla prima catena di rocce, attraversando un immenso abisso. I mongoli s’arrestarono dinanzi a quegli ostacoli insormontabili, continuando a sparare, poi si slanciarono a corsa sfrenata verso l’est.
– Che cerchino di girare le colline? – chiese Rokoff.
– Pare che ne abbiano l’intenzione – rispose il capitano. – Dovranno però percorrere almeno una quarantina di miglia prima di giungere là dove declinano e poi altrettante e anche più per raggiungerci.
– I loro cavalli non potranno di certo percorrere d’un fiato un centinaio e mezzo di chilometri – disse Fedoro. – Sono già esausti.
– Mi rincresce – disse Rokoff. – Questa caccia emozionante m’interessava.
– E se fossimo caduti? – chiese il capitano. – I mongoli non ci avrebbero risparmiati, ve lo assicuro, essendo assai vendicativi.
– Il vostro «Sparviero» è troppo ben costruito per fare un capitombolo.
– Un guasto poteva avvenire nella macchina. Meglio che la sia finita così, signor Rokoff.
– Ed ora dove andiamo? – chiese Fedoro.
– A gettare le nostre reti nei laghi del Caracoruzn – rispose il capitano con uno strano sorriso.
– Tanto ci tenete alle trote di quei laghi, signore? – domandò Rokoff.
– Si dice che siano così eccellenti?
– Le avete assaggiate ancora?
– No, me l’ha detto un mio amico.
– Le giudicheremo – concluse Rokoff, quantunque non credesse affatto che lo scopo di quella corsa fossero veramente le trote.
Lo «Sparviero» aveva allora superata anche la seconda catena di rocce e ridiscendeva verso il deserto piegando un po’ verso l’ovest.
Lo Sciamo, al di là di quelle colline, perdeva molto della sua aridità. Se vi era maggior copia di neve su quelle immense pianure si vedevano anche molte erbe altissime e gruppi di betulle e di pini i quali formavano dei graziosi boschetti popolati dai nidi di falchi, di pernici da neve, di lepri e di ermellini. Era quella la regione abitata dai Chalkas, tribù di nomadi ospitali, che si dedicano all’allevamento del bestiame e che vivono sotto vaste tende di feltro che piantano qua e là, secondo che li spinge il capriccio.
In quel luogo, in quel momento non si vedeva alcun attendamento. Probabilmente il freddo li aveva ricacciati verso l’est per cercare pascoli più abbondanti sui pendii dei Grandi Chingan o sulle rive del Kerulene della Chalka.
Poco dopo il mezzodì lo «Sparviero» che aveva incontrata una corrente d’aria favorevole che spirava dal sud-est, si librava a poca distanza da un laghetto, le cui rive erano coperte da una vegetazione abbondante, composta di abeti giganteschi, di betulle, di larici, di lauri, di cespugli, di rose canine, di pomi selvatici e di noccioli.
– Possiamo scendere – disse il capitano, facendo cenno al macchinista di arrestare le eliche. – Le nostre trote ci aspettano.
– Ci fermeremo molto qui? – chiese Rokoff.
– Finché il macchinista avrà riparata l’ala in modo da garantirmi che non si spezzi più. Avete forse fretta di tornare in Europa?
– Nessuna, signore – rispose il cosacco.
– Ah! Il telegramma!
– Quale, capitano?
– Quello del vostro compagno. Signor Fedoro, volete scriverlo?
Il russo guardò il capitano, il quale sorrideva.