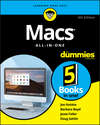Kitabı oku: «I misteri della jungla nera», sayfa 5
VII. Kammamuri
Kammamuri, dopo l’avvenuta separazione, aveva preso la via che conduceva al fiume, cercando di seguire le traccie dell’indiano che lo precedeva. Però, bisogna dirlo, il bravo maharatto si allontanava dal suo padrone a malincuore, e quasi con rimorso.
Egli, con ragione, temeva che Tremal-Naik commettesse qualche pazzia, sapendo che voleva rivedere la misteriosa visione e perciò ogni dieci passi s’arrestava titubante, più disposto ad indietreggiare, malgrado il divieto, che di andare innanzi.
Come ritornare alla capanna, sapendo che il padrone trovavasi nella jungla maledetta, dove i nemici pullulavano come i bambù? Gli sembrava una enormità, una cosa assolutamente impossibile, quasi un delitto.
Non aveva ancor percorso mezzo miglio, quando si decise di ritornare sui propri passi a costo di far andare in bestia Tremal-Naik.
– Infine, – disse il bravo maharatto, – un compagno potrà servirgli a qualche cosa. Animo, Kammamuri, coraggio ed occhi aperti.
Fece una piroetta sui talloni e si diresse nuovamente verso l’ovest, non ponendo più mente all’indiano che fino allora lo aveva preceduto.
Non aveva fatto ancor venti passi, che udì una voce disperata a gridare:
– Aiuto! aiuto!
Kammamuri fece un salto indietro.
– Aiuto! – mormorò egli. – Chi chiama aiuto?
Stette in ascolto, con una mano all’orecchio: il venticello notturno che spirava dall’ovest, portò a lui un fischio acuto.
– Succede qualche cosa laggiù, – borbottò il maharatto, inquieto.– Il vento porta, chi ha gridato deve essere a mezzo miglio da qui, nella direzione presa dal mio padrone. Che assassinino qualcuno?
La paura di cadere nelle mani degli indiani era forte, ma la curiosità la vinse.
Si pose la carabina sotto il braccio e si diresse verso l’ovest, scostando i bambù con precauzione. Proprio in quell’istante echeggiò una detonazione.
Nell’udirla, il maharatto sentì gelarsi il sangue nelle vene. La carabina di Tremal-Naik, che tante e tante volte aveva udito rombare nella jungla nera, la conosceva troppo bene perché potesse ingannarsi.
– Grande Siva! – mormorò coi denti stretti. – Il padrone si difende.
L’idea che Tremal-Naik corresse un pericolo, gl’infuse un coraggio straordinario.
Disprezzando ogni precauzione, dimenticando che forse gl’indiani lo spiavano, si mise a correre verso il luogo dal quale sembrava essere partita la detonazione.
Un quarto d’ora dopo giungeva ad una specie di radura, nel mezzo della quale contorcevasi un oggetto lungo lungo, sparso di macchie. Quel corpo emetteva dei sibili acuti, particolari ai serpenti, allorché sono irritati.
– To’, un pitone! – esclamò Kammamuri il quale, famigliarizzato a simili rettili, non provava paura alcuna.
Stava per allontanarsi, per evitare il pericolo di venire assalito e stritolato, quando s’accorse che il rettile non era più intero e che a lui vicino giaceva un corpo umano.
Sentì rizzarsi il ciuffo di capelli che crescevagli sulla nuca.
– Che sia il padrone, – mormorò.
Afferrò la carabina per la canna, affrontò il rettile che contorcevasi rabbiosamente perdendo sangue e gli schiacciò la testa.
Liberatosi del mostro, corse a quel corpo umano che non dava più segno di vita.
– Visnù sia benedetto! – esclamò, emettendo un sospirone. – Non è il padrone.
Infatti era un indiano, quello stesso che per lanciarsi contro Tremal-Naik era caduto fra le spire del pitone. Il povero diavolo non era più riconoscibile, dopo la terribile stretta del rettile.
Era una massa di carne contorta, stritolata, inondata di sangue.
Aveva la bocca smisuratamente aperta e lorda d’una spuma sanguinosa, gli occhi fuori delle orbite, punte di ossa infrante che gli uscivano dal petto orrendamente sfondato e le membra spezzate in dieci diversi luoghi.
Kammamuri si curvò su di lui per udire se respirava ancora, ma quelle carni erano già fredde.
– Il pover’uomo non ha potuto resistere alla potente stretta, – disse.– Tanto peggio per lui: quest’indiano non può essere che uno di quelli che ci davano la caccia, poiché vedo sul suo petto il misterioso tatuaggio. Orsù, qui non c’è ormai più nulla da fare e corro il pericolo di venire scoperto.
Un leggiero strofinìo di bambù scossi, lo inchiodò sul suolo. Si piegò prontamente e si distese in mezzo alle erbe, rimanendo immobile come il cadavere che aveva vicino.
Se non era stato ancora veduto, poteva sfuggire allo sguardo di colui o di coloro che avevano smosso i bambù, essendo le canne alte.
Lo strofinìo era subito cessato, ma non bisognava fidarsi. Gli indiani sono pazienti come le pelli-rosse dell’America e spiano la preda per delle ore, anzi per delle giornate, e Kammamuri, indiano pur lui, non le ignorava.
Stette così parecchio tempo, poi ardì alzare il capo e guardare all’intorno.
Un sibilo lamentevole fendé l’aria e si senti strozzare da un laccio, che una mano abile aveva gettato attorno al suo collo.
Rattenne il grido che stava per uscirgli dalle labbra, afferrò con pugno solido la corda impedendo così che lo strangolasse e ricadde fra le erbe dibattendosi come un agonizzante. L’astuzia riuscì pienamente.
Lo strangolatore, che tenevasi imboscato dietro ad un gruppo di canne da zucchero selvatiche, credendo che la vittima fosse per spirare, balzò fuori per finirla a colpi di pugnale. Kammamuri aveva afferrata una delle pistole e l’aveva armata drizzandola su di lui.
– Sei morto! – gli gridò.
Un lampo ruppe le tenebre, seguito da una detonazione. Lo strangolatore barcollò, portò le mani al petto e cadde di peso fra le erbe.
Kammamuri gli fu sopra colla seconda pistola.
– Dov’è Tremal-Naik? – gli chiese.
Lo strangolatore tentò di risollevarsi, ma ricadde. Un getto di sangue gli uscì dalla bocca, stralunò gli occhi, emise un gemito e s’irrigidì. Era morto.
– Battiamocela, – mormorò il maharatto. – Tra poco avrò alle calcagna i suoi compagni.
Saltò in piedi e si diede a precipitosa fuga dalla parte che era venuto persuaso che il morto fosse l’indiano che lo aveva preceduto e che Tremal-Naik fosse riuscito a salvarsi.
Percorse, così correndo, più d’un miglio inoltrandosi sempre più nella jungla, procurando di mantenere una via retta per giungere alla riva del fiume e di là aspettare il ritorno del padrone che non voleva abbandonare. Era la mezzanotte, quando si trovò sul limitare di una foresta di palme da cocco, superbe piante che superano in bellezza le palme da datteri, e che una sola basta per fornire ad una intera famiglia il cibo, la bevanda e persino le vestimenta.
Il maharatto non ardì andare più innanzi; s’arrampicò su una di quelle piante e stabilì lassù il suo domicilio, sicuro di non venire assalito dagl’indiani e meno ancora dalle tigri, che dovevano trovarsi in buon numero in quell’isola.
Si accomodò sul tronco, si legò colla corda presa allo strangolatore e rassicurato dal profondo silenzio che regnava, chiuse gli occhi.
Non dormì che pochissime ore, poiché un baccano infernale lo svegliò.
Una grossa banda di sciacalli, sbucata chi sa mai da dove, aveva attorniato l’albero e gli faceva l’onore di una spaventevole serenata.
Quegli animali, poco dissimili dai lupi, che pullulano come le formiche in tutta o quasi tutta l’India, ed i cui morsi sono ritenuti velenosi, erano più di cento e facevano salti disperati, sfogando la loro rabbia con urli lamentevoli, quasi strazianti, da incutere terrore anche a chi è abituato a udirli da lunga pezza.
Kammamuri avrebbe ben voluto allontanarli con qualche schioppettata, ma la tema di attirare gl’indiani, assai più terribili di quelle bestie, lo trattenne e si rassegnò ad ascoltare il loro concerto che durò fino all’alba.
Allora poté gustare il sonno che si prolungò più di quanto avrebbe voluto, poiché quando riaprì gli occhi, il sole aveva quasi compito l’intero suo giro e declinava rapidamente all’occidente. Spaccò una noce di cocco giunta a completa maturanza, grossa quanto la testa di un uomo, la cui polpa indurita rammenta il sapore delle mandorle, ne inghiottì una buona parte e si rimise bravamente in marcia, non già questa volta coll’intenzione di recarsi alla riva, ma di trovare Tremal-Naik.
Attraversò il bosco di cocchi perdendo parecchie ore e quantunque la notte fosse abbastanza inoltrata, rientrò nella jungla piegando verso il sud e continuò a marciare così fino a mezzanotte, fermandosi di quando in quando ad esaminare il terreno colla speranza di trovare qualche traccia del padrone. Disperando ormai di scoprire qualche indizio, stava per cercare un albero su cui passare il restante della notte, quando due sordi spari, tirati a poca distanza l’un dall’altro, lo colpirono.
– To’ – esclamò sorpreso.
Un terzo sparo, più forte degli altri due, s’udì.
– Il padrone! – gridò. – Questa volta non mi sfugge più!
Sospese le sue ricerche e corse verso il sud colla celerità d’un cavallo, e mezz’ora dopo giungeva in un’ampia radura, in mezzo alla quale illuminata da uno splendido chiaro di luna, ergevasi una grandiosa pagoda. Fece alcuni passi innanzi, poi ritornò rapidamente indietro riguadagnando i bambù.
Due uomini si erano mostrati all’aperto e muovevano verso la jungla, portando una terza persona che sembrava morta.
– Cosa vuol dire ciò? – borbottò il maharatto, che cadeva di sorpresa in sorpresa. – Che vengano a seppellire quel cadavere nella jungla?
S’allontanò ancor più, cacciandosi nel fitto d’un cespuglio, ma in un luogo da cui poteva vedere senza essere scoperto.
I due portatori, che riconobbe per due indiani, attraversarono rapidamente la radura, arrestandosi presso i bambù.
– Animo, Sonephur, – disse uno dei due. Facciamolo dondolare e scagliamolo là in mezzo. Sono certo che domani mattina non troveremo che le ossa, se le tigri saranno d’umore di lasciarle.
– Lo credi? – chiese l’altro.
– Sì, la nostra amata dea s’incaricherà d’inviargli una mezza dozzina di quelle bestie. Quest’indiano è un bel pezzo di carne e abbastanza giovane.
I due miserabili scoppiarono in una sonora risata, a quell’atroce scherzo.
– Prendilo bene, Sonephur.
– Andiamo, uno, due…
I due indiani fecero oscillare il cadavere e lo scagliarono in mezzo alla jungla.
– Buona fortuna! – gridò uno.
– Buona notte, – disse l’altro. – Domani mattina verremo a farti una visita.
Ed i due indiani s’allontanarono sghignazzando.
Kammamuri aveva assistito a quella scena. Aspettò che i due indiani fossero molto lontani, poi uscì dal nascondiglio e spinto da una forte curiosità, s’avvicinò al cadavere. Un urlo strozzato gli uscì dalle labbra.– Il padrone! esclamò con voce straziante. – Oh! i maledetti!
Infatti quel cadavere era Tremal-Naik. Aveva gli occhi chiusi, la faccia orribilmente alterata e in mezzo al petto, confitto sino al manico, un pugnale. Le vesti erano tutte lorde del sangue che usciva ancora dalla profonda ferita.
– Padrone! mio povero padrone! – singhiozzò il maharatto.
Appoggiò ambe le mani sul corpo di lui e trasalì come se fosse stato toccato da una pila elettrica. Gli pareva d’aver sentito il cuore a battere.
Avvicinò l’orecchio e ascoltò rattenendo il respiro. Non vi era da ingannarsi: Tremal-Naik non era ancor morto poiché il cuore debolmente batteva.
– Forse non è colpito a morte, – mormorò, tremando per l’emozione. – Calma, Kammamuri, e agiamo senza perdere tempo.
Con precauzione tolse a Tremal-Naik il kurty mettendo a nudo l’ampio petto. Il pugnale gli era stato immerso fra la sesta e la settima costola, in direzione del cuore, ma senza averlo toccato.
La ferita era terribile, ma forse non era mortale; Kammamuri che se ne intendeva più d’un medico, sperò di salvare l’infelice.
Prese delicatamente l’arma e lentamente, senza scosse, la estrasse dalla ferita: un getto di sangue caldo e rosso uscì dalle labbra. Era buon segno.
– Guarirà, – disse il maharatto.
Stracciò un pezzo del kurty ed arrestò l’emorragia che poteva essere fatale pel ferito. Ora si trattava di avere un po’ d’acqua e alcune foglie di youma da spremere sulla piaga, per affrettare la cicatrizzazione.
– Bisogna a qualsiasi costo allontanarsi da qui per trovare qualche stagno, – mormorò poi. – Tremal-Naik è forte, un uomo d’acciaio e sopporterà il trasporto senza aggravare la ferita. Animo, Kammamuri.
Raccolse tutte le sue forze, lo afferrò fra le braccia più delicatamente che poté, e s’allontano barcollando, dirigendosi verso l’est, ossia verso il fiume.
Riposando ogni cento passi per tirare il fiato e per vedere se il padrone dava sempre segno di vita, grondante di sudore, reggendosi a mala pena sulle gambe, percorse più d’un miglio e si fermò sulle rive d’uno stagno d’acqua limpidissima, circondato da una triplice fila di piccoli banani e di cocchi.
Depose il ferito su di un denso strato d’erbe, ed applicò sulla sanguinosa piaga delle pezzuole bagnate. A quel contatto un debole sospiro, che parve un gemito represso, uscì dalle labbra di Tremal-Naik.
– Padrone! padrone! – chiamo il maharatto.
Il ferito agitò le mani ed aprì gli occhi che roteavano in un cerchio sanguigno, fissandoli su Kammamuri.
Un raggio di gioia illuminò il suo bronzeo volto.
– Mi riconosci, padrone? – chiese il maharatto.
Il ferito fece un cenno affermativo col capo e mosse le labbra come per parlare, ma non articolò che un suono confuso, incomprensibile.
– Non puoi ancora parlare, – disse Kammamuri, – ma mi narrerai ogni cosa poi. Sta’ certo, padrone, che ci vendicheremo dei miserabili che t’hanno conciato così malamente.
Lo sguardo di Tremal-Naik brillò di un cupo fuoco e strinse le dita strappando le erbe. Egli lo aveva senza dubbio compreso.
– Calma, calma, padrone. Ora troverò io alcune erbe che ti faranno molto bene, e fra quattro o cinque giorni abbandoneremo questi luoghi e ti condurrò alla capanna a terminare la tua guarigione.
Gli raccomandò un’ultima volta silenzio e immobilità completa, batté le erbe per un raggio di trenta o quaranta passi per assicurarsi che non nascondevano alcuno di quei terribili serpenti detti rubdira mandali il cui morso fa, come si dice, sudar sangue, e si allontanò strisciando.
Non corse molto, che trovò alcune pianticelle di youma, volgarmente chiamate lingua di serpente il cui succo è un balsamo prezioso per le ferite.
Ne fece una buona raccolta e si disponeva a ritornare, ma fatti appena pochi passi s’arrestò colle mani sui calci delle pistole.
Gli era sembrato di aver veduto una massa nera cacciarsi silenziosamente fra i bambù; aveva più la forma d’un animale, che d’un essere umano.
Fiutò a più riprese l’aria e sentì un odore marcatissimo di selvatico.
– Attento Kammamuri, – mormorò. Abbiamo una tigre vicina.
Si mise fra i denti il coltellaccio e s’avanzò intrepidamente verso lo stagno guardando attentamente attorno. S’aspettava di trovarsi da un momento all’altro di fronte al feroce carnivoro, ma così non fu e giunse in mezzo agli alberi senza averlo nemmeno veduto.
Tremal-Naik era nel medesimo luogo di prima e pareva assopito, di che si rallegrò il bravo maharatto. Si mise vicino la carabina e le pistole per esser pronto a servirsene, masticò le erbe, malgrado la loro insopportabile amarezza e le applicò sulla piaga.
– Là, così va bene, – diss’egli stropicciandosi allegramente le mani. – Domani il padrone starà meglio e potremo sloggiare da questo luogo che non mi sembra molto sicuro. Gl’indiani fra poche ore si recheranno nella jungla e non trovando il cadavere, si metteranno senza dubbio in campagna. Non lasciamoci dunque prendere così…
Un miagolìo formidabile, famigliare alle tigri, simile ad un ruggito, gli troncò la frase. Volse rapidamente la testa, allungando istintivamente le mani verso le armi.
Là, a quindici passi di distanza, raccolta su se stessa, come in atto di slanciarsi stava un’enorme tigre reale, che lo fissava con due occhi brillanti che avevano i riflessi azzurrini dell’acciaio.
VIII. Una notte terribile
Tremal-Naik, al ruggito di guerra del felino, si era subitamente svegliato, facendo un brusco movimento, come se cercasse il suo fedele coltellaccio. Il moribondo s’era rianimato come il soldato che ode lo squillo di tromba che dà il segnale della mischia.
– Kammamuri? – articolò con uno sforzo supremo.
– Non muoverti, padrone! – disse il maharatto, che fissava negli occhi la belva, sempre raccolta su se stessa.
– La ti…gre! la ti…gre! – ripeté il ferito.
– Ci penso io. Torna ad adagiarti e non prenderti pensiero per la mia vita.
Il maharatto aveva impugnata una pistola e aveva diretto la canna sulla tigre, ma non ardiva tirare, temendo in primo luogo di non ucciderla sul colpo e collo sparo di attirare l’attenzione dei nemici.
La tigre, lo si vedeva, esitava ad assalire, tenuta in rispetto dalla canna lucente della pistola, conoscendone indubbiamente i mortali effetti. Si batté tre o quattro volte i fianchi colla coda, come i gatti allorché sono in collera, emise un secondo miagolio più forte del primo poi cominciò ad indietreggiare sollevando la terra coi suoi potenti artigli senza staccare gli occhi dal maharatto che sosteneva imperterrito quello sguardo.
– Kamma…muri… la ti…gre! – tornò a balbettare Tremal-Naik, sforzandosi di sollevarsi sulle braccia.
– Se ne va, padrone. Non ardisce attaccare il cacciatore di serpenti ed il suo maharatto. Sta’ cheto e tutto andrà bene.
Ad un tratto la tigre scattò in piedi, drizzò gli orecchi come cercasse di raccogliere qualche rumore, emise un terzo ma più basso miagolio fece un rapido voltafaccia e scomparve nella jungla, lasciandosi dietro il ben noto odore di selvatico.
Kammamuri s’era pure alzato, in preda ad una forte inquietudine.
– Chi può avere spaventata la tigre? – si domandò con ansietà. – Qualcuno sicuramente si avvicina.
Si slanciò verso gli alberi ed esaminò la jungla che era distante un centinaio di passi, ma non vide alcuno.
S’affrettò a ritornare vicino a Tremal-Naik, che era ricaduto sul letto di foglie.
– La ti…gre? – chiese il ferito con voce fioca.
– È scomparsa, padrone, – rispose il maharatto, dissimulando la sua inquietudine. Ha avuto paura della mia pistola. Dormi e non pensare ad altro.
Il ferito mandò un sordo gemito.
– Ada! balbettò.
– Cosa vuoi, padrone?
– Ah! come… era bella… bel…la!
– Cosa vuoi dire? Chi era bella?
– Ma…ledetti… l’han…no rapita… ma… – digrignò i denti con rabbia e cacciò le unghie in terra.
– Ada!… Ad…a! – ripeté.
– Delira, – pensò il maharatto.
– Sì, l’hanno ra…pita, – continuò il ferito. – Ma… la ritro… verò oh! sì, la ritroverò!
– Non parlare, padrone, che corriamo un grave pericolo.
– Pericolo? – balbettò Tremal-Naik, senza comprenderlo. – Chi parla di pe…ricolo? Tornerò qui… sì, tornerò, maledetti… con la mia Darma… e vi fa…rò divorare tut…ti!
Agitò le braccia con impeto furioso, roteò gli occhi, li chiuse e rimase immobile come fosse morto.
– Dorme, – disse Kammamuri. – Tanto meglio: almeno il suo gridare non tradirà la nostra presenza. Ed ora, stiamo in guardia, che la tigre forse ci spia.
Si sedette incrociando le gambe alla maniera dei turchi, si mise la carabina sulle ginocchia, si cacciò in bocca una pallottola di betel per combattere il sonno che lo assaliva e attese pazientemente l’alba, cogli occhi bene aperti e gli orecchi ben tesi. Passarono una, due, tre ore, senza che nulla accadesse. Nessun miagolio di tigre, nessun sibilo di serpente, nessun urlo di sciacallo rompeva il silenzio che regnava nella misteriosa jungla. Solo di quando in quando un soffio d’aria carico di pestifere esalazioni, passava sulle canne e le curvava con dolce mormorio. Le tre dovevano essere trascorse, quando una specie di fischio, potente, bizzarro, ruppe il silenzio. Era una specie di niff! niff! assai acuto.
Il maharatto sorpreso e un po’ atterrito, s’alzò e tese gli orecchi rattenendo il respiro. Quel misterioso niff! niff! si ripeté e molto vicino.
– Questa non è la tigre! – mormorò Kammamuri. – Quale pericolo ancora ci minaccia?
Armò la carabina, strisciò senza far rumore verso gli alberi e guardò.
A trenta passi da lui si muoveva un grosso animale lungo non meno di dodici piedi, di forme pesanti, massiccie. Aveva la pelle irta di protuberanze, la testa grossa e un po’ triangolare, gli orecchi grandi e sulla massa ossea delle nari un corno aguzzo e molto lungo.
Kammamuri riconobbe subito con che razza di nemico aveva a che fare, e si sentì il cuore rimpicciolire per lo spavento.
– Un rinoceronte! – esclamò con un filo di voce. – Siamo perduti!…
Non alzò nemmeno la carabina, ben sapendo che la palla si sarebbe schiacciata contro quella pelle grossissima che è più resistente d’una corazza d’acciaio. Poteva bensì colpire il mostro in un occhio, il solo punto vulnerabile, ma la paura di mancare al colpo e di venire sventrato dal terribile corno o schiacciato sotto le mostruose zampe, gli suggerì l’idea di starsene cheto sperando di non venire scoperto.
Il rinoceronte pareva in preda ad una viva irritazione, ciò che succede sovente a questo animale intrattabile, rozzo, brutale e povero d’intelligenza. Si slanciava, come fosse diventato d’un tratto pazzo, con una agilità veramente sorprendente per un essere della sua struttura e si divertiva a spezzare, a frantumare, a disperdere i bambù, facendo delle ampie breccie nella jungla.
Di quando in quando s’arrestava respirando fragorosamente, si avvoltolava per terra come un cignale, agitando pazzamente le tozze gambe e sprofondando fra le erbe il suo corno, per poi risollevarsi e ricominciare daccapo i suoi assalti contro i bambù.
Kammamuri non respirava nemmeno per non attirare l’attenzione del bruto; sudava come riposasse sul coperchio di una caldaia in ebollizione, e stringeva con mano convulsa la carabina, divenuta inutile quanto un bastone di ferro. Egli aveva paura che l’animale se la prendesse cogli alberi e s’avvicinasse allo stagno, scoprendo così Tremal-Naik.
Stette lì qualche tempo, poi riguadagnò il giaciglio del padrone. Sua prima cura fu quella di strappare quanta erba poté e nascondere totalmente il ferito, poi se la svignò accanto ad un banian abbastanza grosso, portando seco le armi.
– Non posso fare di più, – disse. – Ad ogni modo, accoglierò il bruto con una scarica generale delle mie armi.
Il rinoceronte continuava a saltellare presso la jungla. Si udiva il terreno tremare sotto il suo peso, i bambù a spezzarsi crepitando e la sua formidabile respirazione paragonabile al suono d’una rauca tromba.
D’improvviso Kammamuri udì il miagolìo della tigre. Si slanciò rapidamente verso lo stagno, guardandosi d’intorno con spavento.
Sull’albero che aveva allora allora abbandonato, scorse la tigre aggrappata ad uno dei rami; i suoi occhi scintillavano come quelli di un gatto e i suoi artigli strappavano la corteccia della pianta.
Puntò rapidamente il fucile verso la fiera, la quale, sgomentata, si slanciò giù per guadagnare la jungla, ma si trovò dinanzi al rinoceronte.
I due formidabili animali si guardarono reciprocamente per qualche istante. La tigre, che forse sapeva di nulla avere da guadagnare in una lotta col brutale colosso, cercò di fuggire, ma non ne ebbe il tempo.
Il rinoceronte aveva fatto udire il suo grido. Abbassò la testaccia mostrando l’aguzzo suo corno e si slanciò furiosamente sulla belva, dimenando rabbiosamente la corta sua coda.
L’urto fu terribile. La tigre aveva fatto un salto immenso, cadendo sulla groppa del colosso, il quale, fatti trenta o quaranta passi, si gettò a terra costringendola a lasciarlo.
– Bravo rinoceronte! – mormorò Kammamuri.
I due nemici s’erano entrambi risollevati, con rapidità fulminea, precipitandosi l’un sull’altro. Il secondo assalto non fu fortunato per la tigre. Il corno del rinoceronte le fracassò il petto lanciandola di poi in aria per più di quaranta metri. Ricadde, cercò di risollevarsi mugolando di dolore e di rabbia e tornò a volare ancor più in alto perdendo torrenti di sangue.
Il rinoceronte non attese nemmeno che ricadesse. Con un terzo colpo della sua terribile arma la sventrò, poi rivoltandola contro terra la schiacciò coi suoi larghi piedi riducendola in un ammasso di carni sanguinolente e di ossa infrante.
Tutto ciò era successo in pochi secondi. Il colosso, soddisfatto, emise due o tre volte il suo sordo fischio, indi rientrò nella jungla a devastare i bambù, senza però allontanarsi dallo stagno.
La sua ritirata giungeva in buon punto, poiché Tremal-Naik, in preda al delirio e ad una violentissima febbre, s’era risvegliato chiamando Kammamuri.
Ciò rendeva la situazione dei due indiani estremamente pericolosa, poiché l’intrattabile animale poteva udire le loro voci e comparire improvvisamente fra gli alberi. Il maharatto sapeva bene che non vi era da illudersi sulle probabilità di salvare la vita, nemmeno colla fuga, poiché tutte le specie di rinoceronti superano nella corsa l’uomo più agile.
S’affrettò a raggiungere il padrone ed a liberarlo dalle erbe che lo coprivano.
– Silenzio, – diss’egli, ponendogli un dito sulle labbra. – Se ci ode, siamo irremissibilmente perduti.
Ma Tremal-Naik, in preda al delirio, agitava pazzamente le braccia e dalle labbra gli uscivano parole insensate:
– Ada… Ada!… – gridava egli, sbarrando spaventosamente gli occhi – dove se’ tu, vergine della pagoda?… Ah! ah! mi ricordo… Sì, mezzanotte! mezzanotte!… Ed essi sono venuti, tutti armati, molti contro uno, ma non ho paura no, io, non tremo, sai, Ada, sono il cacciatore di serpenti… forte! molto forte! L’ho visto sai quell’uomo, quello che ti ha condannata. Era brutto, molto brutto e voleva strangolarmi. Perché quegli uomini hanno dei lacci? Perché hanno anche loro il serpente sul petto? Quanti serpenti, quante teste di donna. Ma non mi fan paura. Che? io aver paura di loro? Io, Tremal-Naik?… Ah!… Ah!…
Tremal-Naik diede in uno scroscio di risa, che fece fremere il maharatto fino in fondo all’anima.
– Ma padrone, sta’ zitto! – supplicò Kammamuri, che udiva il maledetto animale saltare furiosamente sul limite della jungla.
Il delirante lo guardò con occhi semi-chiusi e proseguì a voce più alta: – Era notte, notte molto buia, io scendevo dall’alto e sotto di me vagava la visione. L’ho udito il profumo cadere sulle pietre. Perché, crudele, adorare quella divinità? Non mi ami tu adunque?… Tu sorridi, ma io fremo. Tu sai quanto ti ama il cacciatore di serpenti. Avrei forse un rivale? Guai a lui!… Guarda che si avvicinano i maledetti… ridono, sghignazzano e mi minacciano… via di qui, via, assassini, via, via!… Hanno ancora i lacci, li gettano… aspettate che io vengo… La vendicherò, assassini, eccomi!… Kammamuri! Kammamuri! mi strangolano!
Il delirante si alzò a sedere cogli occhi stralunati e la schiuma alle labbra e tendendo il pugno chiuso verso il maharatto gridò:
– Sei tu che vuoi strangolarmi? Kammamuri, dammi le pistole che lo accoppi.
– Padrone, padrone, – balbettò il maharatto.
– Ah tu… non sai chi sono? Kammamuri, mi strangolano!… Aiuto!… aiu…
Il maharatto gli soffocò le grida, mettendogli rapidamente una mano sulla bocca e rovesciandolo a terra. Il ferito si dibatteva furiosamente ruggendo come una fiera.
– Aiuto!… – tornò ad urlare.
Dalla parte degli alberi si udì un potente grugnito. Il maharatto, tremante di spavento, vide il muso triangolare del rinoceronte far capolino fra le fronde. Si tenne per perduto.
– Grande Siva! – esclamò, raccogliendo in furia la carabina.
Il rinoceronte guardò il gruppo coi suoi occhietti piccoli e brillanti, ma più con sorpresa che con collera.
Non vi era un istante da perdere. Quella sorpresa non doveva durare molto, per quel brutale colosso, che tanto facilmente si irrita.
Il maharatto, reso ardito dall’imminenza del pericolo, puntò freddamente la carabina, mirò uno degli occhi e lasciò partire la scarica, ma la palla mal diretta si schiacciò sulla fronte del rinoceronte, il quale tese orizzontalmente il corno preparandosi ad assalire.
La perdita dei due indiani era ormai quasi certa. Ancora pochi minuti e avrebbero subìta la medesima sorte della tigre.
Fortunatamente Kammamuri non aveva perduto il suo sangue freddo. Visto l’animale ancora in piedi, lasciò cadere l’arma diventata inutile, si precipitò sopra Tremal-Naik, lo sollevò fra le sue braccia, corse allo stagno e saltò dentro, sprofondando fino alle spalle.
Il rinoceronte caricava allora con furia irresistibile. In quattro salti varcò la distanza e piombò pesantemente nell’acqua, sollevando uno sprazzo di fango e di spuma.
Kammamuri, atterrito, cercò di fuggire, ma non lo poté. Le sue gambe si erano affondate in una sabbia tenacissima e in modo tale, che ogni sforzo riusciva inutile.
Il poveretto, mezzo asfissiato, tremante, pallido, gettò un urlo straziante:
– Aiuto! Son morto!…
Udendo dietro di sé sordi fischi, si volse e vide il rinoceronte dibattersi furiosamente e avventare a destra e a sinistra tremendi colpi di corno. Il colosso, trascinato dall’enorme peso, era affondato fino al ventre e continuava ad affondare nelle sabbie mobili.
– Aiuto!… – ripeté il maharatto, sforzandosi di mantenere fuori dall’acqua il padrone.
Un lontano latrato rispose alla disperata chiamata. Kammamuri trasalì: quel latrato l’aveva udito ancora e non una, ma mille volte. Una pazza speranza gli balenò in mente.
– Punthy!… – gridò.
Un cane nero, vigoroso, grosso, sbucò dalla fitta massa di bambù e corse verso lo stagno latrando con furore. Quel cane che arrivava in così buon punto, era proprio il fedele Punthy, il quale lanciossi contro il rinoceronte tentando di azzannargli un orecchio. Quasi nel medesimo istante si udì la voce di Aghur.
– Tieni fermo, Kammamuri! – gridava il bravo giovanotto. – Ci sono!…
Il bengalese con un salto varcò una fitta macchia, scomparve fra i bambù e riapparve sulla riva dello stagno. Armò rapidamente il fucile, si mise in ginocchio e sparò contro il rinoceronte, il quale, colpito nel cervello, cadde su di un fianco, scomparendo più che mezzo sott’acqua.
– Non muoverti, Kammamuri, – proseguì il destro cacciatore. – Ora compiremo il salvataggio; ma… Cos’ha il padrone?… È forse ferito?
– Taci e spicciati, Aghur, – disse il maharatto, che tremava ancora. – Nella jungla vagano dei nemici.
Il bengalese sciolse in fretta la corda che cingevagli il dubgah e gettò un capo a Kammamuri che l’afferrò solidamente.
– Tieni fermo, – disse Aghur.
Radunò tutte le sue forze e cominciò a tirare. Kammamuri si sentì strappare da quelle tenaci sabbie e trascinare verso la riva, sulla quale frettolosamente si arrampicò.