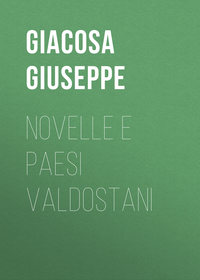Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Novelle e paesi valdostani», sayfa 14
LA LEGGENDA DEL PICCOLO SAN BERNARDO
Interrogato una volta dagli ufficiali dello Stato Maggiore Sardo, che nome avesse la giogaia che separa il Monte Bianco dalla Valle del Piccolo San Bernardo, il rettore dell'Ospizio rispose:
– Si chiama: «Miravidi».
Era il nome che egli nella caldezza del suo amore per quell'Alpe le aveva imposto, che aveva serbato fino allora per sè solo, godendosi la dimestichezza di fare a nomignoli colla montagna; ma venutogli il destro di registrarlo e di eternarlo forse sulle carte, egli lo aveva colto di volo colla prontezza accorta degli innamorati che hanno sempre sveglia la cura esaltatrice.
Il nome di Miravidi fu segnato, credo, su qualche carta e meriterebbe di essere su tutte. Quella costiera vide infatti e vede tuttavia mirabili cose, non mai viste altrove.
Vede la gola stretta e scura che fu chiamata l'Allée Blanche dalla doppia cintura di nevati che la fascia: vede l'azzurro lago di Combal, più cangiante che un cielo estivo in giorno tempestoso, nel quale il ghiacciaio della Brenva immerge i suoi procellosi cavalloni rassodati, e dove sorsero forse gli ultimi ripari del popolo dei Salassi, che vanta le ultime resistenze opposte in Europa alle Aquile Romane. Vede foreste fitte di quanti alberi poterono i secoli seminarvi, dove biancheggiano qua e là, cadaveri secolari, stranamente paurosi, i tronchi fulminati delle Arollee dei Larici. E vede levarsi dalla sua più bassa radice e quindi giganteggiare più che da ogni altra parte, la mole ossuta del Monte Bianco, che scende per dorsi e gradi in Savoia e piomba a picco in questa primissima valle d'Italia. Le cime che da Chamonix e più lungi da Ginevra appaiono ammorbidite dal cuscino delle ghiacciaie, mostrano alla giogaia di Miravidi le coste taglienti e travagliate dai fulmini. Di là sono vette, di qua, creste; di là, il monte s'adagia e oscura il cielo col profilo bianchissimo dalle curve larghe e gravi, di qua s'erge e frastaglia l'orizzonte con una selva di torri, di pinnacoli, di antenne colore del rame. Nessun altro dei grandi gruppi Alpini, nè questo da altri versanti, spiega così intera la smisurata faccia de' suoi fianchi. Le vallate per lo più procedono perpendicolari od oblique all'asse del monte che le sbarra, cosicchè di questo non appare a chi le risale se non lo spazio compreso fra le due chine che le fiancheggiano. Qui ai piedi del Monte Bianco corre un vallone parallelo al suo asse: dalle vette di Miravidi l'occhio ne abbraccia tutta la distesa, misura tutta la base da gigante, vede scintillare tutte le acque che esso versa in Italia.
Dalla parte di mezzodì si affaccia alla costiera di Miravidi, la verdissima valle del Piccolo San Bernardo; la più corta, la più varia, fra quante sono tributarie della Dora Baltea, dominata dalle ghiacciaie del Ruitor le cui acque formano in alto il lago di Santa Margherita e scendono poscia nella fertile conca della Thuille per via di stupende cascate fra i boschi.
Donde viene quel nome di Ruitor? Di quale termine celtico o gaelico è derivato? Il linguaggio alpino è pieno di tali vocaboli, discesi coi secoli e vincitori delle lingue moderne, delle barbariche e ciò che più conta della latina: parole che sotto l'involucro delle nuove desinenze serbando il nocciolo antico, ci recano la voce e in parte rispecchiano l'animo dei primissimi stabili abitatori di queste regioni. Si direbbe che la robusta struttura delle terre durate senza mutamento al passaggio dei secoli, abbia irrobustito le parole primamente adoperate a significarne gli accidenti: e, come l'Alpe si chiama Graja dalla voce celtica Grau (grigio biancastro) e la catena che vi s'allaccia verso Oriente, è detta Pennina, da Pennche dal celtico significa: sommità e Dora, proviene da Dour (acqua) e moltissime altre ve ne hanno che io ignoro e sanno i filologi, e più ancora che sa il popolo ed i filologi non sanno.
Già ai tempi di Roma si disputava intorno l'origine di tali nomi. Tito Livio al Libro XXI, Cap. 38, raccoglie e confuta l'opinione che la voce Pennina derivasse da Punica per essere Annibale passato in Italia traversando l'Alpe di quel nome, locchè certo non fece, e che il nome di Alpe Graja, dato all'attuale Piccolo San Bernardo provenisse da Greca per esservi passato Ercole Tebano. Qui comincia la leggenda del Piccolo San Bernardo: leggenda, non storia; in causa appunto di questo favoloso passaggio di Ercole. Plinio secondo ne discorre come di voce in gran credito, e al popolo dei Salassi che abitava queste regioni, vantano alcuni la discendenza da un Cordelus, figlio di Statielo, che si vuole fosse uno dei capi dell'esercito di Ercole, quando il semi-dio traversò l'Italia. Ercole valicò dunque il colle del Piccolo San Bernardo? Se mai, fu tornando dalle favolose colonne, dopo di avere congiunto insieme il Mediterraneo e l'Oceano. Vi andò seguendo la costiera Libica; ne sarà tornato per Spagna e Gallia, donde per l'Alpe Graja o per il Colle di Tenda sarà sceso in Italia. Ma il viaggio ed il valico sembrano piuttosto una mera favola dei Romani ellenizzanti; favola ispirata forse dalla maravigliosa asperità di queste regioni. Se è vero che ai tempi di Cesare, una strada carreggiabile valicasse il giogo del Piccolo San Bernardo (Alpis Graja) si capisce come i Romani affacciandosi la prima volta a questo robustissimo nodo alpino e vedendo già domata dall'uomo la selvatichezza dei luoghi, abbiano attribuito la stupenda opera ad Ercole.
Prima di Cesare e prima di Annibale, superarono questo giogo torme armate di Galli chiomati ed erano frequenti i commerci fra gli abitanti della Tarantasia (Centroni) e quelli della Val d'Aosta (Salassi). Vi passò Annibale? Gli storici romani, non nominano i luoghi donde egli scese di Spagna per le Gallie in Italia, e perchè si contentano di descriverne l'aspetto e perchè le montagne, dal più al meno, si somigliano tutte; ogni valico alpino, da quello di Tenda al Gottardo, vanta quel passaggio ed in ognuno di essi i disputanti eruditi, trovano caratteri locali che, le elastiche interpretazioni aiutando, corrispondono ai testi. La disputa ferveva ai tempi di Seneca, nè è verosimile che sia mai definita, se qualche carcassa d'elefante o molti scheletri umani riconosciuti di razza etiopica, scavati un giorno a caso in qualche gola alpina, non faranno testimonianza del vero. La cosa non è assolutamente impossibile, nè improbabile, perchè il giorno prima di affrontare l'ultimo giogo, l'esercito cartaginese cadde e lo superò, in un agguato tesogli dalle popolazioni indigene, e vi lasciò morti uomini e bestie da soma. Comunque sia, in favore del Piccolo San Bernardo, oltre le solite corrispondenze, che è facile rintracciare dovunque, sta il fatto dell'agevole strada e la affermazione di L. Celio, il quale, a soli cinque anni dalla discesa di Annibale, scrive che questi passò per Cremonis jugum nel quale Cremonis jugum si ravvisa il Monte Crammont, ultimo della catena di Miravidi, all'ombra del quale chi scende in Italia dal Piccolo San Bernardo, deve per forza passare. Ciò basti, se non alla storia, alla leggenda del Piccolo San Bernardo e scusi gli abitanti delle terre vicine, se chiamano: Cerchio d'Annibale, un cerchio druidico, tuttora visibile sulla spianata presso l'Ospizio.
Il Monte Bianco, la cui testa, il Penn gaelico, soverchia la costiera di Miravidi e sta spiando oltre nella valle, avrebbe dunque veduto passare le schiere Puniche, i cavalieri Numidi e le nuove moli degli elefanti. E, ad Annibale, se vi passò, e a Cesare, il quale vi passò di certo, apparve da quelle cime la stessissima vista che noi vediamo, non mutata affatto nè di forme, nè di colori, nè di misure, nè di minutissimi particolari. Locchè con altrettanta esattezza non si può dire di altri luoghi, fuorchè del mare al largo donde non si scoprono terre, o ne appare solamente il profilo. Le costiere o presero o perdettero spazio, si aprirono porti o si chiusero, s'internarono alcune città litorali, e, delle rimaste, variò affatto l'aspetto ed il colore. Le pianure, o furono tosate di foreste o imboschirono e fruttificarono per diverse colture. Chissà se date le spalle ai monti della Sabina, Coriolano più riconoscerebbe la campagna romana? Dovunque entra come elemento del quadro, l'opera dell'uomo, il quadro è in tutto od in parte mutato e sulle Alpi stesse altri valichi somiglianti, causa l'indole diruta delle roccie, mostrano ora nuovi scoscendimenti e nuove rovine. Qui, grazie il loro dolce pendìo non è verosimile che le chine circostanti, abbiano addolcito o inasprito il primitivo profilo; nè mai su queste cime crebbero alberi, nè vi germogliò altro che l'erba fitta dei prati. I secoli vi passarono senza lasciare traccia, senza abbattere e senza edificare; il suolo ha una immobilità morta: nulla trasforma e nulla cancella. Sulla grande spianata della sommità, le pietre che segnavano il tempio druidico, emergono ora dalla terra come già emersero quando vi convenivano i Salassi preganti. Oramai è corso un secolo dall'anno che il mal guidato esercito piemontese invernò attendato su quelle alture, impotente difesa regia contro le schiere della prima repubblica francese; e il suolo serba ancora le traccie d'ogni tenda, sicchè si può contarne il numero e aggirarle tutte quante e discernere dalla diversa impronta le tende capitane dalle soldatesche. Le erbe di cento estati rinnovati, i venti e le nebbie di cento autunni e di cento primavere, le nevi di cento inverni, non valsero, non che a colmare, a far meno profondi i fossatelli incisi intorno quelle fragili dimore di tela. Fida terra che nella sua povertà ha tanta tenacia di memoria, terra amica della storia e degna di storia, dove l'uomo può segnare le sue gesta in un piccolissimo solco, più durevole che non furono altrove i portici, i fori, le terme, i circhi e gli altari! Di lassù si può dire, che la più chiara e sicura contezza che abbiamo di Cesare è questa: Cesare vide quanto noi qui vediamo. La Mansioneromana ora distrutta, non esisteva ancora ai tempi di Cesare. Fu eretta, credesi, da Augusto e anticipò al mondo i miracoli di carità per cui è santificato Bernardo da Mentone. A mille anni d'intervallo, la previdenza civile di Roma e la pietà religiosa di un monaco, riuscirono qui all'opera istessa: all'Ospizio dei viandanti. Vide Cesare la colonna che sorge tuttavia sulla vetta del colle? La tradizione lo afferma, lo negano gli eruditi. La leggenda vuole che la colonna fosse prima consacrata al Dio Penn il Dio delle sommità, l'altissimo inaccessibile e che l'occhio del Dio vi sovrastasse in forma di gemma dotata di virtù taumaturgiche. Oggi ancora qualche pastore più credulo o più immaginoso dei compagni, va cercando per le petraie, se mai rinvenisse il divino occhio, che salverebbe dalla cecità il genere umano. Gli eruditi in quel masso di marmo cipollino, alto sette metri per un metro di circuito, ravvisano un'opera romana. La colonna non ha fregi nè ordini; è rude e salda. Qualche volta l'inverno, la neve, la seppellisce intera, poi la rende intatta al sole. Seguendo la leggenda, più Dei eterni le diedero nome e morirono. Dal culto di Penn passò a quello di Giove e si chiamò da Giove tutta la montagna, poi resse la croce e fu segno del vicino ricovero ai viandanti assiderati e smarriti. Chissà a quali altri simboli è destinata, chissà in che diverse lingue sarà chiamata, nelle quali rintracceranno i curiosi gli elementi delle nostre, come noi nelle nostre, quelli delle galliche e della latina!
Dopo Cesare, gli eserciti romani valicarono più volte il colle del Piccolo San Bernardo. Vi correva la grande strada militare, che da Milano, metteva a Vienna nel Delfinato. Vi passò Gondicaro a capo dei Burgundi; vi passò forse solo, povero ed esule, Adalberto, figlio virtuoso (se non gli fu attribuito a virtù il non essere salito al trono) del turbolento Berengario, marchese d'Ivrea e re d'Italia.
Verso il mille, quando il terrore del finimondo, le frequenti pestilenze e le carestie, volsero in Europa gli animi e le opere alla pietà ed al fervore religioso, e furono veduti re ed imperatori aspirare e darsi al monacato, un santo savoiardo, sui ruderi forse della Mansione romana, edificò il nuovo Ospizio pei viandanti. Ospizio e fortezza forse ad un tempo, contro i Saraceni che infestavano le valli di Savoia e del Vallese. Dei Saraceni sull'Alpe Graja, non è memoria, ma Bernardo di Mentone sembra averli guerreggiati in quel luogo stesso dove innalzò il maggiore de' suoi Ospizi; sul Monte Giove, che fu poi il Gran San Bernardo. Approdavano sulla costa Nizzarda, donde per la Provenza ed il Piemonte, erano saliti fino in Savoia, in Moriana, in Tarantasia e sul lago di Ginevra o nel Vallese. Così occuparono i maggiori valichi dell'Alpe marittima della Cozia e della Pennina: il Monte Ginevra, il Cenisio ed il Monte Giove. Padroni della Tarantasia e della Valle d'Aosta, dalla quale mosse a snidarli nel 942, re Ugo di Provenza, è certo che essi tennero il passo che congiungeva le due Provincie, e, se Bernardo da Mentone li combattè sul colle di Giove, è probabile che volendo liberarne la Valle d'Aosta, essendo egli arcidiacono in quella Cattedrale, li affrontasse pure sull'Alpe Graja.
Chissà che il pacifico ricovero, non sia stato dapprincipio edificio prettamente belligero; locchè non contrasterebbe nè al suo carattere religioso, ne alla sua benefica destinazione. Siamo in tempi in cui la spada poteva essere insieme arme di guerra e segno di fede cristiana, ed è ovvio credere che fra i seguaci del santo combattessero quegli stessi, che, cacciati gl'infedeli, si assoggettarono di poi alla rigida disciplina monacale e si proposero come còmpito quotidiano, continui miracoli di abnegazione e di carità. Da quel tempo il Piccolo San Bernardo ebbe normali abitatori, se non che ne venne a poco a poco scemando il numero, sicchè la casa eretta per convento, finì in romitaggio.
E seguitò nel corso dei secoli la tragica sfilata degli eserciti ai quali un tale valico dovette riuscire spesso più faticoso e micidiale che una battaglia. Durante due secoli, il XIII ed il XIV, in luogo dei soldati sfiniti e sbigottiti, l'Ospizio vide passare con norma consueta, le fastose e gioconde cavalcate dei Conti di Savoia che si recavano in gran pompa di Ciamberì in Aosta a tenervi le corti di giustizia.
Ogni sette anni il Sovrano superava il colle e scendeva, con signoresca accompagnatura, nelle terre de' suoi fedeli vassalli Valdostani. Quel valico consacrava la sua sovranità. Entrando in Val d'Aosta per il passo del Piccolo San Bernardo, il Conte di Savoia trovava sul confine tutta la nobiltà della valle, radunata a fargli omaggio. Se giungeva per altra via, non gli era dovuto alcun solenne ricevimento. Quella era la via sacra, la sola degna di passarvi principescamente il principe, di meritare al principe l'omaggio della sudditanza. Appena varcato il confine, ogni castello era rimesso nelle sue mani, non già con lustra esteriore, ma sibbene con propria ed efficace consegna, tanto che, ad ognuno di essi egli deputava speciali governatori, che lo occupavano nel suo nome finchè egli soggiornava nella vallata. Così, dinanzi la sua pacifica magistratura, i piccoli ed i grandi vassalli deponevano il potere e l'alterigia. Nè tale rinunzia era dei soli litiganti, ma di quanti sedevano col sovrano nella corte di giustizia; nè costituiva una prestazione feudalesca dovuta al Sovrano. Sovrano era il Conte di Savoia in Valle d'Aosta, sempre e per qualunque via vi accedesse, ma solo passando per il Piccolo San Bernardo, egli esercitava della sovranità, la più sacra prerogativa, la giudiziaria, e a quella sola i signori Valdostani concedevano la totale rinunzia delle proprie forze.
Nel 1600, Carlo Emanuele I guidò per l'Alpe Graja 10,000 soldati, diretto alla terra di Mommegliano in Savoia, che trovò occupata dagli eserciti di re Enrico IV. Nel 1630 vi salì, di Savoia, il principe Tommaso di Carignano, perseguito dalle soverchianti forze del re Luigi VIII; valicato il colle, si accampò sulla montagna che fronteggia il villaggio della Thuille, dove appaiono ancora i resti dei suoi ridotti. Nel 1691, regnando Vittorio Amedeo II, un esercito francese comandato dal marchese De la Huguette, scese per quel valico in Valle d'Aosta, arse quanti villaggi trovò per strada, devastò e pose a sacco la città di Aosta, scorrazzò le terre e tornò con ostaggi in Savoia. Tornano i Francesi dopo tredici anni guidati dal La Feuillade, raggiungono a Bard il Vendome, occupano tutti i castelli, tengono per due anni la valle sotto il retto ma doloroso governo del marchese di Kercado, e finalmente ne sgombrano l'anno 1706, dopo la battaglia di Torino, riconducendo seco i nuovi reggimenti del marchese De Vibrave scesi pur ora dal colle.
E qui per dieci anni segue un continuo valicare e rivalicare di soldatesche d'ogni gente e d'ogni maniera, non sempre nemiche ma sempre infeste. Al villaggio della Thuille, il primo che s'incontri scendendo dal Piccolo San Bernardo in Italia, durano anche oggi il terrore e la memoria di lontane stragi e rapine; io intesi ancora raccontare lungo la valle una grande vittoria che una mano di contadini riportò, ora sono assai più di cent'anni, su di un formidabile esercito francese. Si tratta credo della resistenza opposta l'anno 1708, nella stretta di Pierre-Taillée, al marchese di Mouroy ed ai suoi quattro o cinquemila soldati. I Francesi, occupata la Valdigne, cioè l'alto bacino che comprende i villaggi di Entrèves, Courmayeur, St-Didier, Morgex e La Salle, volgevano verso Aosta; alle chiuse di Pierre-Taillée, gli abitanti delle terre vicine e pochi soldati, sbarrarono loro il passo. Il luogo è tale da non potersi a forza superare senza grandissima strage; il Mouroy, fallitogli il primo impeto, abbandonò l'impresa, sgombrò la Valdigne, e il Piccolo San Bernardo lo vide tornarsene scornato in Savoia. Vera battaglia non vi fu; ma i difensori, benchè scarsissimi di numero, avrebbero avuto animo e campo da sostenerla e da trionfarne. Nessuno dei valligiani rammenta ora il nome del capitano nemico, nè la data dell'impresa, nè la cagione della guerra; ma il fatto smarrito in una incerta nebbia leggendaria, amplificato dagli anni, prende nelle loro menti una grandezza epica, e il luogo, già più aspro e solenne delle Termopili, diventa altrettanto glorioso.
Nel 1742, Carlo Emmanuele III guadagna il Piccolo San Bernardo con un fiorito esercito e scaccia di Savoia gli Spagnuoli. Carlo Emmanuele conosceva il valico; vi era passato undici anni addietro, quasi solo, pensieroso e presago forse degli imminenti drammi domestici. Veniva di Ciamberì e affrettava verso Torino temendo non ve lo precedesse per il Moncenisio il padre Vittorio Amedeo, geloso di riprendere l'abdicato potere. Triste sorte che tale dissidio dovesse nascere fra tali sovrani, degni tutti e due del trono, ultimi gloriosi fra i rampolli del ramo diretto di Savoia. Dopo di essi fino al regno di Carlo Alberto lo Stato cadde in miserrimi principi. L'ultima, la più triste fra le notevoli memorie del Piccolo San Bernardo è documento della loro insipienza. Fino allora le torme armate affrettavano per l'ardua montagna, premurose di scansarne i pericoli, già terribili al solo passaggio: nessuno aveva mai osato attendare un esercito in tali luoghi e mantenernelo per l'invernata. Chi può dire i disagi, gli stenti, il freddo, le malattie, gli scoramenti patiti dalle milizie piemontesi durante l'inverno del 1793? In regioni, dove le spesse muraglie della casa, le doppie vetriate, le tavole che fasciano le pareti di ogni stanza, sono impotente difesa contro la violenza delle bufere, o lo stagnare delle gelide nebbie invernali; tende di tela o baracche di assi mal connesse, erano tetto e casa a soldati mal nutriti, mal vestiti e peggio guidati. Non li sosteneva nè la speranza di prossime vittorie, nè la fiducia nei capitani, nè l'esempio dei principi. Comandava un austriaco, salito agli alti gradi militari per perizia diplomatica, più curante di infeudare all'Austria il regno Sardo, che di combattere il comune avversario repubblicano. E mentre sulla spianata e sui fianchi del colle il vento divelleva le tende e la neve turbinando spegneva il fuoco dei bivacchi, mentre la canna gelida dei fucili spellava le mani ai soldati e le orribili malattie dei paesi nordici spopolavano il campo, il duca di Monferrato vi traeva seco un seguito di cinquanta domestici, due dei quali specialmente destinati a preparare il caffè della Sua Altezza Reale.
Qui finisce la triste storia del Piccolo San Bernardo. Il frequente scorrazzare di eserciti nostrani e stranieri fu a questi monti più causa di danno che di gloria. Il loro valico non fu mai interamente conteso ai soldati che vi salivano da questa o da quella parte; le sorti delle guerre non si decidevano fra queste gole selvaggie: nessuno di questi luoghi ebbe il gramo compenso di dar nome a giornate famose. La loro oscurità non li salvò dalla rovina, la rovina infeconda non li additò alla gratitudine della storia. Calpestate, devastate, dissanguate, arse, queste terre, che diedero agli eserciti piemontesi i migliori soldati, non ne ebbero onori di lapidi e di monumenti; il detto: felici i popoli che non hanno storia, fu loro per più secoli bugiardo.
Ora, da molti anni, la pace dell'Ospizio non è turbata; la casa ospitale esercita quietamente il suo sacro ministero. Le balze echeggiano l'estate per colpi di cannone, e sulle creste, dove parve temerario il camoscio, corrono ordinate e sicure le compagnie alpine; ma la loro presenza non è minacciosa, ma i villaggi le salutano con grida di gioia. Studiano nell'Alpe la grande fortezza italica, e forse, quando un nuovo esercito straniero salisse a tentarlo, il valico sarebbe ora, per la prima volta, difeso e conteso. Una battaglia su quelle alture sarebbe titanica, ma alla gloria di quell'Alpe non occorre sangue. La sua gloria è quella casa che per secoli combattè e disarmò la nemica natura. E già, anch'essa ha quasi compita l'opera sua. La scienza vinse la pietà: sotto il tunnel del Cenisio e del Gottardo, passa in un giorno più gente, che non ne pericolò in otto secoli sulle giogaie del Piccolo e del Grande San Bernardo.