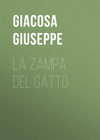Kitabı oku: «Novelle e paesi valdostani», sayfa 6
UN PRETE VALDOSTANO
Un giorno che i cinque curati della vicaria desinavano nella canonica di X, dove li raccoglieva una delle consuete conferenze primaverili, il curato di X m'invitò a tener loro compagnia a pranzo.
È difficile incontrare un prete che non somigli qualche altro prete: dei cinque miei commensali quattro mi ricordavano visi, portamenti, movenze ed accenti mille volte veduti ed uditi; ma uno differiva assolutamente da ogni tipo conosciuto per l'addietro. Era un gobbo, che mostrava nell'aria marziale una salute di ferro ed una forza fisica ragguardevole; le gambe lunghe e diritte ed il busto incurvato formavano una persona alta rimpicciolita, potrei dire un gigante nano. In complesso era piccolo ma spaccava passi lunghissimi ed avrebbe abbracciato un noce di vent'anni. Aveva i capelli grigi, quasi bianchi, la fronte spaziosa, gli occhi vivi ed accorti, il naso grosso e ai lati della bocca un solco lungo e profondo. La bocca esprimeva una bontà divina ed una giovialità continua e misurata. Insomma una testa nobile e virile la quale, meglio che correggere, faceva dimenticare la bruttezza del corpo.
A capo di tavola sedette il vicario con me a destra ed il curato d'X a mancina; dopo di questi veniva un grosso prevosto che russava da sveglio e poi il gobbo che ho detto, cosicchè la tavola essendo rotonda, il gobbo mi sedeva quasi dirimpetto.
Fu il solito pranzo di preti; il vino frizzante del paese sciolse ben presto l'imbarazzo cagionato dalla mia presenza e il latino degli aforismi gaudenti mise nei discorsi una malizia corpacciuta e sensuale. I motti si aggiravano intorno ad un tema unico: la vigilanza che spettava al vicario sugli altri quattro tonsurati.
A sentirli, il vicario saliva sulla torre della chiesa vicarile donde dominava le quattro soggette parrocchie; ma quella torre ne vedeva delle belle! Il vecchio vicario glorificato per peccatacci ai quali era da gran tempo insufficiente, lusingava di rimbalzo con eloquenti reticenze la vanità erotica de' suoi accusatori, ammiccando gli occhi ed ingrossandoli, allungando le labbra ad una smorfia incoraggiante di rimprovero esagerato. Poco alla volta i traslati erano diventati d'un ardimento pazzo. Le più pure ed immacolate parole toglievano uscendo da quelle bocche un senso vizioso, del quale molte volte chi le aveva profferite s'accorgeva al clamore degli applausi che suscitavano intorno.
La torre della chiesa vicarile tornava in campo ogni momento; dicevano che per vederci meglio il vicario ci saliva in buona compagnia, e se la torre non era crollata finora, ne potevano venire dei terremoti. Oh lo sapevano tutti! Il vicario, per non essere distolto dalla sua vigilanza, giunto in cima, tirava a sè la scala a piuoli che mette all'ultimo ripiano, dove pendono sospese le campane, e al campanaro toccava spesso ritardare un'agonia a profitto dei sani. Una volta nominate le campane, fu affar finito e non se ne uscì più. Ogni parte di esse fu specificata, ogni loro funzione descritta a suono di enormi risate, a sentire le quali chi aveva parlato, ristava un momento, guardava in giro in atto di furba maraviglia, e poi diceva: Che cosa ho detto? e ripeteva la frase, e quando gli altri tornavano a sbellicarsi dalle risa, volgeva gli occhi al cielo con aria scandolezzata, giungeva le mani e sclamava: Che gente! Che gente!
Così durò il pranzo, suonando ciascuno a distesa il grande inno della malizia sporca ed untuosa, finchè dopo tre ore tutti ci levammo e il grosso prevosto russante si tirò dietro incollata alla madida sottana la scranna coperta di tela incerata.
Il gobbo aveva riso cogli altri, ma pareva più ridere del loro riso che dei loro discorsi. Qualche volta nelle pose della bufera bacchica, insinuava un frizzo salato corbellando le tardive effervescenze degli interlocutori, con frasi brevi, sugose, che andavano diritte alla mira. In mezzo alla volgarità trionfante di quei panciuti la satira sottile del gobbo mordeva con una eleganza tutta cittadina e starei per dire letteraria; ma quello che più mi colpiva di lui era la sincerità infantile del ridere, quando rideva davvero. Pareva un fanciullo, rideva tutto quanto, da capo a piedi, fino alle lacrime, senza sforzo, contento di ridere, tornando a scoppiare fresco come prima, non appena rivolgesse in mente il fatto o la parola che gli avevano dato l'aire.
La giornata che il mattino prometteva bellissima, poco alla volta s'era oscurita. Quando ci levammo di tavola il vento cominciò a far ballare i vetri, quando ebbimo bevuto il caffè cominciò a nevischiare. S'era in fine d'aprile. Giù per i vigneti che scendono sino alla Dora sorgeva dal terreno ghiaioso e fra le catene brune dei vimini qualche albero sottile di mandorlo o di pesca, tutto fiorito e di là dalla Dora, nei prati, sull'erba arsa dall'inverno, vinceva il verde tenerissimo dei fili spuntati di fresco e si allargavano le foglie già spiegate delle malve e delle primavere. Povera campagna! La neve, asciutta e dura come grandine, rigava l'aria obbliquamente, portata dalla bufera e rendeva, percotendo i rami nudi e gli stecconi delle pergole, mille piccoli scricchiolii secchi come fa la carta da parato quando per vento si stacca dal muro. I mandorli fioriti, dei quali il candore muto della neve faceva risaltare la bianchezza carnosa piena di vita, e i peschi rosati si agitavano furiosamente, seminando le tenere foglioline che il vento aggirava, sollevandole in spire vorticose.
Per certo, a vedere quel tempaccio, le serve dei curati rimaste in casa si partivano o mandavano il campanaro, coll'ombrello, all'incontro del padrone. Tanto valeva aspettarle all'asciutto.
La stanza, benchè senza fuoco, era intiepidita dal fiato ben nutrito dei commensali che i morbidi odori di cibo contribuivano colla faticosa digestione ad impigrire. I vetri verdognoli mandavano una mezza luce quieta, affievolita ancora dal loggiato ad archi sul quale mettevano due finestre, mentre una terza che si apriva verso il vecchio camposanto, una delizia di cortiletto chiuso da alte muraglie, lasciava a mala pena entrare un barlume di giorno, un chiarore da chiostro, da sagrestia, o da stalla.
Due dei curati, con una padronanza tutta pretina, ebbero ben presto sparecchiato e rimessa ogni cosa a suo posto, senza dir verbo. Poi stesero il tappeto sulla tavola, tolsero dal cassetto dello scrittoio, dove era chiuso col breviario, un mazzo di tarocchi ed uno di essi lo brandì in alto agitandolo, poi lo gittò sapientemente sulla tavola in modo che le carte vi si distesero in riga allineate, e gridò in tono di comando: Pontificemus.
Il vicario dormiva in una larga sedia a braccioli, la testa rovesciata sul muro, coll'aria tranquilla di un santo.
Il gobbo non volle essere del giuoco, ed io non conoscevo le carte. Gli altri tre preti si precipitarono sui tarocchi e la partita fu intavolata vigorosamente. Le carte grasse ed unte aderivano l'una all'altra così che per staccarle occorreva ai giuocatori inumidire il pollice al labbro inferiore, rovesciandolo fin sopra il mento. Nel silenzio della stanza si sentiva di quando in quando la nota da scacciapensieri che mandavano le dita attingendo umori e poi il fioccare misurato e piano delle carte sul tappeto.
Il gobbo tamburellò un momento sui vetri, vi appoggiò la fronte come per rinfrescarla, poi prese il cappello ed il bastone e con un: Buona sera risoluto, piantò la compagnia.
Benchè a tavola e dopo non avessi scambiato con lui che poche parole, mi era nato un vivo desiderio di conoscerlo; gli tenni dietro senza altro, e lo inseguii per una stradicciuola fra i vigneti ch'egli aveva infilato frettolosamente. Al rumore de' miei passi si voltò e vistomi, ristette sorridendo.
– Viene anche lei dalle mie parti?
Come gli ebbi detto che non potevo reggere oltre al tanfo della stanza chiusa e che gli chiedevo licenza di accompagnarlo, mi ringraziò e ci ponemmo in cammino, ma per un buon tratto di via non aperse bocca; lo sentii anzi più volte fissarmi sospettosamente con una certa durezza, tanto che, venuto in dubbio di riuscirgli importuno, rivolgevo meco stesso il migliore pretesto per congedarmi.
Ad un tratto si fermò e mi disse:
– Le assicuro che sono tutti buoni preti e buoni curati.
Si era fatto rosso in viso e mi guardava negli occhi con una fissità risoluta, scrutandomi se gli prestavo fede: convien dire che le mie parole valsero a tranquillarlo, perchè lo vidi rasserenarsi e rifarsi tosto cordiale.
Seguitava a rigirare per l'aria un nevischio rado ed asciutto a piccoli grani rabbiosi, che sembravano voler forare là dove picchiavano; uno di quei tempi ventosi dal cielo eguale e lontano che lasciano vedere le più alte cime allividite dalla falsa luce nebulosa. Il mio curato camminava spedito, sollevando sul davanti la vesta e reggendola sul braccio, locchè lasciava dietro uno strascico nero che spazzava la via. Nell'impaccio delle pieghe, le gambe, nettamente disegnate da una calza di grossa lana nera, avevano un disgustoso aspetto femminile come di donna gagliarda e sfrontata; tutta la persona dal tricorno fermamente calcato sulle tempia, contro il vento, alle grosse scarpe rattacconate, mostrava l'incuria propria dei solitari e dei pensatori.
Io avevo cominciato a domandarlo della vita e dei costumi alpestri, ma non era che un rigiro per giungere a quello che più mi premeva e che da lui solo potevo conoscere, la sua propria vita, e come si acconciasse alla solitudine cui era costretto e come la riempisse.
L'idea che mi ero fatto di lui era forse troppo alta e quel senso critico al quale pur troppo dobbiamo affinare le nostre sensazioni ed i nostri giudizi, mi stimolava a verificarne alla prova dei fatti la giustezza o l'errore. Certo nella compagnia dei colleghi egli primeggiava, ma poteva anche essere il monocolo nel regno dei ciechi, mentre io lo avevo sulle prime immaginato di acutissima vista.
Già il vederlo così abbandonato e scorretto della persona me lo aveva fatto cadere dall'animo e provavo una orgogliosa compiacenza al pensiero che in poco l'avrei ridotto al suo essere vero di pretoccolo egoista e beato. E come dava a capofitto nelle mie grosse reti, come mi mostrava passivamente le poche faccie del suo ingegno; lo rigiravo senza fatica, lo stringevo senza metterlo in sospetto, rispondeva ad ogni mia domanda con proposizioni nette, precise, che lo mettevano tutto nelle mie mani.
Non era sciocco, tutt'altro, ma era un uomo contento, una mente quieta e rassegnata. Conosceva assai bene dei paesani, la vita intima, i bisogni, le miserie, le poche gioie, i gravi dolori; ma la sua coscienza non si spigriva per questo, la sua mansueta acquiescenza ai fatti non era turbata. Avevo sperato un ribelle combattuto dalle brutali ingiustizie della vita e dalla tradizionale docilità del proprio ministero, avevo intravveduto una lotta drammatica fra il vescovo e la coscienza, fra il diritto umano e la credenza cieca, mi ero gettato nel mio errore colla gioia ardente del cercatore di miniere che scopre i filoni dell'oro, e vedevo il filone assottigliarsi al primo colpo di piccone e smarrirsi, e una pace scolorita regnare là dove cercavo lo scompiglio di una grande battaglia. Quello che più mi indispettiva era il vederlo abbandonarsi così senza resistenza e rivelarsi intero senza pur cadere in sospetto della mia crescente disistima; ne provavo l'irritante delusione del cacciatore che vede la selvaggina passargli sull'uscio di casa quando egli si disponeva ad inseguirla con gravi fatiche.
Caduto dalle altezze del mio ideale, mi sarei volentieri acconciato ad una lotta di destrezza, avrei voluto vedermi contesa quella conoscenza alla quale intendevo, mettere la mia sottigliezza cittadina in confronto della sua selvatica furberia, insomma ripagarmi del non poterlo ammirar lui ammirando me stesso. – Due o tre volte fui sul punto di lasciarlo senz'altro, e di tornarmene solo e deluso, ma non mi venne mai fatto di girare il discorso ad una conclusione e troncarlo di netto mi pareva scortesia. D'altronde, apprendevo da lui molte nozioni determinate e sicure e, devo pure confessarlo, provavo una certa compiacenza artistica a sentirlo discorrere. Non che fosse eloquente, tutt'altro, ma parlava giusto, chiaro e sobrio; c'era poi nella limpidità del suo pensiero, nella scelta dei fatti narrati, nel giudizio che ne recava forse nelle parole istesse che adoperava, certo nel modo di pronunziarle, una bontà matura e tranquilla, che mi rasserenava l'animo. Calmata la prima curiosità, mi durava quella quiete confidente che infonde in noi la presenza di una persona buona ed intelligente. Oramai, conoscevo il mio compagno come per lunga dimestichezza. Era un uomo pratico, che si adagiava comodamente nella sua solitudine esercitando l'ufficio di curato con metodica coscienza. La molle posatezza di una vita consuetudinaria, aveva sedato in lui fin anche le irrequietezze proprie degli esseri sformati, la gobba non lo irritava, non gli dava quella stimolante sottigliezza, quella incontentabilità che acuisce pervertendole le facoltà mentali. Era forse mansuefatto dalle circostanze facili in cui viveva; non saliva al fanatismo nemmeno per la fede.
Un passo dopo l'altro giungemmo alla sua canonica ed egli mi invitò ad entrare ommettendo i soliti discorsi: «vedrà che miseria, compatirà un povero prete», o che so io. La sua casa grigia gli pareva certo la più confortevole di questo mondo. Infatti la stanzetta dove entrammo, fuori del molle odore di prete pulito che sa di cera, d'incenso, di tabacco da naso e di vecchia pergamena, avrebbe invogliato a dimorarvi in solitudine il più ostinato fannullone cittadino. Le finestre guardavano a picco la gran valle silenziosa sotto la neve fresca, coi paesi bruni riparati a ridosso delle montagne e colla Dora nel mezzo, povera d'acque, lenta, limpidissima, fiancheggiata di pioppi alti e sottili. Una veduta raccolta e varia che saliva fino alle ghiacciaie lontane per una minore vallata aperta dirimpetto, tutta tinta di ruggine, dalle piante nude, fra le quali spiccavano in bianco le linee asciutte di due o tre campanili.
Il curato mi domandò subito se avevo da fare quella sera giù nella valle, e come gli ebbi risposto che no e fu inteso che sarei rimasto a cena ed a dormire, scomparve per avvertirne scusandosene la vecchia domestica, della quale udivo nettamente nell'attigua cucina i passi, la voce asmatica ed il continuo affaccendarsi. Strano personaggio quella domestica! Benchè tenesse il primo posto in casa e tutto facesse capo a lei ed il prete si fosse creduto in obbligo di dirle il mio nome, il mio stato, donde venivo, dove mi aveva incontrato e perchè fossi con lui, non mi venne fatto di vederla pure un momento. A cena, una cenetta saporita, io ero così svogliato che al mio ospite toccava insistere per farmi prendere cibo, e ad ogni invito suo, veniva dall'uscio aperto della cucina una voce rauca e grave: – Chi è che non vuol mangiare? Quel signore? Già, bocche fine, bocche fine. Ehm ehm, bocche fine! – Ma il naso in camera da pranzo non ce lo mise mai e quando pregai il curato che me la facesse conoscere, mi rispose: la poveretta è mezza cieca e non vuole esser veduta da quelli che non può vedere.
Dopo cena riappiccicammo il discorso intavolato per via, io interrogando e rispondendomi il prete colla solita docilità, se non che di quando in quando, certi rigiri di frase, un certo tono di voce, certe occhiate furbe ed indagatrici alle quali non avrei giurato che fosse estranea una punta di canzonatura, mi facevano sospettare che al mio interlocutore fossero questa volta ben chiare le mie intenzioni e l'irriverente concetto che mi ero formato dell'essere suo. Oltre a ciò, sentivo di non essere più padrone del discorso, di non poterlo più girare per il mio verso; mi pareva che le domande che gli rivolgevo, me le mettesse in bocca lui, serrando le sue risposte in modo da non poterne io uscire altrimenti che con una data domanda certo da lui preveduta. Che lavoro faticoso mi toccava di fare per non smarrire il filo della conversazione, intento com'ero a darmi ragione di quell'occulta volontà che mi pareva la dominasse! Che malessere ho provato a quella giostra. Se davvero egli mi leggeva nell'anima, la mia presunzione era ben giustamente punita, poichè egli conosceva me assai più e meglio che non io lui e quella parte passiva e condiscendente che gli era piaciuto di assumere, rendeva più gustosa la sua vittoria e più piccante e ridicola la burletta che mi faceva.
Per levarmi di dubbio, gli domandai perchè egli a sua volta non cercasse di informarsi alquanto dei fatti miei.
– Che profitto me ne verrebbe? e che conoscenza sarebbe la mia? Vedo bene come ci conoscono loro. Quando mi avviene di leggere un libro che tratti di noi, della condizione sociale, dei costumi, dei bisogni dei montanari, provo un senso di vero disgusto, tanto siamo ignorati da quelli stessi che presumono farci conoscere agli altri.
– Ha cercato almeno di darsi ragione di questa mia curiosità?
– Non ne avevo bisogno. Le sue domande me le aspettavo tutte quante dalla prima all'ultima e, me lo lasci dire, nella forma precisa in cui me le ha fatte. E non creda che me ne abbia avuto per male o che il suo modo di giudicarmi mi faccia maraviglia. Per conoscere, non occorre sempre interrogare, basta cercare in noi stessi la ragione delle domande che ci sono rivolte. A questo esercizio ho imparato in qual misero concetto siamo tenuti, non dico noi preti, ma noi solitari. Ma ho fatto di più. Ho seguito il procedere delle idee correnti, anzi ne ho rimontato il cammino. Le interrogazioni intorno alla mia vita, le quali vent'anni or sono erano informate ad un sentimento di simpatia, ad una sorta di ammirazione poetica, ad una curiosità indeterminata, sono ora diventate precise, rigide, hanno alle volte il piglio imperativo del giudice inquirente. Ne ho dedotto che gli uomini universali del piano hanno mutato follia, che una volta popolavano la nostra solitudine di idee poetiche e la credevano eletta da noi spontaneamente o per virtù di un ascetismo che si incontra di rado o in seguito a misteriosi disinganni, mentre ora la considerano quale uno stato imperfetto, e quel che è peggio, ce la imputano quasi a colpa come se con essa intendessimo di sottrarci agli obblighi sociali. Or bene, signor mio, essi avevano torto allora e lo hanno adesso. Noi non siamo nè poetici, nè ribelli; lavoriamo per vivere ad un lavoro che non è certo più disutile del loro ed accettiamo filosoficamente le dure condizioni della vita. Il saper poco di molte cose giova a chi vive fra gli uomini che si dicono colti, ai quali basta di potersi ingannare a vicenda colle apparenze; noi non conosciamo che le curiosità utili, quelle cioè che hanno una ragione determinata e che siamo in grado di soddisfare pienamente. Il giorno che gli umanitari della città avranno tempo e voglia di provvedere ai casi nostri e quindi bisogno di conoscerci, ci troveranno qui pronti a fornir loro quante nozioni saremo venuti via via e studiatamente raccogliendo. Avremo così spianata la strada all'opera loro perchè se il provvedere è dei molti il conoscere è di pochi o di un solo, ed al provvedere occorre anzitutto la conoscenza del bisogno.
Parlava con accento vibrato, staccando una proposizione dall'altra con una virile sicurezza, con un sentimento d'orgoglio dignitoso e misurato, che mi faceva arrossire per la vergogna. Non gestiva. Era ritto in piedi coi due pugni chiusi sulla tavola, la testa alta ed il bel viso buono alquanto pallido. Com'ebbe finito si gettò a sedere e stemmo in silenzio un gran pezzo.
Poi lo richiesi della sua storia e delle ragioni che lo avevano spinto al sacerdozio.
– Oh, una storia singolare, signor mio. S'immagini che feci il cuoco durante parecchi anni. Sicuro. Mio padre era sguattero in un albergo d'Aosta ed io, allevato in cucina e messo al mestiere paterno, entrai appena seppi tenere il mestolo in mano, al servizio di quel vescovo, donde mi tolse la coscrizione. Allora non ero gobbo o così poco che non appariva, il pane di munizione non mi spiaceva, tanto che finita la ferma quando stava per aprirsi la campagna del 48, mi arruolai volontario, fui ferito a Goito e fatto prigioniero di guerra dai Tedeschi. La ferita guarì benissimo ma mi ingobbì per la vita, locchè mi rese inabile al servizio militare e mi strinse, una volta tornato a casa, a riprendere l'antico mestiere e per fortuna mia, l'antico padrone. Ora deve sapere che fino dalle prime scuole dove mi mandava mio padre e nella cucina dell'albergo ed al reggimento, io facevo dei versi, sissignore, dei versi nel gergo valdostano a ritmi semplici ed a rime uniformi, i quali in cucina ed al reggimento, mi avevano valso il nomignolo di Torototella. Però avevano sugo e forma ed erano schietti, e quello che più importa, fu smentita per me la sentenza: carmina non dant panem. Una mia canzonetta a ritornelli venne a conoscenza di Monsignore, il quale, gran giovialone, buono come il pane e santo uomo per giunta, mi fece chiamare mentre stava a tavola, mi pose un bicchiere in mano e mi pregò gliene dicessi delle altre, locchè feci ben volentieri. Alle corte, il vescovo mi propose di farmi studiare tanto da venire ammesso al seminario e si offerse di sostenermi per tutta la durata degli studi. Così dissi la prima messa in età di trentacinque anni e fui subito mandato qui vice-curato e poi curato alla morte del mio predecessore.
Allora lo pregai mi dicesse de' suoi versi. Corse tosto allo scrittoio, ne levò uno scartafaccio e venne a sedermisi di rimpetto.
– Intende il gergo valdostano?
– Sicuro.
– Allora stia a sentire.
Creda il lettore che non aggiungo nulla di mio, che quei versi li ho veramente intesi, che il prete gobbo me li lasciò alcuni giorni per le mani e che ne fui caldissimamente ammirato. Nessuno li avrebbe detti opera d'un prete; non v'erano nominati nè la religione, nè la fede, nè Dio, nè il demonio, nè i santi. Erano versi piani senza invocazioni, nè assalti alla sublimità; raccontavano, descrivevano, frugavano nei minuti episodi della vita quotidiana e ne sparnazzavano intorno mille piccoli fatti ignorati, giusti, di quelli che si sentono veri anche a non averli mai prima osservati. Una poesia raccontava la visita che un pastore faceva al suo vicino, lassù sull'alpe, ma non il pastore bellimbusto tutto nastri e bubbole, cogli scarpini lustri e la beata filosofia oziosa sulle labbra, ma un vero pastore sudicio, quadrato, che si tirava dietro le suole di legno un palmo di melma e d'altro, che discorreva poco e di cose usuali, un delizioso intaglio quel discorso, divagato e preciso, pieno di interiezioni e d'incisi, con dei oue (oui) e degli ah! fortemente sospirati, che facevano da basso accompagnamento continuo a tutte le parole.
Un'altra raccontava una serata in una stalla, d'inverno. Chi si rammenta di certi quadri che ebbero gran voga alla fine del secolo passato ed al principio di questo, pieni di figurine diverse, raccolte in diversi gruppi, intento ogni gruppo a diverse faccende, senza curarsi uno dell'altro, chi ballando, chi cenando, chi facendo all'amore, chi lavorando e lo sciancato sul primo piano che domanda l'elemosina, e il cagnetto che fa la sua brava pisciatina sulla cuna di un bambino e in fondo la forca, gli sbirri e l'appiccato; il tutto festoso, vivacissimo, con un saporito accento di caricatura, distribuito qua e là a seconda della gaia filosofia corrente, che fa quasi il commento del quadro e tradisce le simpatie dell'artista?
Or bene, quel poemetto in gergo valdostano aveva tutta la finezza arguta di simili tele, più uno studio di verità, una concisione sugosa e qualche tocco grave, pieno di pensiero. Cominciava all'ora dell'imbrunire e giungeva fino alla mezzanotte. Prima viene la vecchia a mungere il latte nella ciotola verde, dove il primo getto schiaffeggia la vernice ed il secondo e gli altri si ammorzano cadendo nella spuma, la quale giunta all'orlo tinge in bianco il pollice della mano che vi pesca dentro. Prima di mutar ciotola, la vecchia succhia dal pollice la panna grassa o la fa succhiare ai bambini che le stanno attorno ghiotti ed attenti, malgrado i calci e le scodinzolate di certe vacche stizzose. Poi viene la cena, poi i bambini vanno a letto nelle mangiatoie vuote e comincia la veglia e l'arcolaio comincia i suoi giri da trottola con un gemito ad ogni mezzo giro come fanno le ruote dei pozzi e certe tabacchiere a vite. Vengono i discorsi degli uomini, nascosti dietro il fumo acre della pipa catarrosa, e le ghignatine e i secretuzzi delle ragazze da marito; poi la porta si apre, la porta grondante sudore, ed entra un vento gelido ed un innamorato ardente che dà la buona sera a tutto il mondo e va dritto a serrarsi daccanto la sua bella. La stalla è grande e vi convengono i vicini poveri ed i vicini dei vicini; le ragazze da marito sono molte e l'uscio lascia entrare spesso il vento gelido e gli innamorati ardenti; ma una volta che li ha fatti sedere uno d'accosto all'altra e li ha avviati per i discorsetti a bassa voce, il prete non si cura altro di loro e solo li fa intervenire nella gran scena come figure di seconda mano, ne ricava degli incidenti comici o dei ritornelli maliziosi. Il poemetto si rigira seguendo il discorso generale, fa la storia di questo e di quello, raccoglie i motti salati e le arguzie paesane, salta di sbalzo nel dramma, accennando a disgrazie seguite o temute, ma non vi si dilunga volentieri, la sua commozione non è mai verbosa. Nella gioconda pace dell'insieme, quei tocchi gravi raddoppiano di valore e fanno rabbrividire. Di quando in quando, le cose anch'esse intervengono e prendono la loro parte d'azione. I rumori varî della stalla, si sentono tutti. Le vacche stropicciano la catena nell'anello che le assicura alla mangiatoia. A volta rompono il ruminare continuo con un sospirone che esce per le narici e pare venuto da qualche riflessione malinconica o dolorosa, sulla condizione sociale del gregge o sulla stagione ingrata che le condanna all'erba secca e dura. I bambini nelle mangiatoie dormendo russano e fischiano, le ragazze stimolate da pizzicotti ricevuti là dove non faranno mai vedere il segno, trillano dei gridolini allegri e rispondono con manrovesci arditi che irritano le petulanti impazienze dei giovani. Un soldato in congedo intona una canzonetta napoletana, ma essa non è fiore da quella serra, e le sue vispe cadenze degenerano presto nella lentezza piagnucolosa di una complaintevaldostana, la quale si strascina dormicchiando via per le bocche di tutti, copre i discorsi troppo intimi, agonizza e rinasce interminabile e lamentosa. Qua e là risalta un fare rablesiano efficacissimo, e brutale: corrono per tutta l'assemblea delle risate improvvise che fanno volger tutti gli occhi a qualche vecchia, la quale confessa ridendone anch'essa, l'istantaneo involontario peccatuzzo. Finalmente la fisarmonica invita a ballare e le coppie nel cerchio stretto, sulla terra battuta, sotto la luce della lucerna a due becchi, saltano senza muover di posto come i martelli meccanici dei ramai.
Che larga vena comica da capo a fondo, che intuizione giusta del vero, che sapiente eliminazione degli elementi inutili e sovratutto che aria paesana in tutta la composizione. La poesia sincera non ha maestri, nè scuole; il mio gobbo non pensava certo di intonarsi con tanta giustezza col suo tempo e se qualcuno lo avesse lodato per la sua modernità ne avrebbe avuto in risposta una crollatina di spalle; egli non aveva forse mai letto un libro scritto di questo secolo.
Ma egli non scriverà forse mai più un verso in vita sua, e non ne scrisse da parecchi anni. Stava correggendo gli ultimi quando seguì in paese un fatto terribile che è sempre presente alla sua memoria. Me lo raccontò e ve lo racconto.
***
Poco lontano dalla canonica, in un piccolo seno chiuso fra la montagna ed un rialzo di terra che gli toglie la vista della valle, c'era una casa rustica di discreta apparenza. Il luogo freschissimo d'estate e riparato l'inverno dai venti gelidi, è una specie di vallata minuscola, dove corre una miseria di torrentello, poco più che un rigagnolo, il quale precipita dalle cime a furia di cascate e di sprazzi col piglio di un rodomonte che voglia recare al basso la desolazione e la rovina, e poi, incontrato il rialzo che ho detto, gli manca la forza di scavalcarlo, fa un gomito, si acquieta, muta colore, abbassa la voce, si contenta di poco letto e vi depone una sabbiuzza fina fina, tutta piena di riflessi diversi, come uno strato di gemme. Nelle maggiori piene l'acqua, benchè si tinga di un colore rossastro per darsi l'aria rabbiosa, arriva appena a lambire le tavole di un basso ponticello e non fa mai altro danno fuori che di bagnare le more dei rovi, lasciandovi sopra una leggierissima imbiancatura. La casa sorgeva giusto al punto del gomito nell'interno della curva che vi disegna il torrente; aveva un bel prato all'intorno ed il ponticello era destinato esclusivamente al suo servizio. Ne era padrone un tal Vincenzo Bionaz, il quale l'aveva comprata ed era venuto a dimorarvi colla moglie e due amori di bimbi, lo stesso anno che il nostro prete, da vice curato, era stato promosso a curato della parrocchia. Vincenzo, robusto ed intelligente operaio, lavorava in qualità di minatore ad una vicina miniera di ferro dove guadagnava tanto da tenere due vacche nella stalla e da poter comprare ogni anno qualche tavola di prato. Egli era un brav'uomo, allegro e casalingo; la moglie, nativa di Valchiusella, un paese dove le donne sono tutte belle da dipingere, lo adorava e ne era adorata, e vivevano tutti e due in pace, come si dice, con Dio e cogli uomini, lasciandosi andare ai facili progetti di futura prosperità in favore dei figliuoli.
Bisogna conoscere i disgraziati paesi infestati dal cretinismo ed avervi vissuto per comprendere il sentimento d'orgoglio che danno ai parenti i bambini sani e belli. È una compiacenza continua che va fino alla gratitudine verso quelle creature, dalle quali la famiglia è sottratta alla vergogna comune e nobilitata. Tutte le facoltà dell'animo umano, anche le cattive, partecipano di tale compiacenza, tutti gli affetti della vita sono dominati dalla gioia immensa di possedere un così raro tesoro e la coscienza della propria felicità così piena ed eccezionale, ingenera in chi la prova una specie di sicurezza fatale di non doverla perdere mai.