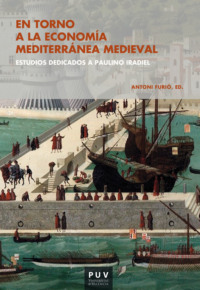Kitabı oku: «En torno a la economía mediterránea medieval», sayfa 4
20 In proposito cfr. The New Economic History. Recent Papers on Methodology, New York, John Wiley & Sons, 1970, a cura di R.L. Andreano, ed. it. La nuova storia economica, con traduzione di A. Salsano, Torino, Einaudi, 1975; gli interessanti saggi raccolti nel citato volume intitolato Dove va la storia economica? Metodi e prospettive, secc. XIII-XVIII, con particolare riguardo per l’Italia al saggio di P. Malanima, Storia economica e teoria economica, ivi, pp. 419-427 e per la Gran Bretagna al saggio di W.M. Ormrod, Governement Records: Fiscality, Archives and the Economic Historian, ivi, pp. 197-224.
21 C. M. Cipolla, Tra due culture, cit., pp. 91-92.
22 Ibidem, p. 33.
23 Si veda in proposito il bel volume degli Atti della XXXIV Settimana Datini, dedicato a Economia e energia secc. XIII-XVIII, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 2003, e il volume degli Atti della XL Settimana Datini, Le iterazioni fra economia e ambiente biologico nell’Europa preindusriale, secc. XIII-XVIII, Economic and Biological Interactions in Pre-industrial Europe, fron the 13th to the 18th Centuries, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Firenze University Press, 2010.
24 C.M. Cipolla, Tra due culture, cit., p. 96.
25 R.A. Goldthwaite, The Economy of Renaissance Florence Baltimore, Md., The John Hopkins University Press, 2009; ed it. L’economia della Firenze rinascimentale, Bologna, Il Mulino, 2013.
26 Interessanti esempi di utilizzazioni di fonti letterarie e iconografiche in studi di storia economica sono contenuti anche negli Atti della XXVI e della XXXIII Settimana Datini, dedicati rispettivamente a Il tempo libero, economia e società (Loisir, Leisure, Tiempo libre, Frezeit), a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1995, e a Economia e arte, secc. XIII-XVIII, Firenze, Le Monnier, 2002.
27 Fondazione Istituto internazionale di storia economica «F. Datini» Prato, Atti della «Quarantunesima Settimana di Studi» 26-30 aprile 2009, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Firenze University Press, 2010, pp. 608-609.
ALLE ORIGINI DEL FATTORE ITALIA: LAVORO E PRODUZIONE NELLE BOTTEGHE FIORENTINE DEL RINASCIMENTO
Giampiero Nigro Università degli Studi di Firenze
Il tema della capacità del design rinascimentale è tornato più e più volte nella riflessione sulle attuali potenzialità economiche dell’Italia e delle sue vocazioni manifatturiere. Imprenditori, economisti e sociologi, cogliendo l’utilità della storia, affermano che per irrobustire la qualità e la visibilità del made in Italy è necessario fare riferimento al gusto e alla capacità tecnica e artigianale che ebbe inizio durante il Rinascimento. Dunque l’italian factor trova i suoi precedenti storici nel design-thinking del Rinascimento fiorentino. A parte gli sgradevoli neologismi, ho sempre avuto l’impressione che il concetto di capacità nel disegno rinascimentale sia stato usato solo in quel limitato significato, come se i connotati dei tempi si fossero semplicemente estrinsecati sul piano dell’abilità artistica e della sensibilità estetica.
In effetti nella Firenze degli umanisti e degli artisti del Rinascimento, nella Firenze dei secoli XIV-XVI esisteva un insieme complesso di fattori economici, sociali e culturali che possiamo sintetizzare nella locuzione «fattore Firenze».
Per mostrare questo, dovrò richiamare l’attenzione su una parte della società fiorentina di allora. Non parlerò delle masse dei diseredati, ma di una porzione minoritaria della società, non piccola e fortemente diversificata, che a partire dalla peste del 1348 concorse alla ripresa economica e alla riduzione della polarizzazione della ricchezza. Un ceto intermedio che fu artefice e partecipe di forte dinamismo sociale.
Le condizioni economiche e il dinamismo che caratterizzavano la Città del Giglio nei secoli indicati possono essere colti esaminando i dati del Catasto del 1427 dai quali emerge che a Firenze 1/3 dei capi famiglia deteneva circa il 50 % della ricchezza accertata e che cento famiglie ne avevano il 16-17 %.1 Dunque nel Basso Medioevo la distribuzione era migliore di quanto potessimo aspettarci. Pensando al tempo attuale si rifletta sul fatto che, secondo Banca d’Italia, nel 2012 il 64 % della ricchezza in Italia era in mano al 10 % delle famiglie. Inutile soffermarsi sulla difficoltà di confrontare simili dati in modo corretto; mi limito a dire che essi hanno un valore almeno evocativo e ci aiutano ad affermare che Firenze era una realtà dotata di inusitata vitalità, di una dinamicità creata da quel largo strato sociale che ruotava attorno alle botteghe.
Ecco il nucleo dal quale intendo partire: la bottega;2 la bottega fiorentina, vista soprattutto nel suo funzionamento e che proverò a descrivere sinteticamente cercando di porre in evidenza gli elementi utili alla mia riflessione. Si trattava, nella maggioranza dei casi, di aziende gestite da quello che definiamo l’artigiano classico; un maestro in grado di agire nella condizione di operatore economico libero sul mercato, con un libero accesso alle materie prime e al consumatore finale. A differenza di quanto accadeva a molti produttori di fase nella manifattura tessile, quella autonomia consentiva l’adozione di strategie prive di condizionamenti se non quelli dei propri bisogni e stimoli culturali. Egli governava la sua bottega sulla base di un rapporto di tipo paternalistico che lo legava ai propri dipendenti: il garzone stabile, il lavorante a cottimo, l’apprendista. Persone che, sottolineo questo aspetto, erano fortemente partecipi dei processi produttivi in cui erano inserite. Non esisteva alcuna forma di alienazione dal lavoro che il mondo occidentale ha scoperto con la Rivoluzione Industriale. Possiamo quindi immaginare che, normalmente, dentro la bottega fiorentina di quei tempi ciascun addetto concorresse in modo consapevole e partecipato alla creazione dei prodotti finali, di quei beni che tanto spazio hanno avuto nell’immaginario dei nostri storici dell’arte, ma anche e soprattutto dei consumatori di allora. Si pensi a botteghe come quella di Donatello o del Cellini che gli storici dell’arte hanno chiamato scuole; erano scuole come tutte le altre, uguali alla piccola azienda di Girolamo di Lorenzo Talducci «facitore di scarpe in Por Santa Trinita»,3 uguali a una qualsiasi bottega di farsettaio. Al loro interno ogni pezzo veniva fabbricato in parte dal maestro in parte da chi collaborava con lui. Era un modello di organizzazione della produzione compartecipata che garantiva forti e inusitati elementi di creatività.
Altri aspetti fondamentali erano il tempo e il ritmo del lavoro. Si lavorava, di norma, quindici ore al giorno, dall’alba alla compieta, le ore ventuno secondo l’attuale modo di misurare il tempo.
Faccio un piccolo inciso su questo aspetto: da tempo era entrato in uso l’orologio, strumento razionale, indispensabile all’ormai evoluto mondo del lavoro, che consentiva di superare gradualmente le abitudini indotte dalle antiche quanto incerte misure del tempo tramandate nei conventi e nelle chiese. Molti orologi in Italia erano simili a quello sulla controfacciata del Duomo di Firenze, splendidamente dipinto da Paolo Uccello negli anni Quaranta del Quattrocento. Il quadrante contiene tutte le ore del giorno; le ore ventiquattro non corrispondevano all’attuale mezzanotte astronomica ma, secondo lo stile italico, scadevano al tramonto di ogni equinozio ed erano dipinte sulla parte inferiore dell’orologio (in corrispondenza delle nostre ore sei).4
Torniamo al tempo di lavoro; ho detto che la giornata era di quindici ore con tre intervalli: uno per asciolvere cioè per fare una piccola colazione, uno per il pranzo attorno a mezzogiorno (alla sesta delle ore canoniche) e uno per la merenda all’ora nona, cioè intorno alle quindici.
Le giornate lavorative nell’anno erano mediamente duecentocinquanta con un ritmo settimanale che si aggirava intorno a cinque giorni di quindici ore e il sabato di ben dieci ore.
Questi pochi elementi farebbero immaginare una dimensione pesantissima del lavoro, ma non era così; non lo era grazie al ritmo naturale delle attività che dava spazi alle relazioni umane e consentiva interruzioni legate a necessità personali. Il tempo del lavoro si identificava con quello della vita, l’uno era parte dell’altro. Allora non esisteva il nostro concetto di tempo libero: il tempo dello svago non si contrapponeva a quello del lavoro ma alla continua fatica di vivere; la possibilità di prendersi consolazione poteva investire qualsiasi momento del quotidiano, non solo nelle ore e nei giorni di festa ma anche in quelli della bottega.5
Gli studi che ho condotto su registri contabili di molte aziende mi hanno convinto del fatto che il ritmo del lavoro fosse estremamente diseguale. Diseguale l’intensità con cui ci si applicava alla produzione, diseguale il numero delle giornate lavorative nel mese. Ciò dipendeva non solo dalla diversa distribuzione dei giorni festivi, ma anche da altri fattori come i comportamenti della committenza che poteva provocare brusche accelerazioni e nuovi freni al lavorio della bottega; anche l’avvicendarsi delle stagioni e le cadenze della campagna potevano provocare mutamenti dei ritmi con il temporaneo trasferimento di manodopera cittadina. Gli stessi artigiani, spesso piccoli proprietari, erano talvolta costretti a lasciare la bottega per recarsi nella loro presa di terra.
Infine erano assai frequenti le assenze dal lavoro per motivi personali. Alcune aziende ne tenevano memoria in appositi libri «degli scioperii». Se ne conserva uno nel Fondo Datini.6 Scorrendo l’elenco dei conti accesi ai vari dipendenti, troviamo che le assenze erano relativamente frequenti e potevano durare da più giorni a poche ore. I motivi erano assai diversi: si era lasciato il lavoro per un pellegrinaggio o per andare alle terme di Montecatini; per andare a veder montare la campana del Duomo o per assistere un familiare, per andare in campagna o per governare il vino o partecipare a un lutto.7 Tali assenze determinavano una riduzione proporzionale o forfettaria del compenso stabilito all’inizio del rapporto di lavoro.
Insomma questi uomini, legati da un contratto a tempo determinato, entravano o uscivano dai laboratori d’accordo con il proprietario e nel rispetto delle esigenze del laboratorio.
Possiamo immaginare questa bottega, immersa nel tessuto urbano, come un punto di riferimento per i passanti, momento di sosta e di relazione sociale. La possiamo immaginare persino nella dimensione rappresentata da La bottega del falegname di Jean Bouchirdon, luogo in cui poteva raccogliersi la famiglia, spazio in cui i momenti di vita sociale non venivano mortificati dall’obbligo del lavoro.
I connotati di fondo della bottega bassomedievale rimasero sostanzialmente stabili mentre, proprio tra il Trecento e il Cinquecento, gli oggetti che uscivano da quei fondaci subirono significative trasformazioni nelle tipologie e nella qualità; ciò fu il frutto della evoluzione del potere di acquisto e quindi dei modelli di consumo.
All’inizio del periodo considerato, la domanda interna era essenziale, tipica di una realtà in cui la ricchezza era fortemente polarizzata; le attività produttive, seppure differenziate, erano lo specchio di quella situazione. L’immagine internazionale della manifattura fiorentina era essenzialmente rappresentata dai tessuti di lana, dagli eccellenti panni fatti di lane costose, tinti e rifiniti in modo magistrale. Mentre l’Arte di Calimala cedeva il passo all’Arte della Lana, quei panni pregiati che circolavano nel continente europeo e nel Mediterraneo concorsero in modo fondamentale alla crescita della ricchezza anche sostenendo l’ampliamento dei traffici commerciali delle grandi compagnie mercantili bancarie.
Il mutamento si venne realizzando con una certa gradualità che subì una forte accelerazione nei primi anni del Quattrocento. Crebbero le tipologie dei prodotti realizzati in città e, con la molteplicità produttiva, crebbe un complesso sistema di relazioni tra le botteghe, tra loro e le grandi aziende commerciali.
Dai tessuti e dalle fogge degli abiti agli strumenti più semplici della quotidianità; dal pettine alla valva di uno specchio, dai cassoni dipinti ai deschi da parto: erano oggetti di alto contenuto tecnico, uno più bello dell’altro, espressione di una sensibilità tutta rinascimentale. I manufatti più ricchi divennero testimoni di una forza economica e culturale, quella di Firenze appunto, che riusciva a imporre modelli di consumo ben oltre i propri confini, nelle corti e nei ricchi ambienti laici ed ecclesiastici europei.8
Il fenomeno coinvolse tutte le forme della produzione cittadina, dalle piccole botteghe alle più grandi imprese manifatturiere. Si pensi alle vicende del settore serico e auro-serico. Nel Trecento, i drappi di seta fiorentini e soprattutto quelli lucchesi e veneziani circolavano in Europa, ma perdevano la guerra commerciale con i tessuti di rara bellezza che venivano dall’Oriente, da Costantinopoli. Agli inizi del Quattrocento tale situazione cominciò a mutare.9 Per segnalare alcuni fatti emblematici, nel 1422, un’ambasceria fiorentina si recò in visita al «Soldano» d’Egitto; tra i suoi doni, oltre che venticinque pregiati pannilani, vi erano tessuti serici. Se quegli uomini decisero di offrire un simile dono a chi viveva nel cuore di un’alta e antica tradizione, dovevano essere consapevoli della conquistata abilità dei loro battiloro e setaioli.10 Nel 1492, l’anno della scoperta dell’America, Bonsignore Bonsignori, un fiorentino che si trovava a Bursa, il più importante centro produttivo di tessuti serici e auro-serici della Turchia ottomana, scrisse che in quella città «Si lavorano più sete e drappi d’oro che in tutta Italia, non sono però sì belli».11 Dunque in quel periodo Firenze aveva conquistato un primato che, inizialmente basato sulla imitazione, aveva assunto una autonoma identità. Nel 1542 la compagnia di Iacopo e Giovambattista Botti di Siviglia ordinò a Firenze una fornitura per la cattedrale: un piviale «d’oro filato e tirato, talché tutto parrà una massa di oro intero», una pianeta e una serie di camici che ebbero il valore di ben 1.500 ducati. Mentre i maestri fiorentini vi provvedevano, Matteo Botti scriveva ai suoi fratelli che, vedendo il lavoro finale, i canonici si sarebbero convinti «ch’e fornimentj che gl’ànno non sono niente […] e non parrà havere maj hauto cosa richa».12 Non ci stupisce troppo l’entità della somma spesa: Siviglia era la porta del Nuovo Mondo in cui giungeva gran parte dell’argento americano che stava inondando l’Europa. Stupiscono le modalità di azione dei Botti; essi sapevano, attraverso le mille relazioni commerciali ed epistolari, cogliere opportunità di affari di ogni genere e, nel caso specifico, seppero agganciare una prestigiosa committenza e condizionarne fortemente la scelta mostrando la superiorità dei propri stilemi. In questo modo il made in Florence avrebbe esibito se stesso.
Ma vi erano anche debe ser altre forme di imporre le proprie mode. Angela Orlandi ha trovato un documento molto interessante che è una specie di estratto-conto, del 1558, relativo alla realizzazione di una bambola. Siamo ancora nell’ambito della famiglia Botti di via dei Serragli. La bambola venne chiesta a Matteo dal fratello Iacopo che abitava a Siviglia per la figlia. Per costruire il giocattolo si fece ricorso a un falegname, Antonio Particini, che il Vasari definì «raro maestro di legname» che «merita somma lode»; la pittura del viso, «di colore incarnato», fu affidata a Gian Iacopo Mattoncini, discepolo di Lorenzo di Credi. Al vestito poi fu dedicata una particolare attenzione: il sarto utilizzò raso giallo e damasco verde avendo cura che la fattura fosse alla moda, uno stile probabilmente ispirato agli abiti indossati da Eleonora di Toledo, la moglie di Cosimo I. A tutto ciò si aggiungano i decori in seta che concorsero a farne un oggetto assai prezioso il cui costo equivaleva a circa tre mesi di stipendio di un ufficiale della zecca.13
La bambola non fu soltanto un giocattolo, fu custodita a Siviglia nell’abitazione del mercante insieme ad altre suppellettili e oggetti di arredo di cui si aveva il piacere di circondarsi. Tra questi vi era anche una «nostra Donna con figliolo in braccio e Giuseppo» che anni prima, nel 1535, Francesco, il fratello di Iacopo, aveva ordinato al Vasari per portarla in Spagna.14 Tutto veniva orgogliosamente esibito ai tanti ospiti di rango che arricchivano gli indispensabili rapporti sociali nella opulenta Siviglia.
Le riflessioni fatte lasciano immaginare la presenza a Firenze di artefici e mercanti diversamente specializzati ma similmente dotati di cultura che non era solo estetica. Essi producevano e usavano una moltitudine di manufatti di alta qualità che riuscivano a imporre nel mondo.
Come è accaduto tutto questo?
Non basta evocare il ruolo della produzione dei beni di lusso.15 È vero che essa fu fondamentale nel compensare la crisi del commercio di pannilani e nell’accrescere il ruolo di Firenze nei traffici internazionali. L’attenzione quasi esclusiva sul ruolo dei beni particolarmente ricchi ha finito per appannare una visione più complessa e articolata della società e della economia del tempo. La realtà cittadina era assai diversificata e al suo interno accanto ai beni di lusso vi erano beni poveri ma, esattamente come gli altri, espressione di una colta sensibilità. Ricchi di qualità intrinseche erano destinati alla domanda che stava emergendo proprio all’interno di quel ceto medio che tendeva a dare maggiore spazio al consumo di beni superflui.
Si potrebbero fare molti esempi: alla fine del Trecento poteva capitare di incontrare, nelle piazze e nei mercati, l’ambulante che vendeva immagini sacre, dipinte su carta, oggetti quasi certamente dotati di valori estetici non inferiori a quelli di un orpello preparato per un prestigioso soffitto. Proprio nell’ambito dei consumi devoti a Firenze operava una famiglia di lunghissima tradizione, i Benintendi Falimmagini che tra il XIV e il XVI secolo facevano figure di cera a misura d’uomo che rappresentavano persone graziate per uno scampato pericolo. Secondo il Vasari la ceroplastica si era raffinata nel tempo grazie alla osmosi fra le varie arti. Insomma possiamo prendere i «boti», gli ex-voto, come ulteriore testimonianza della crescita dei consumi medi e medio-bassi.16 Ancora, per proseguire con qualche ulteriore esempio, si pensi allo sviluppo della domanda dei tessuti di cotone alla perugina o alla diffusione di eleganti oggetti dal basso valore intrinseco ma di implicita citazione colta.
Così come è insufficiente spiegare il successo del made in Florence riferendosi alla sola produzione di lusso, è anche insufficiente evocare soltanto il ruolo della cultura delle élites. Sembra quasi ovvio richiamare l’attenzione sul fatto che Umanesimo e Rinascimento ebbero una influenza forte e positiva, ma è altrettanto vero che anch’essi furono il frutto di una realtà economica e sociale dinamica e innovativa. Almeno quel terzo della popolazione sopra citato era partecipe di questa vita culturale e lo era a modo suo, apportando elementi di innovazione basati su un pragmatismo e un gusto che si stava evolvendo. Si deve pensare la città di quegli anni come un crogiuolo di individui che appartenevano a classi diverse e al cui interno la contaminazione tra diversi modelli di vita era forte.17 La contaminazione, quell’inesausto conflitto della imitazione, era un elemento che rompeva gli schemi della tradizione medievale; per fare un elementare esempio, anche le abitudini al parziale riuso di abiti concorrevano a mettere in discussione certi conformismi. «Poca vertù, ma fogge ed atti assai!» lamentava Franco Sacchetti18 nel rimpiangere la vita tranquilla e sostanzialmente immobile dei tempi passati. Come ho accennato, ciò era chiaramente visibile nei piccoli manufatti del quotidiano, come in certe suppellettili d’osso o di legno anziché di avorio, realizzate dal medesimo artigiano. Questo fenomeno di contaminazione era ancora più visibile nei modelli alimentari; essi cambiavano nella tipologia dei prodotti, nelle tecniche di preparazione e perfino in alcuni servizi, come quelli del cuoco di osteria che preparava cibo da asporto per persone appartenenti ai ceti più diversi.19 Nel Seicento Giulio Cesare Croce avrebbe rielaborato una versione medievale delle vicende di Bertoldo confermandone la funzione didattica. L’astuto contadino sarebbe morto per non poter mangiar rape e fagioli, perché non gli era stato possibile mantenere comportamenti consoni al suo stato; Firenze due secoli prima stava mettendo in discussione queste regole.
Altro elemento che deve essere maggiormente valutato riguarda ciò che oggi definiremmo valorizzazione del capitale umano. Molti ragazzi giovanissimi ambivano a entrare in bottega: era il modo per muoversi nella scala sociale; prima però si andava a scuola fino a 10-12 anni. Dal Catasto del 1480 emerge che nella Firenze di 50-55.000 abitanti, ben 1.031 ragazzi nell’età tra 10 e 13 anni andavano a scuola.20 Tra di loro vi era chi, dopo la scuola di grammatica, seguitava nella bottega d’abaco, molto diffusa in Toscana sin dai tempi di Leonardo Fibonacci. In essa si insegnava la matematica applicata all’economia. I maestri erano quasi sempre noti studiosi i quali sottolineavano che la formazione offerta sarebbe stata «sufficiens ad standum in apotecis artificis».21 Gli scolari imparavano cose anche complesse: non solo le operazioni di base, le frazioni, l’uso dei numeri arabi, i pesi e le misure; studiavano il calcolo del tasso d’interesse e le rateizzazioni, la tenuta di un libro di entrate e uscite e tutti i principali problemi monetari, perfino il tema dell’alligazione.
Insomma, la comunità cittadina tentava di offrire un livello di formazione che non avremmo immaginato e che non si interrompeva con la scuola ma continuava in bottega, con la molta cura e severità che ho riscontrato in tanti scambi epistolari tra direttori di imprese del tempo.
Tutte queste condizioni aiutano anche a spiegare l’esistenza di un altro fattore, quello delle diffuse capacità imprenditoriali. È un tema introdotto da Federigo Melis che non si stancava mai di insistere sulla necessità di fare storia economica ponendosi idealmente alla scrivania del dirigente di allora.22 In questi ultimi decenni si sono potuti approfondire molti aspetti di quel management.
Anzitutto gli imprenditori fiorentini mostravano una forte vocazione all’innovazione: fino dagli ultimi decenni del Trecento, il pragmatico adattamento di molti strumenti del commercio provocò effetti fortissimi. Si potrebbero fare molti esempi ma mi limito a due, studiati da Melis. Il primo riguarda le innovazioni nel settore bancario e la graduale creazione di una banca moderna che offriva alle imprese lo scoperto di conto e che usava l’assegno di conto corrente.23 Il secondo attiene al settore dei trasporti dove la differenziazione dei noli marittimi consentì un forte ampliamento della circolazione di beni meno ricchi.24 Sembra quasi inutile sottolineare che quegli atteggiamenti mentali erano il frutto di una tensione rivolta alla espansione della propria impresa e alla riduzione dei costi di transazione; era la stessa tensione che diventava creatività nella produzione degli oggetti.
Accanto alla propensione all’innovazione troviamo una cultura orientata agli investimenti produttivi e al rischio. Francesco di Marco Datini, morendo nel 1410, lasciò oltre centomila fiorini ai poveri di Prato. Di quella cifra il 65 % era rappresentato da investimenti a rischio: quote di partecipazione in società di vario tipo e di varia forma; un altro 25 % era costituito dagli investimenti pubblici, spesso obbligatori, in termini di sottoscrizione delle cartelle del debito pubblico; solo il 10 % rappresentava gli immobili di questo imprenditore.25 Forse il Datini si mostra come un caso piuttosto raro; resta il fatto che, anche osservando le denunce catastali dei fiorentini, il reinvestimento dei guadagni nelle attività produttive sembra essere significativo. Sono convinto che questa particolare propensione al reinvestimento degli utili conseguiti potesse anche derivare dalla influenza degli ordini mendicanti che condannavano con forza il peccato di avarizia. Vicende e dibattiti che mi fanno venire in mente le osservazioni di Thomas Piketty sugli effetti negativi della accumulazione eccessiva della ricchezza e sulla sua errata distribuzione. Molti predicatori francescani e domenicani spiegavano nei loro sermoni che il denaro nella società dei credenti era come il sangue nel corpo mistico di Cristo: fermare il sangue, peccare di avarizia, significava uccidere la comunità dei cristiani.26 Forse per Datini, e per altri come lui, il continuo reinvestimento della propria ricchezza non era solo dettato dall’ansia del guadagno, poteva essere un modo di interpretare quelle prediche e, assieme alle continue elemosine, una risposta alle mille questioni irrisolte con la propria coscienza.
Per concludere questo mio tentativo di individuare i precedenti del fattore Italia nella Firenze rinascimentale vorrei riprendere brevemente il tema del dinamismo per accennare ad altro aspetto fino a ora poco considerato: quello del sistema di relazione tra le imprese, sia produttive che commerciali. Ovviamente non mi riferisco ai naturali meccanismi di confronto, di imitazione e di concorrenza tra aziende presenti sul medesimo mercato. Esisteva un nesso collaborativo, un vero e proprio network tra le aziende artigianali di base, piccole o grandi che fossero, e i grandi mercanti. Da questi ultimi la bottega otteneva un input fatto dagli stimoli ricevuti in contesti lontani, raccolti attraverso la conoscenza e lo studio dei mercati, stimoli e informazioni sui gusti presenti nelle grandi città europee e del Mediterraneo e su prodotti e tecniche poco conosciute. I manufatti, che rappresentavano delle novità, venivano accolti dai produttori i quali avevano cura di adattare tutto al gusto raffinato della realtà locale. Potremmo fare tantissimi esempi ma mi limito a ricordare il caso delle maioliche ispano-moresche. Le ceramiche che circolavano nel Mediterraneo durante il XIV secolo erano fabbricate da artigiani arabi di Manises e Paterna.27 I mercanti fiorentini cominciarono ad acquistarne per vedere se potevano trovare smercio; da Firenze giunsero molteplici input per cui i fabbricanti arabi cominciarono ad adeguarsi al gusto dei committenti fin tanto che, appresa la tecnica, i fiorentini iniziarono a produrne per proprio conto.
Anche da questo punto di vista l’elemento della imitazione si collegava strettamente con il Genius loci e con una creatività sostenuta e arricchita dal contesto ambientale ben curato. Ancora oggi, sia all’interno delle mura che fuori, nella campagna toscana, sono riconoscibili quei particolari elementi di armonia che ci appaiono come il frutto di una intelligenza collettiva, quasi un istinto di chi ha vissuto quell’ambiente, spontaneamente creato sulla base di una grande sensibilità estetica.
La forza economica di Firenze nel Rinascimento non era fatta soltanto dal design-thinking, beneficiava di una complessa serie di fattori economici e culturali.
Se questa è la lezione della storia, troviamo in essa molti utili riferimenti per affrontare oggi i complessi problemi economici dell’Italia. E non solo di essa.
1 D. HERLEY, CH. KLAPISCH-ZUBER, I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427, il Mulino, Bologna 1988, pp. 329-362.
2 Il tema che viene affrontato di seguito, oltre che su mie dirette indagini tiene conto di molti altri studi relativi all’artigianato basso medievale, bibliografia articolata e complessa dalla quale emergono i lavori di Donata Degrassi dedicati all’economia artigiana nell’Italia medievale.
3 F. AMMANNATI, Un calzolaio del Quattrocento: Girolamo Talducci e la sua bottega in Porta Santa Trinita, «Prato Storia e Arte», 113, 2013, pp. 143-155.
4 G. NIGRO, Il tempo liberato. Festa e svago nella città di Francesco Datini, Istituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini»-Prato, Prato, 1994, pp. 15-28.
5 G. NIGRO, Il tempo liberato, cit., pp. 7-10.
6 ARCHIVIO DI STATO DI PRATO, Fondo Datini, 1154, XXI, Quadernuccio degli scioperii, Compagnia di Arte della Lana di Prato.
7 G. NIGRO, Gestione del personale e controllo contabile. Un significativo esempio nella Toscana Basso medievale, in Fra spazio e tempo: studi in onore di Luigi De Rosa, a cura I. Zilli, I/III, Napoli [1995], I, Dal Medioevo al Seicento, pp. 809-821.
8 G. NIGRO, Per una analisi dei modelli di spesa e di investimento nella Toscana del XIV e XV secolo. Livelli di ricchezza o ceto di appartenenza? in Ricos y pobres: opulencia y dessarraigo en el Occidente medieval, XXXVI Semana de estudios medievales, Estella 20-24 julio, 2009, Gobierno de Navarra, Pamplona 2010, pp. 247-274.
9 Una sintesi di questo processo, complesso e articolato, si può trovare in G. NIGRO, M. SPALLANZANI, Intrecci mediterranei: tra economia e arte, in Intrecci Mediterranei. Il tessuto come dizionario di rapporti economici, culturali e sociali, Prato 2006, pp. 16-21.
10 D. CATELLACCI, Diario di Felice Brancacci, ambasciatore con Carlo Federighi al Cairo per il Comune di Firenze (1422), «Archivio storico italiano», S. IV, VIII, 1881, pp. 157-188. G. CORTI, Relazione di un viaggio al Soldano d’Egitto e in Terra Santa, «Archivio Storico Italiano», CXVI, 1958, pp. 247-266, p. 255.
11 A. ORLANDI, Oro e monete da Costantinopoli a Firenze in alcuni documenti toscani (secoli XV-XVI), in Relazioni economiche tra Europa e Mondo Islamico. Secc. XIII-XVIII, Europe’s Economic relations With The Islamic World 13th-18th Centuries, a cura di S. Cavaciocchi, Atti della «Trentottesima Settimana di Studi», 1-5 maggio 2006, Istituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini»-Prato, Le Monnier, Firenze 2007, pp. 981-1004.