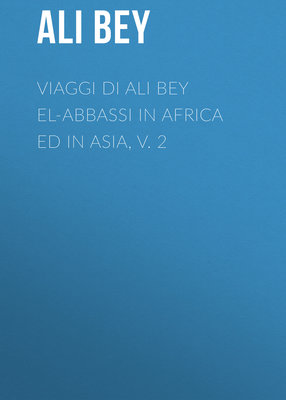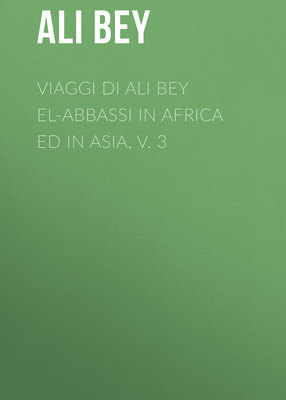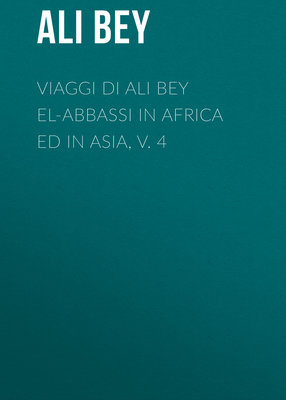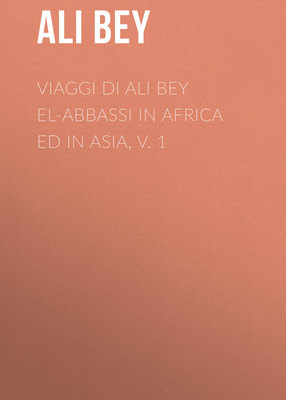Kitabı oku: «Viaggi di Ali Bey el-Abbassi in Africa ed in Asia, v. 1», sayfa 7
CAPITOLO X
Elemosina. – Digiuno. – Pellegrinaggio. – Calendario. – Mese sacro. – Pasque. – Impiegati delle moschee. – Feste. – Superstizioni.
Dopo la credenza di un solo Dio onnipossente, e la fede nella missione del suo profeta, come altresì l'obbligazione delle preghiere canoniche, duopo è osservare il precetto della elemosina: questa legge è assolutamente obbligatoria per ogni musulmano in istato di osservarla.
Questo precetto comprende la decima elemosiniera, l'elemosina pasquale, il sacrificio pasquale, le donazioni o pie fondazioni, e le elemosine eventuali di carità.
La decima elemosiniera corrisponde al due e mezzo per cento all'anno di quanto si possiede, tranne i montoni e le capre che non contribuiscono che in ragione dell'uno per cento. Deve distribuirsi quest'elemosina ai poveri; ma si fa generosamente e senza troppo minuto calcolo, poichè ogni cuore buono alle disgrazie del povero contribuisce in una più alta porzione che quella fissata dalla legge. Per conto mio ebbi costantemente l'abitudine di nudrire un certo numero di sventurati o di storpiati, oltre le accidentali elemosine ch'io facevo, e credo di aver soddisfatto al mio debito.
Chiamasi elemosina pasquale l'obbligazione imposta ad ogni ricco musulmano di dare ai poveri il primo giorno del mese schovàl, che è la piccola pasqua; (l'Eìd seguìr) una mezza misura di frumento, o di farina, o un'intera misura d'orzo, o di dattili, prima del sole. I padri di famiglia e le persone che hanno servitori, devono dare per ogni individuo della famiglia quanto per se medesimi. È in loro arbitrio il dare l'elemosina in natura, o in danaro.
Il sacrificio pasquale è quello d'un montone, di un bue, o d'un cammello, che s'uccide il primo giorno della gran Pasqua (l'Eìd quibir) che ricorre il 10 del mese Dulhàja. Questa misura è applicabile ad ogni musulmano agiato padre di famiglia, o capo di casa. Dopo aver ucciso l'animale colle proprie mani tra il levar del sole ed il mezzogiorno, ne mangia una parte arrostita, e dà ai poveri il rimanente, che dev'essere più di un terzo della bestia. La pelle della vittima è riservata per gli usi personali del padrone oppure deve darsi ai poveri. Si fa lo stesso sacrificio in alcune importanti circostanze, come per guarire da una malattia, quando viene intrapreso un lungo viaggio, e simili cose.
Le donazioni o pie fondazioni, consistono nell'inalzare monumenti di pubblica utilità, come a dire nello stabilimento d'una moschea, d'una fontana, d'un ospizio, d'un ospitale, d'una scuola, ec. Quando un musulmano fa una fondazione o pia donazione, egli e la sua posterità perdono per sempre la proprietà dello stabile, ma per altro può riservarsi certi godimenti per sè, e suoi successori. Una delle mie prime cure, quando abbandonai il paese de' Cristiani, fu di meritare la grazia di Dio con una pia fondazione, e feci fare un deposito d'acqua potabile ad uso della moschea di Tanger che non ne aveva.
Gli ordinarj atti di carità, o le accidentali elemosine che sono consigliate nelle altre religioni, sono quasi obbligatorie per i Musulmani. Egli non può mettersi a tavola senza invitare quelli che gli stanno ai fianchi, qualunque siasi lo stato loro, e la loro credenza; egli non rimanderà giammai senza qualche soccorso il miserabile che glielo chiede, s'egli ha mezzo di consolarlo. L'ospitalità verso ogni uomo che si presenta, qualunque sia il suo culto, è una conseguenza di questo principio.
Il digiuno nel mese di Ramadàn è il quarto precetto divino. Consiste nel non mangiare nè bere, nè fumare, nè respirare l'odore degli aromati, nè quello di un frutto, ed a osservare una perfetta continenza dal momento del feger, crepuscolo avanti il levar del sole fino al tramontare ne' ventinove o trenta giorni del mese di Ramadan.
Questo digiuno obbliga tutti gli uomini e le donne, ad eccezione degli ammalati, dei viandanti, delle femmine incinte, o nello stato d'impurità legale, delle nutrici, dei minatori, dei vecchi deboli, delle persone alla cui sanità l'astinenza potrebbe pregiudicare, dei pazzi, ecc. E se si rompe il digiuno per inavvertenza o per distrazione, per causa di malattia, di viaggio, o per altra legittima causa corre l'obbligo di soddisfare a questo debito digiunando tanti giorni in altro tempo a sua scelta: ma se la trasgressione del digiuno di un solo giorno fu volontaria, e senza legittima causa, devesi per espiare questo delitto digiunare settantun giorni.
Dal tramontare del sole fino all'ora della preghiera del mattino, si può mangiare, bevere, fumare e divertirsi quanto si vuole durante la notte; ma le persone di regolata coscienza impiegano il tempo a recitare preghiere in casa o nella moschea, a leggere il Corano, a fare altre opere di carità, ad unirsi in una fraterna ed aggradevole società, ma sempre circospetta. In questo tempo cessano le nimicizie, si riuniscono le famiglie, i poveri sono più che in altri tempi soccorsi con abbondanti elemosine.
Le moschee sono aperte ed illuminate tutta la notte in tempo del ramadàn, e la folla entra e sorte continuamente; le botteghe sono aperte, e frequentate dai due sessi; sono pure aperti i caffè, ma frequentati soltanto dagli uomini. Vi si conserva però sempre quel carattere di gravità che si distingue il musulmano.
Non bevendo nè mangiando in tutto il giorno, s'aspetta con impazienza l'ora del mogareb, ossia del cader del sole; al primo segnale dell'el-mùdden, o gridatore pubblico posto in cima alla torre, tutte le persone si pongono in moto, ed all'istante si mangia una specie di pappa di farina, condita col mele e collo zuccaro, o qualche altro manicaretto assai nutriente: si fa in seguito la preghiera, e poco dopo si pranza. Molti mangiano durante la notte tre o quattro volte, io non prendevo che il tè, e la mattina prima dell'aurora una tazza di pappa, o un poco di concoussou.
Il digiuno del Ramadan è appena sentito dal ricco, perchè egli passa la giornata dormendo, e la notte si compensa largamente delle privazioni del giorno; di modo che egli non fa che cambiare l'epoca de' suoi giornalieri godimenti: ma esso è bene una grave penitenza pel poco agiato che deve guadagnarsi il vitto col travaglio del giorno, e perciò non può eludere il rigore del precetto cambiando il suo tenore di vivere. Questo digiuno del Ramadan viene osservato con tanta precisione, che un musulmano che lo rompesse volontariamente senza leggittima causa, e sopra tutto in presenza di testimonj, sarebbe come infedele giudicato meritevole della pena di morte.
I mesi arabi essendo lunari, ed ogni mese incominciando all'istante che scuopresi ad occhio nudo la nuova luna i musulmani sono estremamente attenti ad osservare il cielo; ed hanno in ciò un tatto finissimo ed una vista estremamente penetrante, di modo che più volte m'indicavano il luogo in cui vedevano la nuova luna, ch'io non vedevo altrimenti, e che col soccorso d'un cannocchiale scoprivo in seguito in quel punto preciso del cielo ch'essi mi avevano indicato. La dichiarazione di due testimonj, che attestano innanzi al kadi aver veduta la luna, basta per far proclamare incominciato il mese; e quando le nubi impediscono di vederla, il compimento di trenta giorni del mese precedente dà luogo al nuovo mese.
Onde agevolare queste osservazioni, io calcolavo da prima i giorni in cui le nuove lune potrebbero vedersi, e dava loro questa specie d'almanacco: l'esattezza de' miei pronostici mi avevano conciliata tutta la loro confidenza, e vi si conformavano senza scrupolo per incominciare il Ramadàn e finirlo; di modo che il Sultano ordinò che questa cerimonia non avesse luogo che dietro la mia indicazione.
Il cominciamento del Ramadàn viene annunciato a Fez con molti colpi di fucile tirati da un'altura vicina, e col lugubre suono delle trombette che i pubblici stridatori fanno udire dall'alto di tutte le torri delle moschee; l'istante del fine dello stesso mese, o il cominciamento della pasqua, viene pure annunciato con colpi di fucile tirati dai tetti delle case: infelici coloro che amano la tranquillità, e sopra tutto infelici gl'infermi! essi sono storditi dal numero delle armi da fuoco, e dal grido dell'universale tripudio. Malgrado il carattere augusto che la religione imprime al mese di Ramadàn molti mori del basso popolo, diventano quasi frenetici. Gli uni si riscaldano il capo colle frequenti preghiere, e colla lettura continua del Corano; altri con quella dei libri ascetici, o sacri; altri finalmente colla debolezza del loro stomaco, e colla tristezza che ne è un'inseparabile conseguenza; e tutti sono scossi dall'orribile e funebre suono delle trombe, che dall'alto delle torri si fa udire in diverse ore del giorno e della notte: ciò che cagiona molte contese tra la plebaglia.
Nella notte del 27 avvi continuamente in ogni moschea un ministro, che senza libro recita il Corano ad alta voce, ed il popolo sta in piedi ad ascoltarlo. La recita è interpolata da preghiere; e la persona che recita viene successivamente rilevata da un'altra, talchè allo spuntare del giorno si viene ad aver recitato tutto il Corano. In quella notte sono illuminate le strade ed i terrazzi; immensa è la folla, e le donne vanno in truppa per visitare qua e là le moschee, nelle quali un'infinita quantità di fanciulli d'ogni età, di femmine, di santi imbecilli, buoni e cattivi, fanno uno spaventoso mormorio; che però non impedisce la lettura del Corano, nè le preghiere.
Tutte le notti del Ramadàn avanti l'aurora vi sono degli uomini delle moschee, che scorrono le strade con enormi bastoni battendo a replicati colpi le porte delle case, affinchè gli abitanti si alzino per mangiare avanti l'ora della preghiera del mattino.
Il pellegrinaggio della Mecca è il quinto precetto divino. Ogni musulmano deve almeno una volta in sua vita fare personalmente questo santo viaggio, o darne la commissione ad un pellegrino, che soddisferà per lui, ed in suo nome a questo sacro dovere, nel caso che egli abbia legittimi motivi che lo impediscano di farlo.
L'oggetto di tale viaggio è quello di visitare la Kaàba, o la casa di Dio alla Mecca; le colline Sàffa e Mèrova che sono nella stessa città, ed il monte Aarafat, che trovasi a piccola distanza dalla santa città. L'epoca di queste cerimonie alla Mecca ricorre tutti gli anni nel mese Dulhàja. Molti pellegrini approfittano della circostanza per andare anche a Medina per visitarvi il sepolcro del Profeta; ma questo è un atto di divozione nè ordinato, nè consigliato dalla legge. Ritorneremo altrove su questo argomento.
L'anno arabo essendo composto di dodici mesi lunari, trovasi undici giorni più corto dell'anno solare; e per conseguenza il Ramadan e le pasque fanno il giro dell'anno solare in trentuno o trentadue anni. Ecco i nomi dei mesi arabi
Moharràm.
Safàr.
Ràbioul-aoval.
Ràbiou-zéni.
Diàd.
Ioumeldà (ossia Ioumà).
Arjàb.
Schabàn.
Ramadàn.
Schoval.
Doulkàada.
Doulkàja.
I giorni della settimana chiamansi così
Nahhàr el Khàd – primo giorno – Domenica.
Nahhàr el Zenin – secondo giorno – Lunedì.
Nahhàr el Telàta – terzo giorno – Martedì.
Nahhàr l'Arbàa – quarto giorno – Mercoledì.
Nahhàr el Hhamiz – quinto giorno – Giovedì.
Nahhàr Ioumouà – sesto giorno – Venerdì.
Nahhàr es Sebts – settimo giorno – Sabbato.
I giorni di digiuno e le feste dell'anno sono:
Il 1, 2, 3, e dieci di Moharram per il digiuno.
Non avvi nulla nel mese Safàr.
Il 12 di Rabioul-aoual si solennizza il Moulotid, o la nascita del Profeta: le feste durano fino al 19: ed a quest'epoca soglionsi per l'ordinario circoncidere i fanciulli.
Non v'è niente di particolare ne' tre susseguenti mesi.
Il primo giovedì, ed il 27, del mese d'Arjab sono consacrati al digiuno.
Nel mese di Schaban si passa pregando la notte del 15, e si digiuna il susseguente giorno.
Si digiuna tutto il mese di Ramadan; si fa preghiera la notte, e particolarmente nelle notti del 27, e del 30 che devono interamente consumarsi pregando.
La Pasqua chiamata l'Eïd Seguìr, piccola Pasqua, è fissata nel primo giorno del mese di Schovàl. In questo giorno deve farsi l'elemosina pasquale, di cui si è parlato, e si fa la preghiera pasquale all'Emsàlla di cui si parlerà tra poco. Dopo questo giorno di Pasqua si digiuna sei giorni scelti ad arbitrio nel corso dello stesso mese.
Niente vi è nel mese Doulkaada.
In quello di Doulhaja i musulmani che non vanno alla Mecca digiunano i primi nove giorni. Il 10 del mese incomincia la Pasqua chiamata l'Eïd Kibir o grande Pasqua, la quale dura tre giorni; nel primo de' quali si va subito la mattina a fare la preghiera pasquale all'Emsalla, poi tornato in propria casa si sacrifica un montone in memoria del sacrificio d'Abramo. Egli è a tale epoca che si fanno le ceremonie del pellegrinaggio della Mecca.
Questi mesi sono composti di 29 e di 30 giorni, e l'anno non è che di trecento cinquanta quattro, e per conseguenza il termine dei dodici mesi si compie undici o dodici giorni prima di quello dei dodici mesi solari. Risulta che il Ramadan, e le Pasque fanno il giro dell'anno solare, e non s'incontrano press'a poco nello stesso punto che dopo trentuno o trentadue anni solari, che compongono un anno lunare di più. Il presente anno che è il 1218 dell'Egira ha cominciato il 23 aprile del 1803 di Cristo.
Il digiuno del Ramadan è il solo di divino precetto, gli altri non sono che una pratica religiosa imitativa.
I musulmani contano nell'anno quattro mesi sacri, duranti i quali non si deve senz'esserne forzati, fare la guerra, nè privar di vita un uomo. Sono questi i mesi di moharram, d'arjal, di doulkaada e di doulhaja.
Per la preghiera Pasquale avvi fuori delle città un luogo a ciò destinato, che chiamasi El-Emsàlla, ove s'aduna tutto il popolo la mattina del primo giorno d'ogni Pasqua avanti il levare del sole.
Magnifica fu la festa dell'ultima Pasqua celebrata in Fez dal Sultano. I paschà, i keih, ed i grandi cheik alla testa di numerosi corpi di cavalleria vennero da tutte le provincie dell'impero per felicitare il Sultano, e rimasero quasi tutti accampati fuori della città.
Nel luogo dell'Esmàlla, si formò un recinto di forma quadrata, chiuso da tre lati da una tela di cinque a sei braccia d'altezza, e press'a poco della lunghezza di circa sessanta piedi da ogni banda, con entro una tribuna pel predicatore. Noi eravamo entro questo recinto in numero di circa seicento, e tutta la popolazione di Fez, ed i fedeli venuti dalle provincie, stavano al di fuori in numero di altre dugento cinquanta mille persone. All'arrivo del Sultano incominciò la preghiera. Ogni volta che per i movimenti dei rikat l'Imano ed il Mudden pronunciavano l'esclamazione Allàhou aki bàr! Dio grandissimo! questa veniva ripetuta da un infinito numero di Mudden sparsi tra la folla fino ad una grandissima distanza: ed a tale grido si vedevano prostrarsi innanzi alla divinità dugento cinquanta mille persone aventi il sovrano alla loro testa, e per tempio l'intera natura: spettacolo veramente augusto, che non si può vedere senz'essere profondamente commossi.
Dopo la preghiera un fakih del Sultano salì sulla tribuna, pronunciò un sermone, e la ceremonia si chiuse con una breve preghiera. Il Sultano sortito dal recinto, montò a cavallo, e tutta la sua corte ne imitò l'esempio. Dopo aver fatto un passeggio, durante il quale i diversi corpi delle provincie gli vennero incontro per salutarlo, si ritirò; ed in allora, ebbero cominciamento le corse dei cavalli, le scaramuccie, i colpi di fucile, le grida d'allegrezza ohe si prolungarono tre giorni nella città e nei contorni.
Rimarcabile è la maniera con cui ogni corpo salutava il Sultano. Dopo essersi disposti in linea si presentavano al Sultano coi loro lunghi fucili che si tenevano perpendicolarmente davanti colla mano destra, ed appoggiati sul pomo della sella piegavano il corpo avanti, facendo una riverenza, e gridando ad alta voce tutte le volte Allàh jebark òmor sidina! Dio benedica la vita del nostro Signore! Poi ritiravansi per lasciar luogo agli altri. Il capo di ogni truppa veniva alquanto innanzi, ed avvicinandosi al Sultano, lo salutava in particolare, facevasi conoscere, e faceva segno alla sua gente di avanzarsi e di ritirarsi.
A poca distanza dal Sultano erano molte compagnie della sua guardia a cavallo con un infinito numero di stendardi, ed una banda di tamburri rauchi, e di cornamuse assai discordi. Marciavano presso al Sultano i grandi ufficiali ed alcuni servitori a piedi; e due di questi stavano sempre ai fianchi del suo cavallo con un fazzoletto di seta in mano per scacciare le mosche.
Tra i musulmani non trovansi preti propriamente detti. Quelli che assistono alle moschee non hanno altra marca distintiva che possa farli conoscere, nè alcun carattere che gli dispensi dalle obbligazioni di cittadino: hanno mogli, travagliano e pagano le imposte; in una parola, l'ordine sacerdotale, che negli altri culti forma nello stato una classe separata, non esiste presso i musulmani. Qui gli uomini sono in ogni casa eguali in faccia al Creatore; i templi non hanno luoghi riservati, nè posti privilegiati. La virtù o il vizio sono i soli mezzi che avvicinano o allontanano l'uomo dalla Divinità.
Gl'impiegati delle moschee sono prima gl'Imani, che dirigono la preghiera, predicano i venerdì, e fanno talvolta la lettura de' libri sacri; ed in appresso i Mudden, che chiamano il popolo dall'alto delle torri, e che ajutano gl'Imani nella direzione delle preghiere. Quest'impieghi non imprimono verun carattere in coloro che gli esercitano; e quindi tosto che hanno terminate le loro funzioni, si occupano in altri affari come semplici cittadini. Durante l'assenza d'un Imano dalla moschea, il Mudden, o un altro individuo, o qualunque del popolo si pone alla testa dell'assemblea; dirige la preghiera, e fa le funzioni di vero Imano.
I musulmani non hanno altre feste in tutto l'anno che quelle della Pasqua, e della nascita del Profeta. Il venerdì il musulmano lavora come gli altri giorni della settimana, incominciando la mattina fino ad un'ora avanti mezzogiorno, in cui abbandona la sua officina, o altre sue occupazioni per andar a fare le sue abluzioni, e la sua preghiera alla moschea: torna in appresso al suo travaglio.
Dal fin qui detto si vede che l'islam, o la religione di Maometto, è austera. La parola islamismo vuol dire abbandono di se medesimo a Dio; e su questa primaria base è fondato questo culto.
La credenza nella missione di Noè, di Abramo, di Mosè, di Gesù Cristo e di altri antichi Profeti, è un articolo indispensabile per l'introduzione all'islamismo; di modo che un giudeo non può essere ammesso al corpo dei fedeli, senza che preventivamente abbia dato prove della sua credenza nella missione di Gesù Cristo, riconosciuto come lo spirito di Dio (Rouh Oullàk) e figliuolo di una Vergine: lo che viene attestato dal Corano.
I musulmani sono d'opinione che gli evangelj che trovansi tra le mani de' cristiani siano stati viziati, o corrotti da interpolazioni. Essi negano la morte di Gesù Cristo, che secondo il Corano salì vivo al cielo senza subire il supplizio della croce; non ammettono il domma della Trinità, nè per conseguenza l'unione ipostatica della seconda persona in Gesù Cristo, e nell'eucaristia.
Sgraziatamente sonosi pure introdotte nell'islamismo varie superstizioni, che il musulmano filosofo detesta. Le ceremonie esteriori del culto hanno soverchiato in modo le dottrine fondamentali della religione, che quando un musulmano faccia ogni giorno il numero della prostrazioni o dei rihat prescritti dalla legge, non si guarda alla sua morale, e sarà tenuto buon musulmano; sarà pure inalzato alla dignità di santo, se eccede il numero delle preghiere e dei digiuni legali, quantunque la sua condotta sia quella d'un uomo perverso, com'io ebbi occasione di vederne alcuni esempi.
La venerazione pei sepolcri dei santi ha un utile effetto quando le loro cappelle sono l'asilo dell'innocenza contro gli attentati del despotismo. La venerazione in cui sono tenuti gl'imbecilli, protegge la sgraziata loro esistenza; ma l'asilo delle cappelle conserva altresì un ragguardevole numero di delinquenti, dai quali dovrebbesi liberare la società, ed il rispetto verso gl'imbecilli è cagione di mille attentati contro la pubblica morale. I safi, o talismani, le reliquie, le corone, i recitatori di preghiere per gl'infermi, per le cose smarrite, ec. ec., sono altrettante pie frodi che macchiano il puro deismo di Maometto. Altronde qual è il culto in terra che non sia stato alterato dalla cupidigia dei ciarlatani, o dalla sciocca timidità del popolo? Fortunatamente che nell'impero di Marocco non si vedono quelle greggie monastiche, ossia quei Dervis, che scontransi in tutta la Turchia.