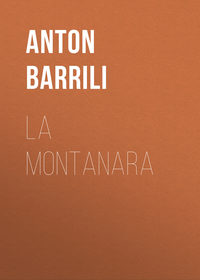Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La montanara», sayfa 21
– Figuratevi! – esclamò il vecchio Malatesti. – Spero anch'io che non si ripeteranno, perchè voi dal canto vostro consiglierete la vostra figliuola a non darne occasione. Elena è una cara donnina, a cui vogliamo tutti un gran bene; ma è giovane, ed ha bisogno di consigli. Ella, del resto, non ha ancora guadagnato il privilegio di fare a modo suo.
– Che cosa intendereste di dire?
– Solamente questo, che la gaia vita delle feste e dei ricevimenti, con tutti i pericoli che ne derivano, si può e si deve rimandarla ad altro tempo; a quel giorno, che arriva pur troppo, e per tutte, in cui le ebbrezze son dissipate, ma almeno la famiglia è assicurata. Non è strettamente morale, ciò ch'io vi dico; – soggiunse il vecchio gentiluomo. – Ahimè! riconosciamo pure che non lo è niente affatto. Ma è secondo gli usi antichi delle grandi famiglie: e questi usi, nella corruzione generale, avevano la loro parte buona. Conserviamo almeno questa parte, marchesa. —
La bella Polissena non fu tarda a conoscere «il velen dell'argomento» come lo avrebbe chiamato il ministro, nella sua smania recente di citazioni dantesche. Ed anche davanti al vecchio Malatesti, la madre furibonda di Elena dovette abbassar le ali e tacere.
Il conte Gino, quella sera, ricondusse a casa sua moglie. Nè si parlò tra di loro di ciò che era avvenuto; nè fu più occasione di tornarvi poi. Del barone De Wincsel nessuna notizia per tutta la settimana. Si seppe più tardi che egli era escito dagli arresti, per ritornarsene a Vienna. Così procedevano allora le cose, nei felicissimi Stati di Modena, Massa, Carrara e Guastalla.
In que' giorni la fanciulla dei Guerri era già ritornata alle Vaie; triste, non rassegnata, ma calma; così calma, da ingannare i suoi, che la videro perfino sorridere. Aveva tante cose da raccontare di Modena! La cuginetta era graziosa, amorosa, veramente carina. Ben presto l'avrebbero veduta anche loro, poichè nel finir della primavera sarebbe venuta a conoscere i suoi nuovi parenti delle Vaie.
Il cugino Ruggero non era meno felice della sposa; e sicuramente doveva esser felice, poichè aveva fatto un'ottima scelta. Buonissima famiglia, quei Campolonghi; ricchi, senza orgoglio di gente nuova, e assai benveduti in città; nel complesso, adunque, un matrimonio eccellente. Si erano fatte gran feste; si era stati allegri; essa, la montanara, non aveva ballato, perchè il ballo non le piaceva, ma aveva preso parte alle gioie degli altri, ed era stata perfino a teatro.
Nessuno le domandò se avesse anche veduto il conte Gino Malatesti.
La povera fanciulla non versò la piena del suo dolore che ai piedi del confessore, del buono e compassionevole Don Pietro.
– Figlia mia! – esclamò egli. – Ve lo avevo pur detto! Perchè andare laggiù?
– Ebbene, che c'è di male? – replicò la fanciulla. – L'ho veduto, e son qua, più forte a soffrire, che non mi sentissi da prima. Essa è bella, padre mio, molto bella; ma egli è infelice. Gli ho perdonato; pregheremo per lui. —
Capitolo XVIII.
Per l'Italia
Aminta Guerri non aveva perdonato. Indole schietta e sana, uomo tutto d'un pezzo, come si diceva una volta (e si diceva, perchè si usava ancora esser tali), Aminta ignorava certe transazioni dalla coscienza, per sè, e non le intendeva negli altri. Chi prometteva una cosa e ne faceva un'altra, era per lui un mancatore di fede: ed egli non concedeva a quell'uomo le circostanze attenuanti, se non per mutare il suo odio in disprezzo.
A questi patti, voi lo intendete, Gino Malatesti non poteva sperar nulla di buono da lui. Avrebbe dovuto resistere ad ogni volontà, sfidare ogni pericolo, per meritare la stima e l'affetto di Aminta. Un po' di carcere ai suoi amici!.. Ebbene, tanto meglio. Non era quello il tempo da ciò? Vengono pure i bei momenti eroici, per un popolo sventurato! Poveri i vecchi a cui era mancata perfino l'occasione di farsi utilmente vivi a quel modo! Ma allora, vivaddio, anche il carcere era una battaglia, e doveva esser lieto chi ci andava, e render grazie a chi gliene porgeva occasione.
Vedete infatti; di tanti martirii, di tante sofferenze, s'incominciava a raccogliere il frutto. Gravi risoluzioni erano state prese nel segreto dei colloquii diplomatici, e quel segreto lo sapevano tutti, in Italia. Il Piemonte si armava a furia; la Francia, la nobile Francia, caldeggiava l'impresa. Ancora qualche mese, e una frase severa di Napoleone III all'ambasciatore austriaco appiccava il fuoco alle polveri. La guerra imminente! E qual guerra! La guerra divina, di tutto un popolo contro i suoi oppressori. Lungamente abbracciato dai suoi, benedetto dal padre. Aminta Guerri andò per certi negozi domestici fino a Massa, nella primavera del 1859. Da Massa si avviò a Carrara; di là scese alla Magra e non respirò fino a che non ebbe passato il confine. Era libero, libero; non aveva più birri alle calcagna, non più timore di carceri ducali. Da Sarzana, viaggiando a furia, si recò a Genova; e là, prima ancora di entrare in un'osteria per mangiare un boccone, veduti alcuni soldati per via, domandò loro dove avessero il quartiere.
– In piazza di San Leonardo, – gli dissero, – ma il quartiere si chiama di Sant'Ignazio. C'è il deposito del 7^o reggimento.
– Che significa il deposito?
– Significa che il reggimento è già partito; qui non c'è che un battaglione di deposito, per gli arruolamenti, per la contabilità, e per tante altre cose che non sappiamo noi. Siamo volontarii, e non lo conosciamo per altro che per gli arruolamenti.
– Volete accompagnarmi, camerata? – disse Aminta al volontario che gli aveva dati i ragguagli.
– Volentieri; ma badate, ci si dà del tu, tra compagni d'arme.
– E diamoci del tu; non domando di meglio. —
Il volontario parlava italiano con uno spiccato accento veneto. Disse il suo nome; era un Fogazzaro, di Verona, bruno, ben fatto, simpatico a quel Dio, e spesso parlava in versi.
– Ma non è roba mia; – soggiungeva subito; – son versi di Aleardo Aleardi, il nostro gran poeta, che gli Austriaci hanno mandato nella fortezza di Josephstadt. —
Ventisei anni fa (non dimentichiamo la data) l'Aleardi era un gran poeta, e nessuno era ancora saltato fuori ad accusarlo di languori, di svenevolezze, quasi, Dio ci perdoni, di rammollimento, d'infiacchimento della balda gioventù italiana. Aminta Guerri doveva trovare i Canti di quel poeta in molti zaini di combattenti. Ora tutti li hanno in tasca, e non per rileggerli!
L'amico Fogazzaro condusse Aminta per certi traghetti, viottole, discese e salite, fino al colmo di una collina, dov'erano due conventi tramutati in caserme. Entrato in uno di questi, e detta una parola al soldato di guardia, fece salire il borghese al pian di sopra, gli mostrò un uscio su cui era scritto: «Maggiorità» e gli disse:
– Va dentro, e fàtti soldato d'Italia; io ti aspetto nel corridoio. —
Entrato nella camera, e ammesso alla presenza di tre ufficiali, uno dei quali aveva il grado di maggiore. Aminta Guerri disse il suo nome, la patria, e che volesse da loro. Aveva le carte e le mostrò; fu misurato, esaminato, approvato; ebbe un numero di matricola, fu consegnato ad un sergente, perchè lo conducesse con altri al magazzino del vestiario. Un'ora dopo era soldato d'Italia, col suo farsetto di tela e il suo berretto di cotone, in attesa del cappotto grigio e del cheppì, che sarebbe andato a cercare in giornata. Per intanto, se voleva, andasse a prendere la sua razione di pane.
– È buono, sai, il pane di munizione; – gli disse l'amico Fogazzaro. – Lo chiamano di munizione, perchè coi pezzettini di crosta e magari della mollica, si può caricare il fucile e far buon colpo, come con le palle di piombo. Ma non badare; lo digerirai stupendamente anche tu, dopo che saremo andati a San Benigno, a caricare un centinaio di brande, e di là saremo ritornati a Sant'Ignazio. Tutti santi, qui! – soggiunse il Fogazzaro; – e la loro lontananza te li fa invocare cento volte in un giorno. Dico invocare…
– Ho capito, ho capito; – rispose Aminta, ridendo.
Il nostro giovanotto andò quel giorno a San Benigno per le brande, e dormì quella notte nel letto che aveva portato sulle spalle, attraverso le vie della città. La mattina seguente faceva parte della squadra che andava per i viveri, e portò sulle spalle un bel peso di carne sanguinante. In quella gita ebbe il piacere di sentir la parlata domestica, e di conoscere nel suo compagno di fatica un altro modenese. Si chiamava Prampolini, era avvocato, poeta alle sue ore anche lui, innamorato del Leopardi, grande ammiratore di Pietro Giordani.
La compagnia, come vedete, non poteva esser migliore. Andare alla fatica qua e là, stare a lavorar di scopa in quartiere, mangiar la zuppa nella gamella, parlando di letteratura e d'arte, citando i poeti e gli scrittori della patria, in verità, era una festa. E come si rideva! Non sempre, per altro, non sempre; qualche volta alla schietta risata bisognava sostituire l'occhiata, l'ammicco intelligente, che obbligava a sforzi erculei, per tener chiusa la bocca. Ciò avveniva quando si era «in rango» per dare il numero, o per staccare il passo in buon ordine, al cenno di un vecchio sergente, o per sentire la nomenclatura di tutti i pezzi del fucile, con le analoghe spiegazioni, in una lingua che non aveva nè babbo nè mamma. Nei primi esercizi, il comando «al tempo!» che indicava di rimettersi in posizione, per ripetere un movimento sbagliato, era sempre argomento di ilarità rumorose, che facevano scappar la pazienza, ma poi anche le risate al sergente. Alla domenica, prima di escire dal quartiere, dovevano rimettersi «in rango» per sentire la spiegazione del regolamento, fatta dal caporale di settimana. Il caporale, avvezzo al suo dialetto, maltrattava la lingua madre, e allora i volontarii ad osservargli: – «Scusi, signor caporale, non abbiamo capito.» – Ah, non capite? Non capite? – ribatteva il caporale. – Ebbene, se non capite l'italiano, i vadd a spieghevlo 'n piemonteis!»
Era buono, il caporale; una vera pasta di zucchero, ad onta della sua severità apparente. Dopo il comando: «rompete le righe» per cui erano tutti liberi di andare dove loro piacesse, Aminta andava a presentare le sue scuse.
– Ma se lo so! – esclamò il caporale rabbonito. —I seve d'bravi fieui; ma, con tutti i vostri dialetti, non capite l'italiano. Basta, fra poco faremo tutti una sola famiglia, e parleremo piemontese. Non è vero che lo capite, il piemontese? —
Erano belli, quei vecchi soldati piemontesi delle due classi del 1828 e del 1829, richiamati allora sotto le armi. Avevano fatte le campagne del Quarantotto e del Quarantanove; poi, ritornati alle case loro, e non pensando più di dover ripigliare il fucile, erano diventati uomini gravi e pacifici; la più parte si erano anche ammogliati. Ma anch'essi, i Contingenti, come si usava chiamarli, anch'essi sentivano l'onta di Novara, e fieri e contenti erano venuti a raccogliersi sotto le note bandiere, maestri di guerra, narratori di liete e di dolorose gesta, alle classi più giovani. Uno di essi, un Cucchietto, nativo dell'alto Piemonte, aveva fatto parte del triste manipolo cui era toccato di passare per le armi il general Ramorino: un soldato (diceva egli) che era morto bene e che non era un traditore. – «Ma allora, – chiedevano i giovani, – perchè è stato fucilato?» – «Per aver disobbedito, per aver voluto fare di sua testa» – rispondeva il contingente, con quel suo tono assoluto.
Non bisognava far di sua testa: bisognava obbedire; questa era la regola. E si obbediva; e obbedivano tutti, in quel benedetto esercito. Tipi di gentil gravità e di ferrea disciplina, accettata per sè, voluta egualmente negli altri, erano quegli ufficiali che Aminta doveva ben presto conoscere, dal colonnello Berretta fino a Carlo Rivalta, il più giovane fra i sottotenenti del reggimento. Rigido osservatore dei regolamenti, ma buono per il soldato, quell'aiutante maggiore Coppier, con quelle sue gambe lunghe e sottili, per cui era chiamato «il capitano più grande del vero,» e con quel suo gran naso, che stava a cavaliere di una bocca femminea, donde non era mai escita una mala parola. In mezzo a quella gravità i volontari recavano la loro gaiezza; ma non era una gaiezza baldanzosa; era una gaiezza disciplinabile, già mezza disciplinata fin dai primi giorni di quartiere; era l'esuberanza di vita, propria della gioventù intelligente, governata dall'amor patrio, contenuta dalla dignità dell'esempio.
In capo ad otto giorni Aminta Guerri aveva imparato il maneggio del fucile e le prime evoluzioni di compagnia. La mattina del nono giorno, sul piazzale della Cava, sotto la guida del sergente Bernaroli, compieva la sua educazione militare con la scherma di baionetta. Sapete? quella scherma famosa con cui il fantaccino para tutti i colpi del cavaliere e finisce infallibilmente a buttarlo giù dall'arcione. S'intende che nei depositi di cavalleria s'insegnava in pari tempo al cavaliere la scherma di sciabola, per cui gli era dato di disarmare il fantaccino, facendogli saltare la baionetta dalla canna, infallibilmente, in tre colpi.
La mattina del decimo giorno, un grosso drappello di volontarii, così addestrati al mestiere, lasciava il deposito, per andare a raggiungere il reggimento, già in linea sulle rive della Sesia. La strada ferrata da Genova ad Alessandria era tutto un passaggio di soldati d'ogni forma e colore. Egualmente da Alessandria a Novara, poichè, dopo Montebello, Frassineto, Palestro e Vinzaglio, i due eserciti alleati avevano mutata la linea di operazione e l'obbiettivo, spingendosi rapidamente a minacciare il nemico verso il centro politico, e strategico per conseguenza, delle sue fiere difese. Da Novara si andava allora più speditamente su Milano, e l'esercito combattente non si sarebbe potuto raggiungere che sulla via di Magenta. Avanti dunque a Novara, drappelli di tutte le armi, soldati piemontesi e soldati francesi, bersaglieri e cappotti grigi, zuavi, cacciatori di Vincennes e artiglieri della Guardia imperiale. Si stava a disagio, nelle carrozze; si esciva fuori dai finestrini, per aggrapparsi alle prime sporgenze e rampicarsi fino ai sopraccieli, dove si posava finalmente, ammirando la campagna e respirando l'aria libera. Il fumo, anche! Ah! che fumo d'Egitto? Importava poco, il fumo della vaporiera. Del resto, a que' tempi, sulle strade ferrate non si bruciava ancora che carbone. E si andava allegri, salutando le stazioni con grida fraterne, cantando tutte le canzoni patriottiche di quell'anno, e quelle di dieci anni addietro, ma più spesso e più volentieri la Bella Gigogin, una scioccheria smisurata, che esprimeva benissimo la spensieratezza di quel tempo e di una generazione molto sicura del fatto suo. Anche i soldati francesi cantavano la Gigoginne, facendo un grazioso miscuglio di parole italiane, piemontesi, lombarde, con desinenze di Francia.
Da Novara si cominciò a far cammino a piedi. Si entrò a Magenta ancor seminata di brandelli di carne e fumante di sangue: orrendo spettacolo, che pur sollevava gli spiriti! A Milano gran meraviglia per il Duomo, e grande allegrezza per le accoglienze fraterne, più belle a gran pezza del Duomo. E via, il giorno dopo, per correre sulle traccie dei reggimenti, che erano sempre due marcie più in là. Correvano tutti, quei reggimenti benedetti, perchè Garibaldi era volato su Brescia, e bisognava collegarsi con lui. Piemontesi e Francesi, cappotti grigi e calzoni rossi, cheppì e turbanti, penne di cappone ondeggianti all'aria e nappine azzurre battenti sugli omeri, si andava tutti di conserva, spesso nelle fermate confondendosi, sulle piazze barattando gli abiti e le insegne, ballando insieme, senz'altra musica fuor quella che si sprigionava dai cuori.
Andiamo, corriamo anche noi; se no, finiremo Dio sa quando. Gli eserciti alleati erano in linea da Desenzano a Montechiaro. Il giorno 24 di giugno, fu San Martino di Pozzolengo da un lato e Solferino dall'altro; una grande giornata, una battaglia napoleonica per la massa in azione, per lo sforzo maraviglioso, per gli effetti strategici. Aminta Guerri prese quel giorno il suo battesimo di fuoco. Ci capì poco, anzi nulla, come in ogni battesimo avviene al battezzato; non ebbe altra impressione del fatto, e non serbò altro ricordo che quello di un grande intronamento di orecchi.
Gli eserciti alleati non riposavano sugli allori. Inseguito fino al Mincio il nemico fuggente, investirono la piazza di Peschiera. I Piemontesi, mantenendo la prima disposizione dei corpi combattenti, piantarono il campo sulla sinistra, e incominciarono tosto i lavori d'approccio. Aminta aveva fatto il facchino e lo spazzaturaio in caserma; imparò a fare lo zappatore, scavando fossi e rizzando parapetti. Rafforzato il campo, scavate le vie coperte, si incominciò a lavorare di notte, poichè le parallele giungevano troppo sotto gli occhi della piazza assediata, e l'opera, continuata di giorno, poteva essere più facilmente guastata. Ma anche di notte, e come gli era concesso dall'oscurità, vigilava il nemico. Dai bastioni, ad ogni tanto, partivano razzi, illuminando la campagna; poi, sotto l'arco dei razzi, veniva la corda delle cannonate. Era dunque un lavoro utile, da parte degli assedianti, il notturno; ma era anche oscura la morte, quando toccava.
Nella sera del 30 giugno il battaglione di Aminta fu comandato di avamposto; noioso servizio, poichè la notte avanti gli era toccato il faticoso, cioè quello di lavorare nelle trinciere. Ma pazienza; quando si è in mare si naviga, e quando si è in terra si va. Il battaglione, messo in ordine di marcia due ore dopo il rancio, partì dalla cascina Fedalora, intorno a cui era formato il campo, e si avviò per la nota strada che metteva ai lavori d'approccio; poi, ad un certo punto, piegò a sinistra, nella direzione del lago, per non dar nell'occhio al nemico, che vigilava sui bastioni. Sull'imbrunire, ripiegando nuovamente a destra, giungeva ad un casolare, dove si stabilì la gran guardia, e di là si spiccarono due compagnie, per procedere ancora verso i forti. Una di esse rimase ad un certo punto in sostegno; l'altra, che era quella di Aminta, proseguì la sua strada, lasciando ancora qualche manipolo d'uomini lungo le prode dei campi, per collegare le sentinelle avanzate ai sostegni. La notte era sopraggiunta, e le due ultime squadre della compagnia, guidate da un tenente, s'inoltravano ancora pei campi, seguendo certi sentieri fiancheggiati da piccole siepi d'acacia. Il tenente collocò due posti di quattro uomini, poi un terzo, poi un quarto, e finalmente le sentinelle avanzate. Aminta ci capiva poco, e ci vedeva anche meno, per il gran buio che regnava in que' luoghi, interrotto solamente a quando a quando dai razzi, a cui tenevano dietro le cannonate del nemico. Altro non vide e non intese che questo: dietro una svolta del sentiero era stato collocato con tre uomini il caporal Piras, suo superiore immediato; di là dalla svolta, dieci quindici passi più oltre, era collocato lui in sentinella.
– Tu rimarrai qui; – gli disse infatti il tenente, dopo averlo condotto sul posto, di contro ad un muro a secco, che sosteneva un campo e lo divideva dal sentiero.
– Che debbo fare, signor tenente? – domandò il giovanotto.
– Ah, siete volontario? – riprese il tenente, udendo la parlata del fantaccino.
– Sissignore.
– E siete alla vostra prima guardia?
– Sissignore.
– Se lo sapevo, mettevo qua un altro; – borbottò il tenente.
– Che importa? – disse Aminta. – Mi dica quel che ho da fare, e lo farò come un altro.
– Lo credo, lo credo, e supplirete con la buona volontà all'esperienza; – rispose il tenente. – Badate dunque; voi siete da questa parte l'ultima sentinella del campo. Da questo sentiero, in mezzo a piantagioni di grano turco, si riesce all'aperto, sotto le fortificazioni del nemico. Non vi occupate di ciò che può accadere altrove; guardate là, davanti a voi, attento ad ogni rumore che possa darvi indizio di gente che s'avvicina. Al primo calpestìo date il «chi va là?», scambio di sparare, come fanno i novellini, mettendo sossopra i compagni, e spesso per una cosa da nulla. Date il «chi va là» come vi ho detto; poi, quando siete ben certo che si tratta di uomini, non di ramarri, o di lepri, sparate in quella direzione il vostro colpo, e vi ritirate, ricaricando, sulle altre sentinelle.
– Dove sono? – chiese Aminta.
– Le avete vedute; qua dietro, sulla vostra destra. Dopo la svolta troverete le prime, e via via tutte le altre, sempre sulla destra, se date le spalle al nemico. Spero bene che non gliele darete, – soggiunse il tenente; – perciò non diremo più sulla vostra destra, ma sulla vostra sinistra, guardando il nemico, e sulla sinistra del campo. Se il nemico si avanza in forze preponderanti, vi sarà facile avvedervene, e avrete tempo a ripiegarvi sulla compagnia di sostegno.
– Sissignore; – disse Aminta.
– A proposito, e per ogni buon fine, – disse ancora il tenente, – se dato il «chi va là?» vi fosse risposto da amici, eccovi il santo e la parola d'ordine: San Martino, Malplaquet. Ve ne ricorderete?
– Sissignore, non dubiti.
– Bene! e adesso, buona guardia! —
Così dicendo, il tenente metteva con gesto amorevole la mano sulla spalla di Aminta. Ma gli cadde anche addosso con la persona, mentre si udiva un gran rombo, e una vampa, un'ondata di fuoco, passava, tingendo l'aria di un rosso cupo.
Aminta credette lì per lì che il tenente gli fosse cascato morto tra le braccia. Povero tenente Parodi, così buono coi soldati! Non era più giovane, il tenente Parodi, e aveva disegnato, appena fosse finita quella campagna, di prendere la sua giubilazione. Si sapeva nel reggimento che una brava donnina l'aspettava, per dargli la mano di sposa. Povero tenente Parodi!
Ma non era nulla, per fortuna; un urto dell'aria, uno stordimento momentaneo, da cui il tenente si riebbe subito.
– Diavolo! – esclamò egli, rialzandosi. – Una palla da trentasei, passata troppo vicina. Ho sentito il soffio caldo sulla guancia. Consoliamoci che non sia stato un bacio! —
Aminta, al lume improvviso di quella vampa aveva anche intravveduto che il sentiero era molto stretto.
– Se passano di queste giuggiole, – diss'egli, – si sta male davvero!
– Vedete di che si tratta; – ripigliò il tenente. – Bisogna accostare le spalle al muro. Gli occhi di là, mi raccomando; e non colpi inutili, che guasterebbero il sonno alla gente. —
Ciò detto, il bravo tenente se ne andò; fatti quindici passi, era alla svolta del sentiero.
Aminta era rimasto solo, sentinella avanzata, sentinella morta, cioè l'ultima del campo, in luogo pericoloso, la più vicina al nemico. Questo pensiero sosteneva il suo spirito, abbattuto dai terrori della notte. La battaglia di giorno è gloriosa; si procede alla luce del sole, che intorno a voi tinge d'oro ogni cosa e vi dà l'illusione dell'andare a guisa d'un dio antico, entro una nuvola luminosa, mentre i fumi della polvere vi esaltano, come i fumi di un vino generoso. Ma la vigilia di nottetempo, soli, come abbandonati da tutti, con un nemico vicino e invisibile, tra insidie che si tendono nell'ombra, agguati che si preparano, a cento, a cinquanta, a venti passi da voi, è la cosa più triste che si possa immaginare. Aminta doveva star là con l'orecchio teso; non poteva sparare senza una cagione ben certa. Di questo egli si era già persuaso nelle notti antecedenti, passate sotto la tenda, quando una schioppettata rompeva il silenzio della campagna, e subito altre schioppettate rispondevano a quella, e in due minuti s'impegnava un fuoco d'inferno su tutta la linea degli avamposti. Allora, su, tutti! Bisognava correre ai fasci d'armi, e, se il fuoco continuava, disfare anche le tende, mettersi in ordinanza, con lo zaino in ispalla, pronti a marciare. Non era stato che un falso allarme; il fuoco cessava. Allora si rifacevano i fasci d'armi e si deponeva lo zaino; ma intanto, poichè l'alba era vicina, non si rifacevano le tende, e si battevano i denti, aspettando che battessero la diana i tamburi.
Dunque, non colpi inutili. Ma se fosse stato sorpreso, senza poter dare l'allarme con una schioppettata! Aminta si tenne a buon conto col fucile alto, con l'indice al grilletto e il pollice al cane. E stava là, ritto impalato, vedendo i razzi che descrivevano la parabola davanti a lui, e sentendo le cannonate. I colpi erano regolari; ogni cinque minuti ne veniva uno. Quando il razzo fischiava, illuminando un tratto di paese, egli diceva tra sè: – Ecco, è qua che arriva; questa è la buona! —
Ancora tre cannonate infilarono la viottola dov'egli stava in sentinella. Così almeno gli parve, poichè, sentendo il colpo, vide anche passare l'ondata dell'aria rossastra, e molto bassa, come la prima volta, quando c'era il tenente. Quel fuoco assiduo, ragionandoci su, non gli dispiacque. Fino a tanto che erano cannonate, non doveva esserci pericolo di ricognizioni. Il nemico sicuramente non avrebbe tirato addosso ai suoi esploratori.
Pure, ad ogni tratto, si sentivano rumori, da quella parte che egli doveva guardare. Quante volte non fu per gridare il suo «chi va là?» Ma capì che erano lepri, ramarri, come diceva il tenente, o martore, od altri animali predatori dei campi.
Rimase molte ore in quel posto. L'esercito faceva un servizio stupendo; metà degli uomini lavoravano nelle parallele; i battaglioni d'avamposto, costretti a custodire un gran raggio di terreno, non potevano cambiare di quattro in quattr'ore le guardie. Del resto, vigilare in un luogo, vigilare in un altro, era tutt'uno, e la conseguenza era questa, che non si dormiva in nessuno. Aminta non aveva che una noia di più: quella di tenere il fucile alto, e l'indice al grilletto e il pollice al cane. Un vecchio soldato non avrebbe fatta quella inutile fatica; ma il nostro Aminta aveva promesso di supplire con la buona volontà al difetto d'esperienza, e voleva esser pronto ad ogni occasione, senza perdere un minuto secondo.
Finalmente le cannonate cessarono. Era il caso di stare più attenti di prima. Che rabbia! Proprio allora incominciavano a cascargli le braccia. Provò a rimanere col fucile abbassato, ma in linea orizzontale, tenendolo con ambe le mani nei punti buoni. Quello era il suo modo di riposare le braccia.
Era forse da un'ora in attesa, quando gli parve di sentire un frussi frussi davanti a sè. Un altro ramarro? o una lepre? No, era stato un rumore più forte; ma era anche cessato. Forse un manipolo di nemici, che voleva andare guardingo, e perciò, fatto un po' di strepito per inavvertenza d'un soldato, si fermava tosto, per distrar l'attenzione delle sentinelle morte? Ah, se queste era, il nemico fallava i suoi conti, perchè l'attenzione di Aminta era più tesa che mai. Ancora uno strepito, il suono di cosa che strisci violentemente tra le foglie; certamente un uomo che s'avanza in un campo di grano turco; poi più nulla: poi da capo un rumor sordo, ma cadenzato, uniforme. Aminta è cacciatore e non ricorda più che gli usi del cacciatore; si abbassa, mette l'orecchio a terra ed ascolta. Non c'è più dubbio; son passi d'uomini; e di là, donde vengono, son passi di nemici.
Sorse in piedi, rimise il fucile al petto e aspettò ancora due minuti. Il rumore dei passi cresceva; oramai si sentiva allo sbocco del sentiero.
– Alt! chi va là? – gridò egli con voce poderosa.
Gli rispose un colpo di fucile. La palla passò sovra la sua testa, gnaulando.
Stavolta non e' era più dubbio; poteva tirare con cognizione di causa. Spianò il fucile e lasciò andare il suo colpo. Quindi, cercando una cartuccia nella giberna, si ritirò, secondo la consegna. Giunto alla svolta, aveva già calcata la cartuccia in fondo alla canna, e rimetteva a posto la bacchetta, quando si sentì dare il «chi va là?» ma con voce sommessa.
– Savoia; – rispose.
– Ah sei tu, Guerri?
– Son io, caporal Piras; – replicò egli, che aveva riconosciuta la voce del superiore.
– Che c'è?
– Il nemico.
– Ne sei ben sicuro?
– Perdio! Ho dato il chi va là, e mi hanno risposto con una schioppettata.
– È giusto; – disse il caporale. – Infatti ne ho udite due. – Ma arriviamo fino alla svolta, per sentire se si avanzano. —
Mossero allora verso l'angolo: il caporal Piras, piccolo sardo animoso, il soldato scelto Guenzi, che era con lui, e il nostro Aminta, volontario, che stava adattando un altro cappellotto al luminello del suo fucile.
Giunti laggiù, udirono i passi di gente che si avanzava lenta, fermandosi ad ogni tratto, come per ascoltare.
– Punta sulla mia spalla; – bisbigliò il caporale all'orecchio di Aminta; – e tu, Guenzi, un passo più in là, ma pronto subito a ritirarti. Ci siete? Fuoco! —
Tre colpi partirono, e i tre tiratori furono pronti a nascondersi dietro l'angolo. Parecchie fucilate risposero, e non solamente dal sentiero, ma anche da un campo che era più in là, poichè i nostri sentirono fischiare qualche palla entro la viottola, dove si credevano al riparo.
– Non importa; – disse il soldato scelto Guenzi, un piemontese di buon umore. – A qualcheduno l'abbiamo accoccata, e noi siamo sani tutti e tre.
– Animo, Via! – disse il caporal Piras; – ripieghiamoci sulle altre sentinelle. —
I due soldati obbedirono al comando, e appena furono al posto più vicino, ricaricarono i fucili.
– Che c'è, caporal Piras? – domandarono le sentinelle.
– Una pattuglia austriaca, – rispose il caporale. – Aspettiamo che si presenti, per mandargli la seconda di cambio. —
L'alba era vicina, e un leggero barlume, diffondendosi per l'aria greve, permetteva di distinguere appena i profili dei bastioni e il lungo dorso di monte Baldo. Le fucilate ricominciarono, da una parte e dall'altra; ma la ricognizione austriaca veniva innanzi molto lentamente. Ed era naturale, poichè tastava terreno davanti a se, volendo sapere dove fosse e come in forza il nemico.
Le sentinelle si erano ripiegate sui posti avanzati: e così, procedendo verso sinistra, e facendo ad ogni tanto i loro colpi, giungevano ad un punto dove il sentiero si spartiva in due.
– Caporal Piras, dov'è la ritirata?
– Sempre a sinistra, ha detto il tenente. Dunque per di qua. —
Entrarono allora risoluti nella viottola più bassa. Erano in quindici, e restavano in quindici, tra soldati e caporali. Ma dov'era il sergente Jemina, che avrebbero dovuto trovare per via? Già troppo cammino avevano fatto, dopo quel bivio, senza trovare nessuno, nè soldato, nè sott'ufficiale. E il fuoco continuava dai campi; e il nemico si avanzava, disposto a ventaglio, ma non per far fresco, davvero!