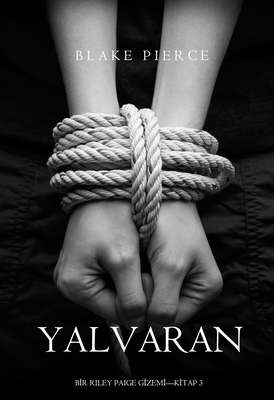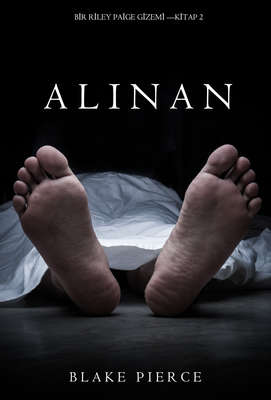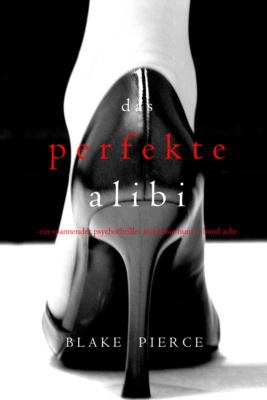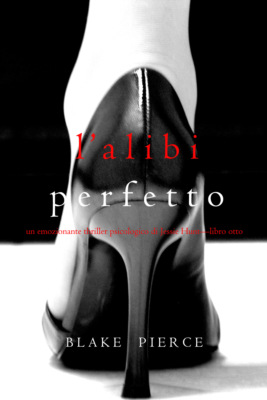Kitabı oku: «Il Killer della Rosa», sayfa 13
Capitolo 26
Riley arrivò alla camera mortuaria a Georgetown poco prima dell'inizio previsto del funerale di Marie. Aveva paura dei funerali. Per lei era più difficile parteciparvi anche rispetto ad arrivare su una scena del crimine con un cadavere assassinato da poco. Inevitabilmente le entravano dentro in un modo terribile. Ma Riley sentiva di dovere ancora qualcosa – non sapeva cosa – a Marie.
La facciata della camera mortuaria era costruita con pannelli prefabbricati di mattoni e sfoggiava colonne bianche nel portico frontale. Entrò in un foyer decorato con tappeti e dotato di aria condizionata e da lì proseguì in un corridoio con carta da parati in semplici colori pastello studiati per non essere né deprimenti né festosi. L'effetto però si ritorse contro Riley, trasmettendole un senso di disperazione. Si chiese perché le camere mortuarie non potessero essere semplicemente quei posti tetri e non invitanti che in realtà avrebbero dovuto essere, come mausolei e obitori, senza questi orpelli ipocriti.
Riley oltrepassò svariate stanze, alcune con bare e visitatori, altre vuole fino ad arrivare a quella in cui doveva celebrarsi il servizio funebre di Marie. All'estremità opposta della stanza vide la bara aperta, realizzata in legno lucido con una lunga maniglia in ottone lungo i lati. Nella stanza si erano raccolte forse due dozzine di persone; molte erano sedute, alcune parlavano tra loro sottovoce. Nella stanza risuonava una dolce musica di organo. Una piccola coda si era formata davanti alla bara.
Si mise in fila e presto si trovò in piedi dietro la bara, ad osservare Marie. Sebbene Riley si fosse preparata mentalmente, quella vista le fece male e sussultò. Il viso di Marie era innaturalmente rilassata e serena, non distorta nell'agonia, come l'aveva vista impiccata dal lampadario. Questo volto non denotava stress o paura, come era stato quando avevano parlato di persona. Sembrava tutto sbagliato. Anzi, sembrava molto peggio che sbagliato.
Si allontanò rapidamente dalla bara e notò una coppia un po' più anziana che sedeva nella prima fila. Suppose che fossero i genitori di Marie. Al loro fianco vi erano un uomo e una donna approssimativamente dell'età di Riley. Immaginò che si trattasse del fratello e della sorella di Marie. Riley frugò nella sua memoria, tentando di ricordar le conversazioni con Marie, e ricordò che i loro nomi erano Trevor e Shannon. Non aveva invece idea dei nomi dei genitori di lei.
Riley pensò per un attimo di fermarsi a porgere loro le sue condoglianze. Ma come si sarebbe presentata? Come la donna che aveva liberato Marie dalla prigionia solo per trovare mesi dopo il suo cadavere? No, doveva essere l'ultima persona che avrebbero voluto incontrare in quel momento. Era meglio lasciarli in pace nel loro dolore.
Mentre si faceva strada verso il fondo della stanza, Riley si accorse di non conoscere nessuno lì. La cosa sembrava strana e triste al tempo stesso. Dopo tutte le ore trascorse a videochattare all'infinito e i loro incontri di persona, non avevano un solo amico in comune.
Ma avevano un terribile nemico in comune, lo psicopatico che aveva sequestrato entrambe. Era qui oggi? Riley sapeva che di solito gli assassini andavano ai funerali delle loro vittime e visitavano le loro tombe. Nel fondo del suo cuore, per quanto sentisse di dovere a Marie quella partecipazione, doveva ammettere che quella era la vera ragione per cui era venuta quel giorno. Trovare Peterson. Era anche la ragione per cui aveva portato con sé un'arma nascosta: la sua Glock privata, che di solito teneva chiusa nel cruscotto della sua auto.
Spostandosi verso il fondo della stanza, osservò attentamente i volti di quelli già seduti. Aveva visto la faccia di Peterson alla luce della sua torcia e aveva osservato molte fotografie. Ma non lo aveva mai visto bene faccia a faccia. Lo avrebbe riconosciuto?
Il suo cuore batteva forte mentre guardava ogni volto con sospetto, cercando in ognuno quella di un assassino. Tutti presto finirono per formare una massa indistinta di volti segnati dal dolore, che ricambiavano perplessi il suo sguardo.
Non vedendo alcun evidente sospetto, Riley sedette in un posto laterale nelle file posteriori, lontana da tutti e da dove poteva vedere chiunque entrasse ed uscisse.
Un giovane sacerdote salì su un pulpito. Riley sapeva che Marie non era stata credente, per cui la presenza del sacerdote doveva essere stata un'idea della famiglia. I ritardatari si sedettero e tutti tacquero.
Con voce calma e professionale, il sacerdote iniziò con parole familiari.
“‘Anche se attraverso la valle dell'ombra della morte, non temo alcun male, perché tu sei con me; il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.”
Il sacerdote si fermò per un attimo. In quel breve silenzio, una sola frase riecheggiò nella mente di Riley …
“Non temo alcun male.”
In qualche modo, la frase colpí Riley, come un'espressione grottesca e inappropriata da dire. Che cosa voleva dire “non temere il male”? Come poteva essere una buona idea? Se Marie avesse avuto più paura mesi addietro, se fosse stata più sospettosa, forse non sarebbe mai caduta nelle grinfie di Peterson.
Questo era sicuramente un tempo in cui si doveva aver paura del male. Era ovunque là fuori.
Il sacerdote riprese a parlare..
“Amici, ci siamo riuniti per piangere la scomparsa e ricordare la vita di Marie Sayles—figlia, sorella, amica e collega …”
Il sacerdote poi si lanciò in una stucchevole antologia di luoghi comuni sulla perdita, sull'amicizia e sulla famiglia. Benché descrivesse la dipartita di Marie come prematura, non fece cenno alla violenza e al terrore che avevano segnato le ultime settimane della sua vita.
Riley smise presto di ascoltare il sermone. E, immediatamente, le tornarono in mente le parole di Marie nella lettera di addio.
“Questo é il solo modo.”
Riley sentì un forte senso di colpa in sé crescere tanto da non poter quasi respirare. Avrebbe voluto alzarsi davanti a tutti i presenti, spingere via il sacerdote e confessare a quell'assemblea che tutto questo era colpa sua, interamente colpa sua. Aveva tradito Marie. Aveva tradito chiunque amasse Marie. Aveva tradito se stessa..
Riley ricacciò indietro il bisogno di confessare ma il suo disagio iniziò a manifestarsi con brutale chiarezza. Prima c'erano stati i mattoni prefabbricati, quelle stupide colonne bianche e i colori pastello, che adornavano la camera mortuaria. Poi c'era stata la faccia di Marie, così innaturale e pallida nella bara. E ora quel predicatore, che gesticolava e parlava come una sorta di giocattolo, un automa in miniatura, e l'assemblea di piccole teste che si alzavano e abbassavano mentre parlava.
É come una casa delle bambole, comprese Riley in quel momento.
E Marie giaceva nella bara – non un vero cadavere, ma uno finto in un finto funerale.
L'orrore calò su Riley. I due assassini —Peterson e chiunque avesse ucciso Cindy MacKinnon e le altre —si fondavano nella sua mente. Non aveva importanza che l'accostamento fosse del tutto infondato ed irrazionale. Non poteva separarli. Erano diventati uno nella sua mente.
Sembrava che questo funerale ben organizzato forse il tocco finale del mostro. Preannunciava che ci sarebbero state molte altre vittime e molti altri funerali.
Mentre sedeva lì, Riley notò con la coda dell'occhio un tizio entrare silenziosamente ad ascoltare la funzione e sedere all'altra estremità dell'ultima panca. Lei si voltò leggermente, per capire chi era arrivato nel bel mezzo della funzione e vide un uomo vestito in modo informale, con un cappello da baseball calato basso a nascondere gli occhi. Il cuore di Riley prese a battere più forte. Sembrava grande e forte abbastanza da essere quello che l'aveva immobilizzata quando era stata catturata. La sua faccia era dura, la mandibola serrata, e le parve di cogliere un'occhiata colpevole nella sua direzione. Forse il killer la stava cercando?
Riley si accorse di essere quasi in iperventilazione. Rallentò la frequenza dei suoi respiri finché la mente non si schiarì. Doveva fare forza su stessa per non alzarsi ed arrestare quel tizio. Il funerale stava avvicinandosi al termine e non poteva interromperlo e mancare di rispetto alla memoria di Marie. Doveva aspettare. Che cosa sarebbe successo se non fosse stato lui?
Ma poi quella persona la sorprese: si alzò improvvisamente e lasciò silenziosamente la stanza. La aveva notata?
Riley si alzò di scatto e lo seguì. Si accorse che molte teste so erano girate, quando si era alzata d'improvviso, ma quello ora non importava.
Corse attraverso il corridoio delle camere mortuarie diretta all'entrata principale e, nel momento in cui usciva dalla porta anteriore, vide che l'uomo stava camminando rapidamente lungo il marciapiede pubblico. Estrasse la pistola e lo seguì
“FBI!” gridò. “Fermo lì!”
L'uomo si girò per affrontarla.
“FBI!” ripeté, sentendosi ancora una volta nuda senza il suo distintivo. “Tenga le mani dove posso vederle.”
L'uomo che aveva di fronte sembrava del tutto sconvolto.
“Si identifichi!” chiese.
Le sue mani tremavano, che fosse per paura o sdegno. Riley non poteva saperlo. L'uomo estrasse un portafoglio, con una patente di guida e, guardandola, Riley notò che l'uomo viveva a Washington.
“Ecco la mia carta di identità” disse. “Dove é la sua?”
La convinzione di Riley iniziò a scemare. Aveva mai visto la faccia di quest'uomo prima? Non ne era sicura.
“Sono un avvocato” disse l'uomo, ancora molto scosso. “E conosco i miei diritti. Sarebbe meglio per lei se avesse una valida ragione per puntarmi una pistola contro senza ragione. Qui in una strada cittadina”.
“Sono l'Agente Riley Paige,” rispose. “Ho bisogno di sapere perché stava assistendo a quel funerale.”
L'uomo la guardò con più attenzione.
“Riley Paige?” chiese. "L'agente che l'ha liberata?”
Riley annuí. Il volto dell'uomo denotò subito disperazione.
“Marie era un'amica” disse. “Mesi fa, eravamo intimi. E poi le é successa questa cosa terribile e …”
The man emise un singhiozzo strozzato.
“Ho perso i contatti con lei. É stata colpa mia. Era una buona amica e non le sono stato vicino. E ora non avrò mai la possibilità di …”
L'uomo scosse la testa.
“Vorrei poter tornare indietro e far andare le cose in modo diverso. Mi sento in colpa. Non sono neppure riuscito a rimanere per tutto il funerale, me ne sono dovuto andare.”
Quest'uomo si sentiva colpevole – Riley comprese – e addolorato. Per ragioni molto simili alle sue.
“Mi dispiace” Riley disse dolcemente, abbassando la pistola. “Lo sono davvero. Troveró il bastardo che le ho fatto questo.”
Mentre si girava per allontanarsi, lo sentí dire con tono perplesso.
“Pensavo che fosse già morto?”
Riley non rispose. Lasció l'uomo addolorato in piedi sul marciapiede.
E mentre si allontanava, sapeva bene dove doveva andare. Un luogo che avrebbe capito solo Marie, di tutti al mondo.
*
Riley guidò attraverso strade cittadine che portavano dalle eleganti case di Georgetown a un quartiere diroccato in un ex area industriale. Molti edifici e magazzini erano abbandonati e gli abitanti del luogo erano poveri. Più si inoltrava, più peggiorava la situazione.
Alla fine parcheggiò lungo un isolato composto interamente di case a schiera inagibili. Uscì dall'auto e trovò subito quello che stava cercando. Due case vuote fiancheggiavano un'area vuota e brulla. Non molto tempo prima in quel luogo si trovavano tre case vuote. Peterson viveva abusivamente in quella al centro, usandola come rifugio segreto. Era il posto ideale per lui, troppo lontano da luoghi abitati perché qualcuno sentisse le urla provenienti dall'interno della casa.
Ora quello spazio era stato livellato, tutte le case sgomberate e l'erba stava iniziando a ricrescere. Riley tentò di richiamare alla memoria come appariva quando tutte le case erano al loro posto. Non era facile. Era stata sul posto solo una volta, quando le case erano in piedi ed era notte.
Mentre camminava nell'area sgomberata, i ricordi iniziarono a riaffiorare.
Riley lo aveva seguito per tutto il giorno e poi di notte. Bill era stato richiamato per un'altra emergenza e Riley, imprudentemente, aveva deciso di seguire l'uomo fin lì da sola.
Lo vide entrare nella vecchia piccola casa diroccata con le finestre sbarrate. Poi, pochi minuti più tardi, lui era uscito di nuovo. Era a piedi e lei non sapeva dove sarebbe andato.
Per un attimo aveva pensato di chiedere rinforzi. Poi aveva deciso di non farlo. L'uomo se ne era andato e, se la vittima era dentro la casa, non poteva permettere che soffrisse sola per un minuto di più. Si era avvicinata all'edificio e si era aperta la strada tra le assi che bloccavano solo parzialmente l'accesso.
Accese la sua torcia. Il raggio si rifletté su almeno una dozzina di bombole di gas propano. Non ne fu sorpresa. Lei e Bill sapevano che il sospettato era ossessionato dal fuoco.
Poi sentì grattare sotto il pavimento, e poi un debole grido …
Riley fermò il flusso dei ricordi. Si guardò intorno. Si sentiva sicura —assolutamente sicura —di stare nel punto esatto in cui entrambe avevano sofferto e pianto. Era il luogo in cui sia lei sia Marie erano state rinchiuse in una gabbia in uno spazio scuro e sporco.
Il resto della storia era ancora fresco nella sua mente. Riley era stata catturata da Peterson quando aveva liberato Marie, che aveva percorso circa due miglia in stato di shock. Quando era stata trovata, non aveva più idea di dove fosse stata imprigionata. Riley era rimasta sola nell’oscurità a cercare la sua occasione per fuggire.
Dopo un incubo apparentemente senza fine, torturata ripetutamente dalla torcia di Peterson, Riley si era liberata. Ìn quel momento, aveva colpito Peterson quasi svenuto. Ogni colpo le dava un gratificante senso di vendetta. Forse quei colpi, quella piccola vendetta – rifletté – le aveva permesso di riprendersi meglio di Marie.
Poi, resa furiosa dalla paura e dall'esaurimento, Riley aveva aperto tutte le bombole di propano. Uscendo dalla casa, aveva tirato un fiammifero acceso dentro. L'esplosione l'aveva scagliata dall'altro lato della strada. Tutti si erano meravigliati che fosse sopravvissuta.
Ora, due mesi dopo quella esplosione, Riley osservava intorno a sé il risultato del suo cupo lavoro, uno spazio vuoto in cui nessuno viveva né probabilmente sarebbe vissuto per molto tempo. Sembrava una perfetta immagine di quello che la sua vita era diventata. In un certo senso, sembrava che fosse il punto di arrivo, almeno per lei.
Un nauseante senso di vertigine la sopraffece. Restando ancora nel punto erboso, le sembrò di cadere, cadere, cadere. Finì dritta nell’abisso che si era spalancato proprio per lei. Persino nella luce forte del giorno, il mondo appariva terribilmente buio, persino più buio di quanto fosse stato in quella gabbia nel cunicolo. Lì sembrava non esserci il fondo dell’abisso, e la sua caduta sembrava senza fine. Riley rammentò a se stessa, ancora una volta, la percentuale che Betty Richter aveva dato sulla morte di Peterson.
Direi il novantanove percento.
Ma quell’opprimente un percento, in qualche modo, rendeva l’altro novantanove percento così inutile ed assurdo. E inoltre, anche se Peterson fosse stato davvero morto, quale differenza poteva fare? Riley ricordò le brutte parole di Marie al telefono, il giorno del suo suicidio.
Forse, è come un fantasma, Riley. Forse è questo che è successo quando l'hai fatto esplodere. Hai ucciso il suo corpo, ma non hai eliminato il suo male.
Sì, era proprio così. Stava combattendo una battaglia persa da tutta la vita. Il male, dopotutto, infestava il mondo, così come aveva certamente fatto in quel posto dove lei e Marie avevano sofferto terribilmente. Era una lezione che avrebbe dovuto imparare da bambina, quando non era riuscita a impedire l’omicidio di sua madre. La lezione era riemersa dal suicidio di Marie. Salvarla non aveva risolto nulla. Non era riuscita a salvare nessuno, e nemmeno se stessa. Il male avrebbe prevalso alla fine. Era proprio quello che Marie le aveva detto al telefono.
Non si può lottare contro un fantasma. Arrenditi, Riley.
E Marie, così tanto più coraggiosa di quanto Riley non sapesse, aveva finalmente preso la situazione in mano. Aveva spiegato la sua scelta attraverso cinque semplici parole.
Questo è l’unico modo.
Ma quello non era coraggio, prendere in mano la propria vita. Era codardia.
Emerse una voce dall’oscurità di Riley.
“Sta bene, signora?”
Riley sollevò lo sguardo.
“Come?”
Poi, lentamente, si rese conto di trovarsi in ginocchio in uno spazio vuoto. Le lacrime le rigarono il volto.
“Vuole che le chiami qualcuno?” la voce chiese. Riley vide che una donna si era fermata sul marciapiede vicino, una donna più anziana in abiti trasandati, con uno sguardo preoccupato dipinto sul volto.
Riley tenne il pianto sotto controllo, e si alzò in piedi, e la donna si allontanò.
Riley restò lì, stupefatta. Se non poteva porre fine al proprio orrore, conosceva un modo per stordirsi per affrontarlo. Non era coraggioso o onorevole, ma a Riley non importava. Non vi avrebbe più opposto resistenza. Entrò in auto, e sfrecciò verso casa.
Capitolo 27
Con le mani ancora tremanti, Riley cercò nella credenza in cucina la bottiglia di vodka che vi aveva messo, quella che si era ripromessa di non toccare mai piú. Tolse il tappo e tentò di versare il liquore delicatamente in un bicchiere, in modo che April non la sentisse. Dal momento che era così simile all'acqua, sperava di poterla bere apertamente senza essere costretta a mentire. Non voleva mentire. Ma la bottiglia gorgogliava in modo indiscreto.
“Che cosa fai, Mamma?” chiese April dietro a lei, seduta al tavolo della cucina.
“Nulla” rispose Riley.
Sentì April bofonchiare qualcosa. Immaginò che la figlia avesse compreso che cosa stava facendo. Ma non poteva rimettere la vodka nella bottiglia. Riley avrebbe voluto gettarla via, davvero. L'ultima cosa che voleva era bere, specie di fronte a April. Ma non si era mai sentita così giù di corda, così scossa. Le sembrava che il mondo intero cospirasse contro di lei. E aveva davvero bisogno di un drink.
Riley rimise la bottiglia nella credenza, poi andò al tavolo e si sedette con il bicchiere. Ne bevette un lungo sorso, e sentì la gola bruciarle nel consueto confortante modo. April la osservò per un momento.
“E' vodka, vero, Mamma?” disse.
Riley non rispose, mentre il senso di colpa cresceva in lei. Aprile si meritava una cosa del genere? Riley l'aveva lasciata a casa tutto il giorno, chiamando di tanto in tanto per controllarla, e la ragazza si era comportata in modo perfettamente responsabile ed era rimasta lontano dai guai. Ora era Riley quella che agiva di nascosto.
“Mi hai detto di tutto perché fumavo,” osservò April.
Riley rimase ancora in silenzio.
“Ora è il momento in cui ci si aspetta che tu mi dica che è diverso,” disse April.
“E' diverso,” ribatté Riley stancamente.
April le lanciò un'occhiataccia.
“Come può essere?”
Riley sospirò, consapevole del fatto che sua figlia aveva ragione; in effetti si vergognava.
“L'erba é illegale,” osservò. "Questo no. E—”
“Tu sei un'adulta e io sono una bambina, esatto?”
Riley non rispose. Naturalmente, era esattamente quello che desiderava dire. E naturalmente era ipocrita è sbagliato.
“Non voglio litigare,” rispose infine Riley.
“Hai davvero intenzione di ricadere in questo genere di problema di nuovo?” April chiese. “Hai bevuto moltissimo quando stavi affrontando tutti quei problemi – e non mi hai mai detto che cosa ti stesse succedendo”.
Riley sentì la mascella contrarsi. Era rabbia? Perché mai avrebbe dovuto essere arrabbiata con April, almeno in quel momento?
“Ci sono cose che, semplicemente, non posso dirti,” rispose Riley.
April alzò gli occhi al cielo.
“Gesù, Mamma, perché no? Voglio dire, sarò mai cresciuta abbastanza per conoscere la brutale verità sul tuo lavoro? Non può essere peggio di quello che immagino. Credimi, ho una grande immaginazione".
April si alzò dalla sedia e si diresse verso la credenza. Mise giù la bottiglia di vodka e iniziò a versarsene un bicchiere.
"Per piacere, non farlo, April" disse Riley debolmente.
“Come pensi di fermarmi?”
Riley si alzó e gentilmente prese la bottiglia dalle mani di April. Poi si sedette di nuovo e verso il contenuto del bicchiere di April nel suo.
“Pensa a finire di mangiare, okay?” le disse.
April ora piangeva.
“Mamma, vorrei che tu potessi vederti.” disse. “Forse capiresti come mi ferisce assistere a questa scena. E come mi fa male il tuo silenzio su tutto. Fa molto male”.
Riley tentò di parlare ma non vi riuscì.
"Confidati con qualcuno, Mamma,” continuò April, iniziando a singhiozzare. “Se non con me, con qualcuno. Ci deve essere qualcuno di cui ti fidi”.
April scappò via nella sua camera, sbattendo la porta dietro di sé.
Riley si prese il volto tra le mani. Perché sbagliava sempre con April? Perché non riusciva a tenere le parti oscure della sua esistenza lontane da sua figlia?
Tutto il suo corpo fu scosso dai singhiozzi. Il suo mondo era impazzito e non era capace di formulare un solo pensiero logico.
Rimase seduta lì finché le lacrime continuarono a scorrere.
Poi prese con sé bottiglia e bicchiere, andò in soggiorno e si lasciò cadere sul divano. Accese la televisione e si mise a guardare il primo canale che le era capitato. Non aveva idea di quale film o show era in programmazione e non le importava. Si limitò a restare seduta lì a guardare meccanicamente le immagini, lasciando che voci senza significato riempissero l'ambiente.
Ma non riusciva a fermare le immagini che si accalcavano nella sua mente. Rivide le facce delle donne che erano state uccise, poi le fiamme accecanti della torcia di Peterson che si muoveva verso di lei. E vide il volto di Marie morta – sia nel momento in cui l'aveva scoperta impiccata sia quando era stata sistemata attentamente nella bara..
Una nuova emozione iniziò a sopraffarla – un'emozione che temeva più di ogni altra. Era la paura.
Era terrorizzata da Peterson e avvertiva la sua presenza rancorosa tutto intorno a sé. Non importava che fosse vivo o morto. Si era preso la vita di Marie e Riley non riusciva a smettere di pensare di essere il suo prossimo obbiettivo..
Era anche spaventata, forse ancora di più, dall'abisso in cui stava precipitando ora. Erano due cose distinte? O era stato Peterson a scavare quell'abisso? Questa non era la Riley che conosceva. Sarebbe mai riuscita a superare la PTSD?
Riley perse la nozione del tempo. Tutto il suo corpo era scosso da tremiti e dolori per quella paura dalle molte facce che si era impadronita di lei. Continuò a bere, ma la vodka non la rendeva incosciente.
Alla fine andò in bagno, frugò nell'armadietto delle medicine e trovò quello che cercava. Alla fine tenne nelle mani tremanti i tranquillanti che le erano stati prescritti. Avrebbe dovuto prenderne uno al momento di andare a letto e non mescolarlo con l'alcol.
Ne prese due, sempre scossa dai tremiti.
Poi tornò sul divano del soggiorno e riprese a guardare la TV, aspettando che la medicina facesse effetto. Ma non funzionava.
Il panico la strinse in una gelida morsa.
Le sembrava che la stanza ruotasse, facendole venire la nausea. Chiuse gli occhi e si allungò sul divano. I capogiri migliorarono ma l'oscurità intorno a lei era impenetrabile.
Potrebbe andare peggio? si chiese
Sapeva bene che era una domanda stupida. Le cose sarebbero sempre peggiorate. Nulla sarebbe piú andato al suo posto, l'abisso era senza fondo. Tutto quello che poteva fare era abbandonarsi alla caduta ed alla disperazione più nera.
L'oscurità dell'intossicazione calò su di lei. Perse conoscenza e iniziò a sognare.
Ancora una volta le bianche fiamme della torcia al propano ruppero l'oscurità. Sentì una voce.“Vieni. Seguimi”.
Non era la voce di Peterson. Le era familiare, anzi estremamente familiare. Qualcuno era venuto a salvarla? Si mise in piedi e iniziò a seguire la torcia, chiunque fosse colui che la reggeva. Ma presto, con suo grande orrore, la torcia illuminò un cadavere dopo l'altro: prima, Margaret Geraty, poi Eileen Rogers, poi Reba Frye, infine Cindy MacKinnon. Tutte erano nude e in una posa orribile. Infine la luce rivelò il cadavere di Marie, sospeso a mezz'aria, con il volto contratto in modo spaventoso.
Riley sentì di nuovo la voce.
“Ragazza, hai lavorato veramente male.”
Riley si voltò a guardare. Nella luce sfrigolante vide chi reggeva la torcia.
Non era Peterson. Era suo padre. Indossava l'uniforme completa di un colonnello dei Marine. Questo la colpì molto. Era andato in pensione da molto ormai. E lei non lo vedeva né gli parlava da più di due anni.
“Ho visto cose brutte in Vietnam,” disse scuotendo la testa. “Ma questo mi fa star male davvero. Sì, hai sbagliato tutto, Riley. Naturalmente ho imparato da molto tempo a non aspettarmi nulla da te.”
Mosse la torcia in modo da illuminare un ultimo corpo. Era sua madre, morta e sanguinante dalla ferita d'arma da fuoco. .
“Potresti averle sparato tu stessa, per tutto il bene che le hai fatto” disse suo padre.
“Ero solo una bimba, Papà,” rispose Riley.
“Non voglio ascoltare le tue dannatissime scuse,” gridò suo padre. “Non hai mai portato neppure un attimo di gioia o felicità, lo sai? Non hai mai fatto qualcosa di buono. Non da sola.”
Chiuse la torcia e la fiamma si spense. Riley era di nuovo immersa nell'oscurità.
Riley aprì gli occhi. Era notte e la sola luce nel soggiorno proveniva dalla TV. Ricordava chiaramente il suo sogno; le parole del padre risuonavano nelle sue orecchie.
Non hai mai portato neppure un attimo di gioia o felicità,
Era vero? Aveva sempre fallito così miseramente, persino con le persone che amava di più?
Non hai mai fatto qualcosa di buono. Non da sola.
La sua mente era confusa e non riusciva a pensare lucidamente. Forse non era capace di donare vera gioia e felicità a nessuno; forse, semplicemente, non c'era amore in lei. Forse era incapace di mare.
Nel pieno della disperazione, alla ricerca di un'ancora con cui aggrapparsi, Riley ricordò le parole di April.
Confidati con qualcuno. Qualcuno di cui ti fidi.
Ubriaca ed incapace di pensare lucidamente, Riley compose quasi automaticamente un numero sul suo cellulare. Dopo pochi istanti, sentì la voce di Bill..
“Riley?” chiese, palesemente ancora quasi del tutto addormentato. “Sai che ore sono?”
“Non ne ho idea,” rispose Riley, biascicando malamente.
Riley udì una donna, intontita dal sonno, chiedere: "Chi é, Bill?”
Bill rispose a sua moglie: “Mi spiace, devo rispondere".
Ridley sentì il suono dei passi di Bill e la porta chiudersi. Immaginò che si fosse spostato da qualche parte per parlare in privato.
“Che significa?” chiese.
“Non lo so, Bill, ma —”
Riley si fermò per un momento. Si sentì sul punto di dire cose di cui si sarebbe pentita – forse per sempre. Ma per una qualche ragione non poteva fermarsi.
“Bill, pensi che potresti andare via per un po' di tempo?”
A Bill sfuggì un verso d'incomprensione.
“Che cosa stai dicendo?”
Riley fece un profondo respiro. Di che cosa stava parlando? Le era difficile raccogliere i pensieri. Ma sapeva che voleva vedere Bill. Era una sorta di istinto primordiale, un bisogno di cui non aveva il controllo.
Con quel minimo di ragionevolezza che le era rimasto sapeva che avrebbe dovuto dire Mi dispiace e riagganciare. Ma paura, solitudine e disperazione ebbero il sopravvento. "Voglio dire ....” proseguì, biascicando le parole e tentando di pensare coerentemente, “solo tu e io. Passare un po' di tempo insieme”.
Al telefono calò il silenzio.
“Riley, siamo nel cuore della notte,” disse “Che cosa vuoi dire con passare del tempo insieme?” chiese, con un tono di voce chiaramente più alto.
"Voglio dire …” lei iniziò, cercando, volendo fermarsi ma senza esserne capace. “Voglio dire …Penso a te, Bill. E non solo al lavoro. Non pensi mai a me, tu?”
Riley avvertì un pesante macigno crollarle addosso immediatamente dopo averlo detto. Era stata una cosa sbagliata e non si poteva tornare indietro.
Bill sospirò irritato.
“Sei ubriaca, Riley,” replicò. “Non intendo incontrarti da nessuna parte. Non andrai da nessuna parte in auto. Ho un matrimonio che sto cercando di salvare e tu … Beh, tu hai i tuoi problemi. Rimettiti in sesto. Cerca di dormire”.
Bill terminò brutalmente la chiamata. Per un momento, la realtà rimase sospesa. Poi Riley fu colpita crudamente da un'orribile certezza.
“Che ho fatto?” urlò piangendo.
In poco più di pochi attimi, aveva distrutto un rapporto professionale di dieci anni. Il suo miglior amico. Il suo unico partner. E probabilmente il rapporto che aveva funzionato meglio in tutta la sua vita.
Prima pensava che l'abisso in cui era caduta non avesse fondo. Ma ora sapeva di essersi sbagliata. Aveva raggiunto il fondo ed aveva sbattuto contro il pavimento. Non sapeva se sarebbe mai stata in grado di rialzarsi.
Prese la bottiglia di vodka sul tavolino da caffé; era incerta se bere quel che era rimasto o se buttarlo via. Ma la sua coordinazione era completamente andata. Non riuscì a tenerla in mano.
La stanza ruotò intorno a lei, poi venne un tonfo e tutto divenne nero.