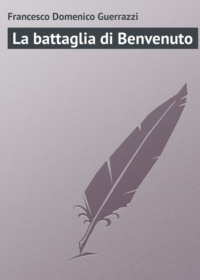Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La battaglia di Benvenuto», sayfa 32
CAPITOLO VENTESIMOQUINTO. LA FUGA
Tu vedrai che lo indugio, e la dimora
Che si frappone alla vendetta, accresce
Questa gran piaga, ch’è da sè mortale.
Arrenopia, tragedia antica.
Noi non sapremmo accertare l’amoroso lettore, che nulla curando il fastidio ci ha con tanta benevolenza seguitato fino a questo punto della storia nostra, se la Cronaca dalla quale ricaviamo le narrate avventure sia o no in parte manchevole, imperciocchè priva della numerazione delle pagine, non lascia modo a conoscere il difetto; vero è che omettendo di esporre come Carlo si partisse da Roma, quale strada tenesse, e quali ostacoli incontrasse, senz’altro badare, trascorre ai casi che avvennero dopo il memorabile passo del Garigliano eseguito
dalla milizia francese; onde volendo noi dare un po’ di supplemento a questo luogo, c’ingegneremo di raccontare alla meglio quanto accadesse in quel mezzo tempo. Coronato che fu a Roma nel giorno della Epifania il Conte di Provenza, rompendo gl’indugii si mise in cammino, sì per prevalersi di quel primo ardore dei suoi soldati, sì perchè, soprastando, non aveva danari per pagarli; e Papa Clemente, per molte cagioni, tra le quali non era ultima quella di non averne neppure egli, non poteva prestargliene. Le storie dei tempi non ci hanno conservato se Carlo operasse ciò che tutti i capitani a lui antecedenti e posteriori hanno fatto movendosi alla conquista del Regno, vale a dire dividere la sua gente in due schiere, mandandone una lungo il littorale, l’altra pe’ luoghi più prossimi agli Appennini, con intenzione di riunirsi a Capua per marciare unitamente alla volta di Napoli; anzi e’ pare che tenesse diverso consiglio, e repugnando dal partire lo esercito, pel cammino di Frosinone si accostasse intero al passo di Cepperano: forse temè incontrare troppo dura resistenza a Fondi e ad Itri, che occorrono costeggiando la marina, e considerò, che quando pure gli fosse venuto fatto di superare questi due passi, gli rimaneva il terzo, più arduo, del Volturno sotto Capua, il quale, per essere quivi il fiume grosso, e il ponte afforzato di antiche e di nuove torri, appariva inespugnabile. Trapassando la Campagna Romana, i popoli, non che gli contrastassero, gli davano all’opposto favore come a figlio prediletto, e a campione di Santa Chiesa. L’Arcivescovo di Cosenza, Bartolommeo Pignattello, veniva con esso lui in qualità di Legato apostolico, benedicendo chiunque si fosse aggiunto alla impresa contro Manfredi, e pronto a scomunicare coloro che avessero osato prenderne le parti: tanta era l’autorità della sua voce, che gli uomini del contado accorrevano per ogni lato volonterosi di farsi ammazzare in pro, come dicevano, della religione contro un eretico. Il Monte San Giovanni, che nel 1494 contese con tanto pericolo di Carlo VIII allo esercito di Francia, il fatale Angioino con allegrezza infinita accoglieva, e gli era largo di spontanei sussidii. Nè (poichè la fortuna non toglie mai a sollevare a mezzo i suoi diletti) i giorni, che, per essere all’entrare di febbraio, dovevano mostrarsi piovosi, cessavano di continuare sereni; il sole oltre ogni credere caloroso, pareva si compiacesse a rischiarare di limpidissima luce i passi del Destinato. Così il campo di Carlo, in sembianza di gente cui tarda essere aspettata a qualche gran festa, vide il quarto giorno del mese le sponde del Garigliano. Questo fiume principale di tutto il Regno di Napoli, che deriva la sua sorgente poco lungi dal lago Celano, trapassando per Sora bagna Cepperano, traversa Pontecorvo, e sbocca finalmente nel Mare Tirreno, formando un confine naturale tra la Campagna Romana e la Terra di Lavoro: dicono, correre le sue acque per lo spazio di ottantacinque miglia, e affermano potersi navigare per venticinque discosto dal mare; nondimeno a Cepperano e a Castelluccio non apparisce sì grosso che qualche volta non si possa guadare. Manfredi, che ben conosceva la importanza del passo, súbito dopo l’assemblea di Benevento vi mandò il Contestabile Rinaldo, Conte di Caserta, al quale aggiunse Giordano Lancia con molte compagnie di Pugliesi, perchè vi tenessero il fermo; schivassero venire alle mani; assaltati, si adoperassero di rituffare i nemici nel fiume. Conosceva lo Svevo, essergli lo indugio più efficace della vittoria medesima, e la impresa di Carlo doversi risolvere in fuga, dove non avesse potuto ingaggiare una presta battaglia, che mancava di danaro, primo e forse unico nervo della guerra: nessuna provvisione che si richiede da esperto capitano aveva ommesso; l’affidavano a bene sperare il luogo di leggieri assai difendevole, i sufficienti presidii affezionati al suo nome, per disciplina e per valore reputatissimi; la fedeltà dei Conti di Caserta e Lancia, che aveva loro preposto. Adesso riprende la Cronaca, e racconta, come la sera del quinto giorno di febbraio tornando Manfredi verso Benevento, dalla quale città era uscito per incontrare una masnada di soldati che dovevano mandargli di Puglia, si doleva per via della negligenza dei Governatori in ispedirli, e della lentezza dei condottieri in menarglieli, mostrandosi più che non si convenisse malinconoso, allorchè, levando gli occhi all’orizzonte, vide un nugolone nero che parandosi innanzi del sole prima che fosse tramontato, ne impediva la vista: qual fosse la relazione che in quel momento passava tra cotesta scena e i pensieri di Manfredi, noi non sapremmo; ma egli stava a considerarla con misteriosa calma, e con un meditare profondo, maggiore di quello che l’uomo in simili casi possa adoperare: gli estremi contorni della nuvola però splendevano di colore di sangue, e ne scaturivano alquanti raggi che spargendosi largamente per l’emisfero tingevano in vermiglio tutti gli oggetti che l’occhio giungeva a contemplare; d’ora in ora un buffo di vento scuoteva con violenza le fronde degli alberi, e percorreva la terra, cacciandosi innanzi turbini di polvere mossa, e paglie; il volo degli uccelli più e più sempre si abbassava, quasi presentissero che il cielo era per farsi turbinoso, ed annunziavano con voce inquieta soprastare la procella. Giordano d’Angalone, che cavalcava allato di Manfredi, avvisando di entrare nel pensiero del Re, favellava: Stasera il sole muore innanzi tempo.»
Manfredi, guardandolo accigliato, rispondeva: «Muore, ma brilla.» – E nel volgere che fece degli occhi, protendendogli giù per la valle esclamò: «Oh! perchè mai si affaccenda egli tanto? In verità mala nuova ne porta il corriero.»
I cortigiani che accompagnavano Manfredi diressero gli occhi al punto in cui mirava il signore, e stringendo le palpebre quanto meglio poterono, aguzzarono la vista: pur finalmente, stanchi di nulla discendere, parlarono insieme: «Salva vostra grazia, messer lo Re, voi avete preso errore…»
«Errore! Guardate là, là a mancina presso al dirupato del Diavolo,» ed accennava col dito «seguendo la direzione della cappella di Nostra Donna del Pianto, – non vedete un uomo che si affatica per guadagnare l’erta del monte?»
Si riprovarono più intenti di prima i cortigiani, e dopo replicati esperimenti risposero: «Noi non vediamo cosa al mondo.»
Tuttavolta, così comandando Manfredi, si rimasero su quella vetta, nè passò molto che incominciarono a scoprire una macchia bruna che parea distaccarsi dall’estremo orizzonte, e di mano in mano ingrandirsi approssimandosi; molto si maravigliarono del caso, e di animo concorde lo attribuirono a miracolo: e veramente, dice la Cronaca, ciò non fu senza volere di Dio, che, purificandogli le facoltà intellettuali e del corpo, anticipava all’anima travagliata lo spasimo della vicina sciagura, la qual cosa noi non sapremmo affermare; comecchè presso molte nazioni della terra vivesse, e forse anche viva la credenza, che il Destinato abbia il dono di profezia, e possa per alcuni segni degli occhi conoscersi colui che, prossimo a chiuderli per sempre, ha ricevuto, quasi in compenso della morte affrettata, la potenza di antivedere gli eventi. Ora si scorgeva manifesto il corriero: gli copriva la bocca una fascia, perchè nel celere corso l’aria non fosse impedita dall’entrare liberamente nel polmone; teneva fitti più che mezzi gli sproni nei fianchi del cavallo, o che distratto da altro pensiero non avvertisse che in quel modo gli dava la morte, o anzi che, calcolando per la fatica sofferta non potere più a lungo durare, volesse che quegli ultimi avanzi di vita si consumassero in isforzo disperato: – nefanda, non inusitata ferocia presso di noi, che ci diciamo immagini del Creatore! Anelava il povero animale in ispaventosa maniera, aveva il morso imbrattato di spuma sanguinosa, grondava sangue dal costato, da tutto il corpo sudore; pure trasvolava con una rabbia di corsa, per modo che a mala pena si potesse seguitare col guardo nei rapidi passaggi che faceva dall’ultimo globo di polvere nel nuovo che suscitava scalpitando; giunto circa quaranta passi alla distanza di Manfredi, stramazzò con lungo sdrucciolío, e abbandonando la testa stette immobile: il corriere, traendo le briglie, spronando più aspro che mai, s’ingegnava a rilevarlo; – fu opera perduta.– «Potevi aspettare a morire dopo altri quaranta passi!» mormorava il corriere smontando, e senza pure degnarlo d’uno sguardo s’incamminò pedone alla volta del Re; se gli inginocchia trafelato alla staffa, ma soverchiato dal travaglio cadeva boccone. Scese Manfredi, lo alzò affettuoso, lo pose a sedere, e di propria mano gli allentava la cintura, perchè meglio respirasse. Confortato il corriere di breve riposo, cominciava dolente: «O Re Manfredi, male nuove vi porto.»
«Già corre gran tempo, che non ne aspetto di buone.» – E così parlando Manfredi pose il gomito sopra la sella del suo destriere, e nella palma della mano lasciò declinare la testa.
«Grande sventura sono per narrarvi, mio Re.»
«E noi siamo apparecchiati ad ascoltarla: narrala.»
«I Provenzali hanno passato il Garigliano…»
«Che! – Tu te ne menti.»
«Così piacesse alla Santa Vergine, e a San Germano, che voi mi aveste giustamente mentito, chè io non vi chiamerei per questo in isteccato.»
«Perchè hanno combattuto? non avevano ordine di schivare la battaglia? Ecco, chi a adopra l’arme senza consiglio, le depone con danno… costoro mi sono debitori di questo sangue sparso…»
«O signor mio, che parlate di sangue? un vituperio eterno ha contaminato l’onore dei Baroni del Regno.»
«Come!»
«Carlo passò senza colpo ferire.»
«Dio!…» – proruppe con altissimo grido Manfredi, e il rimanente digrignò fra i denti, e alzò la testa, e così duro colpo sferrò su la groppa del destriero, che questo si mosse per fuggire: ma egli gli cacciò la destra dentro la criniera, e con forza convulsa lo costrinse a stare: quindi interrogò il corriere: «Dove è il Caserta? – dove andò il Lancia? Questa è la fede dei congiunti? Sopravvissero essi a tanto obbrobrio? Se sopravvissero… io lascio loro, per pena, la vita.»
«Ahimè, Messere! che vi ha tradito il Caserta.»
«Chi? – Caserta? Hai tu nominato il Caserta? Perchè mi ha egli tradito? Che gli aveva io mai fatto? Non l’onorai? Non lo chiamai a parte del reggimento? Non lo costituiva, dopo me, primo nel Regno? Non lo anteposi ai miei stessi consorti? Rinaldo! – l’amico mio! Perchè? Ah! – qual baleno di rimembranza! – La Spina! – Il tempo ha ridotto in polvere anche le sue ossa, e non ha cancellato l’offesa? – Chi offende dimentica; ma lo ingiuriato cinge di cilicio la memoria, e mette su l’anima il peso della vendetta: – non è la vendetta la cancrena del cuore? Ho errato; misero il Re che offende; più misero colui che offende, e non uccide! Rinaldo ha fatto il debito suo: perchè noi mancammo al nostro; – mai si concede errare indarno a cui porta corona; noi ne paghiamo amarissima pena, ma pure dovuta. Dovevamo noi?… un Manfredi?… No, nol dovevamo; ma Dio a cui vuol male toglie il senno.»
Queste parole non suonarono intere dalla bocca del Re, che la passione nol consentiva; gli si nascosero le pupille sotto le ciglia tese, un colore livido gli coperse la fronte, gli si gonfiarono i muscoli, tutta la fisonomia ne rimase scontraffatta in guisa, che i circostanti abbrividirono di terrore; si fece velo al sembiante con ambe le mani, e meditato che ebbe alcun tempo, le rimosse mostrandosi tranquillo. – Tranquillo! destava una sensazione simile a quella di colui che seduto sul lido del mare gode vedere il placido flutto leggermente commosso dalle danze del venticello vespertino, quando all’improvviso, trascorrendo con l’occhio innamorato, incontra legni sparsi e cadaveri, segno della sua ultima tempesta. Il corriero, che non aveva avuto più animo di muovere labbro, ricevuto espresso comando, riprendeva così: «La sera del giorno quarto di febbraio le nostre vedette tornando di tutta carriera, ci avvisavano stessimo all’erta, perchè cominciava a vedersi la vanguardia nemica: già non faceva mestieri di avviso, che il Conte Lancia vigilava incessante, e confortava i soldati con le parole e con l’esempio a bene operare: intanto apparve una schiera di Carlo, poi un’altra, e un’altra ancora; la notte c’impedì di scorgere la venuta delle susseguenti; per quello che ne apparve, prima e dopo che si fu partita la luce, non pensavano a dare battaglia. Era già passata la prima ronda, ed io me ne stava in guardia della tenda del mio signore, Conte Giordano, allorchè un uomo armato s’incamminò alla mia volta: tesi la balestra. e domandai: – Chi viva? – Viva Svevia, – rispose il Cavaliere, – va, sveglia il Conte Giordano, chè ho da parlargli. – Non vi ha mestieri svegliarmi, – rispose il mio signore, – affacciandosi all’apertura, perchè tristo è il vassallo che dorme quando il suo Re sta in pericolo; parlate, Contestabile, ch’io vi ascolto. – E venne fuori: e quivi al sereno, chè il cielo era placido, e non soffiava un alito, cominciava il Caserta: – Giordano mio, se voi, come non dubito, amate il vostro Re di quello amore che l›amo io, ho pensato che voi non impedirete un mio accorgimento pel quale di sicuro distruggeremo lo esercito del Provenzale. – Rispose il Lancia, lo aiuterebbe molto volentieri, nessuna cosa stargli più a cuore quanto la salute del Re, gli esponesse il trovato; per quanto era in lui, lo metterebbe in opera con infinita allegrezza. – Or bene, caro Giordano mio, soggiunse Rinaldo, voi sapete che non solo qui può guadarsi ii Garigliano, e quanto più si rimonta alla sorgente, tanto meglio si passa, specialmente a Castelluccio; noi, secondo le regole dell›arte, e i comandi del Re, abbiamo sprolungato le nostre forze su la destra sponda dei fiume per contrastare i nemici dovunque accennassero di fare un motivo; ma credete voi che quando si possa far meglio, sia questo buono consiglio? Certo voi nol credete: il Provenzale non ha mica convenuto di ordinare i suoi soldati, come noi abbiamo; anzi ho fede che gli riunirà in un punto, e quivi sforzando i nostri, insufficienti a resistergli, guaderà il Garigliano, e ci assalterà alle spalle e di fianco con nostro manifesto svantaggio: vorrei dunque per ovviare al danno che noi ci ritraessimo un po’ addietro… – Come? interruppe il Conte Giordano, trasgredire affatto i comandi di Manfredi! – Il Re, soggiunse il Caserta, ha comandato così perchè gli pareva il meglio; e noi siamo per la fedeltà nostra tenuti ad imprendere non quello che pare, ma quello che è veramente meglio: se poi ce ne volesse dar carico, noi risponderemo, Conte, ai suoi rimproveri: – abbiamo vinto; – non dubitate, ella è questa una buona ragione, che non ammette replica in contrario: io diceva pertanto di ritirarci indietro e spartirci nelle boscaglie lungo la via; io sopra del ponte, voi sotto, io co’ miei Pugliesi, voi co’ Tedeschi: Carlo, domani vedendo il ponte senza difensori, non manderà altrove la sua gente, nè allargherà senza bisogno la sua fronte; si spingerà innanzi per questo passo, riputando, orgoglioso come lo sappiamo, che non ci sia bastato il cuore di sostenerne la vista: facciamo che s’inoltri in colonna; io allora sboccherò dalle macchie, e gli darò la carica sul fianco sinistro, cacciandomi tra mezzo; quando scompigliati gli ordini vedrete ripiegare i Francesi, fate voi sul destro fianco quello che ho fatto io in sul sinistro, e rompete il ponte; i rimasti tra noi e il fiume vi traboccheranno a precipizio, i tagliati tra noi e la terra deporranno le armi, avendo San Germano a fronte: nè mi opponete, piccola schiera essere affidata al valor vostro, perchè quei pochi Tedeschi valgono i miei molti Pugliesi; e dovendo voi assaltare presso il ponte, non potete incontrare che una profondità di sei od otto file, mentre io dovrò combatterli certamente molto più grossi. Che parvene, Giordano? non è una bella astuzia questa? – Il Conte Lancia pensò molto, e rispose breve: – Io non saprei approvarla, Contestabile; ella mi sembra per lo meno arrisichevole, nè a noi può giovare adesso; si vince col combattere come con lo schivare le battaglie, ed ora è il caso: se Carlo indebolisce parte della sua fronte per fare vigorosa impressione sopra un punto della nostra, e noi insisteremo sopra il punto indebolito con simile arte, e lo circuiremo alle spalle, conseguendo così più facilmente quello che in modo più complicato e con maggiore avventura vorreste far voi, nè ci dipartiremo dai comandi ricevuti. – Tacque il Lancia; soggiunse il Caserta; poi il Lancia di nuovo: nè trovando modo a comporsi, propose il Conte Giordano di ragunare un consiglio di guerra, e starsi alla sua decisione: allora con gravi parole favellò il Contestabile: – Luogotenente, noi fin qui abbiamo parlato a Vostra Signoria per avervi compagno alla bella impresa; da che compagno non volete esserci, vi ordiniamo di eseguire quanto crediamo bene di comandarvi. – Ciò potevate fare innanzi, Contestabile, se manifestandomi il vostro funesto disegno volevate trovare in me un lusinghiero piuttosto che un franco soldato; nondimeno vi protesto di fare quanto posso per vincere, ma che a malgrado della vittoria mi dorrò della vostra condotta presso Manfredi. – Farete quello che vorrete, intanto obbedite; – e si partì. Giordano levò la destra al cielo, e udii che profferiva: – Signore, vogli che questa impresa abbia felice fine, come io lo preveggo sventurato. – Ci dividemmo taciti, lasciando molti fuochi accesi per ingannare il nemico; andò il Contestabile co’ Pugliesi a oriente, noi pochi col Luogotenente ci posammo vicino al ponte. Spuntava l’alba che doveva rischiarare l’onta del Regno, quando i Provenzali, visto senza difesa il capo del ponte, mandarono avanti alcune vedette: di lì a poco sopraggiunse un membruto coperto di bellissima armatura, che certo doveva essere il Conte d’Angiò…»
«E parti egli forte quanto si dice?» interruppe Manfredi.
«Non so se forte, prudente è molto, perchè dette ordine che i suoi passando il ponte non si sprolungassero in colonna, sì come aveva pensato il Contestabile, ma giunti al capo si partissero, volgendo una fila a mancina, l’altra a destra, e si schierassero paralleli al filo delle acque. Il mio signore che stava sopra una eminenza con alquanti dei suoi a vegliare le mosse del nemico, esclamò a cotal vista: – Questo sapeva io bene; pure si potrebbe emendare il fallo, se il Contestabile tornasse presto a riunirsi co’ miei. – E spedì il primo, il secondo, fino a cinque corrieri; fecero tutti come il corvo dell’arca; – non ritornarono. Mentre il mio signore agitato da impazienza leva la faccia, e vede… spettacolo d’infamia! su le opposte montagne allontanarsi in vergognosa fuga i Pugliesi; fu per non credere a sè stesso, fu per ferire il primo che disse: – e’ fuggono; – alla fine gli fu forza riceverne l’amara certezza. – Ecco, che accadde fatto, esclamò smarrito, peggiore di quello che temeva; mi era apparecchiato al fallo, non al tradimento: – ora, che faremo noi? domandò rivolto ai suoi, che gridarono concordi: – Morire! – A Dio non piaccia che sia così; serbate, o valorosi, le vite vostre ad atto più generoso, e meno disperato; dico più generoso; perchè non sia virtù spendere le anime senza consiglio; con maggiore utile del nostro Re potremo morire un’altra volta; a San Germano vedranno chiaro che noi non fummo i vili, sì bene i traditi. – Adesso il mio signore mi spedisce a voi, serenissimo Re, e vi prega ad accorrere presto, onde ristorare la cadente fortuna, e confermare con la presenza la fede…»
Manfredi non si rimase ad ascoltare la fine; inforcò la sella, e si affrettò a Benevento, senza pur salutare il corriere. Questi seguiva ansimante a piedi, da lontano, il suo Re, nè andava capace come dopo tanto durato travaglio, dopo essere tanto carezzato sul bel principio, adesso lo avesse deserto con tanto poca carità su la via; accusava le stelle, se la prendeva col destino, e non sapeva, che, quantunque dica la gente – l’ambasciadore non porta pena, nondimeno se l’ambasciata sia di dolore, non può essere che chi la reca non dispiaccia, perchè l’anima partecipa l’odio della perfidia con quello che gliel’ha svelata, e la ragione in queste cose non entra per nulla.
Arrivato che fu Manfredi nella sua real sede di Benevento, mandò per l’Amira dei Saraceni, Sidi Jussuff, della stirpe dei Ben-izeyen, il quale comparso, e salutato il signore con ogni dimostrazione di rispetto, secondo il costume degli Orientali, gli stette immobile davanti, aspettando il comando. Manfredi ordinava: «D’Angalone, procurate sollecito che le compagnie dei Tedeschi di qui a due ore sieno in punto di marciare per San Germano; tu, Baba Jussuff, fa lo stesso dei tuoi Saraceni: tu sai, che sebbene noi siamo credenti di Sidi Issa, tuttavolta li consideriamo come i più fedeli sudditi nostri; va, dì loro che si apparecchia un breve travaglio, che il Dragone minaccia la luna, ma che Dio grande ha destinato che uscirà più lucida che mai dalle sue branche schifose; nè il vincere pende incerto, perchè non ha egli detto il Profeta: – Chi si pasce d’iniquità trova la sua bocca piena di cenere?»
L’Amira, conserte le braccia al seno, fatto inchino profondo, accennava di partire, quando il D’Angalone disse rivolto a Manfredi: «Messere lo Re, avete considerato per via qual notte si apprestava? Il cammino che dobbiamo percorrere è malagevole; se la procella ci giunge, ci strazierà l’affanno, nè potremo inoltrarci di un passo.»
«Trista è la fede,» interruppe l’Amira «che si consiglia col tempo: la bestia che Allah ha fatto compagna dell’uomo, guarda il segno e la mano, non il sentiero, e se tra mezzo si sprofonda l’abisso, muore nella letizia della sua fedeltà; l’uomo avrà sortito doni maggiori per esser minore del cane? Tutto ha destinato il Signore, nessuno può fuggire il suo fato; se l’Angiolo della Morte scese dal cielo, ti percuote tanto seduto alla mensa, quanto schierato in battaglia; – tutto ha destinato il Signore, e il migliore d’ogni consiglio è l’obbedienza del Re.»
D’Angalone, a cui quella dottrina della fatalità non andava a verso, voleva rispondere; lo prevenne Manfredi, facendo un atto di sdegno con la mano, ed esclamando: «È destinato; l’Amira vi ha risposto per me.»
Si allontanarono. Rimase solo Manfredi: si succedevano truci pensieri nel suo intelletto con la celerità stessa con la quale in quell’ora si aggiravano i nuvoli pel firmamento, nè meno erano tenebrosi; noi non ne faremo la storia, chè forse volendo noi potremmo. Passate due ore di passione, giunsero, primo l’Amira, secondo il Conte d’Angalone, ad avvertirlo, essere le compagnie saracene e tedesche disposte a partire. Manfredi, dato un grande sospiro, guardò intorno la sala, prese l’Amira sotto l’ascella, e: «Andiamo» disse «dove ci chiama chi in noi può più di noi stessi… ah! il mio destriero… io l’ho obliato…»
«Ho provveduto a questo, Messere;» rispose D’Angalone: «egli vi attende bardato alla soglia del palazzo.»
«Gran mercè, Conte; voi avete molto bene operato.»
E scesero. Appena si furono affacciati alla porta, che agli occhi di Manfredi occorse un pietoso spettacolo: su gli estremi gradini, disposti in soave atto di amore, stavano la moglie e i figli suoi: – ei gli aveva dimenticati! – tanto possono le cure del trono che facciano dimenticare all’anima sì gran parte di lei? Nè la luce sinistra delle torce di resina, nè i globi di fumo alteravano punto quelle care sembianze; bene dentro sentivano scoppiare le lagrime, ma per non affliggere il Re sorridevano: – bellezza quasi ideale di tenerezza! Una pace mesta usciva loro da tutta la persona, e si diffondeva sul cuore pei riguardanti; parevano una benedizione del padre, che dal capezzale non lascia ai figliuoli che il retaggio della giustizia: era su que’ volti spavento, – era malinconia, – era speranza, – espressione simile a quella del devoto, che, timoroso del giorno dell’ira, inalza una preghiera in espiazione, e nel fervore dell’offerta gli raggia in fronte la fidanza di placare l’Onnipotente vendicatore. Perchè Manfredi abbassa la visiera? Teme egli che sveli la sua faccia il rimorso di averli dimenticati, o la pietà di vederli? Il rimorso, e la pietà, voglionsi ugualmente lodare; quello è proprio della creatura che deve morire, questa conviene anche agli Angioli. Colui che fece la schiatta dei Re, volle che fossero più che uomini; – devono respingere il pianto dal ciglio, – devono non sentire il grido della Natura: – ma lo potranno eglino? – Manfredi si accosta tremante; – non deve tremare, egli è Re: – non è carne quella che lo veste, non sangue quello che gli agita le membra, non anima?…
«Elena! Yole! Manfredino! consorte, figli miei! a che vi state così allo scoperto? non vedete che il cielo tempestoso minaccia, e la bufera sta per iscoppiare?»
«Perchè tu parti senza darci l’addio? perchè tu parti senza menarci con te?» – rispose la Regina con nuova domanda.
«Con me! a perigliare in mezzo delle armi, tra la rabbia di soldati inferociti, tra il tumulto delle battaglie, tra le morti… la fuga?» – e questa parola gli fu come spinta alla bocca, e volendola ritenere gli morì su le labbra.
«Staremo noi dunque lontani dal tuo aspetto a inaridirci nella incertezza più affannosa della stessa sventura, a morire di dolore? Chi fia, che ti consoli senza di me? Se, e Dio nol voglia, tu rimanessi ferito, che si direbbe pel mondo della Regina Elena? una mano straniera ha medicato le piaghe del figlio di Federigo, perchè la sua consorte dimorava lontana dal campo. Ho io tanto mal meritato di te, che tu vogli contaminarmi di così vituperevole onta?»
«Ma tu lo vedi, noi siamo per partire, nè voi potete seguitarne in sella; come trasportarvi? Pochi momenti possono precipitarmi dove non… si può risorgere.»
«Oh! non darti pensiero di questo; ho provveduto: vedi, non sono quelle lettighe?»
«In verità voi impedirete la corsa.»
«No: tu va innanzi, nè aver cura di chi succede; non volgerti nemmeno indietro, noi ti seguiremo da lontano, – ci basterà la vista…»
«M’impedirete il ferire…»
«Ti mostrerò anzi, non dubitare, prima che tu corra in battaglia, questo tuo Manfredino…» (Il Re si curva, impone ambedue le mani sul capo del suo figliuoletto, ed esclama: «o mia speranza!») «e ti dirò che tu lo salvi, ch’è sangue tuo; che nol risparmieranno i tuoi nemici, se cedi…»
«Cedere io? quando ha ceduto Manfredi? quando, donna, ti tornò il tuo consorte dinanzi in sembianza di vinto? Noi vinceremo…»
«E noi, raccolti nella tua tenda, pregheremo il Signore che ti dia vittoria, che non risguardi alla tua fronte segnata dell’anatema, che sciolga quello che legò in terra il suo Vicario, perchè non l’ha legato con la giustizia… intenda il gemito dei supplichevoli… protegga gl’innocenti.»
«Non fare, Elena, non fare, che l’Eterno guardi dall’alto la testa di Manfredi; pregalo per te, pregatelo per voi, figli miei; voi siete degni che egli vi ascolti, e vi ascolterà: io mi raccomanderò alla spada.»
E mosse per allontanarsi: gli si gittarono ai piedi, gli abbracciarono le ginocchia, prorompendo in voce di pianto: «Non ci lasciate, padre! – non mi lasciare senza di te!»
«Venite dunque, poichè lo volete, a partecipare dei miei dolori, della mia morte; anteponete alla vita e alla sicurezza vostre, la mia compagnia, ed io vi accetto: – badate, voi gusterete amarezze ineffabili, chè l’amico del misero è più infelice di lui; tardo poi verrà il pentimento, tardi i desiderii, – non mi credete? Io vi compiango; voi non sapete come flagelli la sventura, nè potete conoscere quanta ci travagli la rabbia di amore di sè, che mescolata col sangue ne circola per la vita: sia fatta la vostra volontà. E tu, inesorabile,» e guardò il cielo, «che raguni le tempeste, e regni sul fulmine, tu risparmia a questi affettuosi la vista feroce dei più santi vincoli rotti dal furore dei bisogni dell’anima e del corpo: bene io so che le mie offerte consideri offerte di Caino davanti al tuo altare, e che per me non hai orecchie da ascoltare la preghiera; e se discendi nel profondo, tu sai se per me pregherei; – ma io ti supplico pe’ miei figli, – intendi, pe’ mei figli innocenti; guardali se sono puri al tuo cospetto, ricercali, nè troverai parte che tu non goda di avere creata. Io ho peccato, – puniscimi; ma non è ragione che questi capi diletti portino il peso delle mie iniquità.»
Così parlava Manfredi sì come disperato del perdono del cielo, ed altamente commosso aggiungeva: «Benincasa! Benincasa! prendete quattrocento lance spezzate, e fate scorta alla mia reale famiglia: – bada, Benincasa, questo è sangue mio, tu pure sei padre, e conosci a prova che voglia dire – sangue mio: a te dunque lo raccomando.»
«Messer lo Re,» rispose il Benincasa portando la mano destra sul cuore, «io ne avrò cura più che se fossero miei figli…»
«Non più: – guardali come guarderesti i tuoi, tanto mi basta.»
Alta la notte, e cupamente profonda, attristava la terra; nè raggio incerto di stella, o di luna, trapelava dai nuvoli che ingombravano lo emisfero: – in così spaventosa oscurità sarebbe stata, non che altro, benedetta la luce del fulmine. Dalla furia del vento che si spezzava dentro le forre dei monti, dal mugghio delle nuvole travolte, usciva un dolore, un terrore, simile al rammarichío d’una moltitudine di tormentati, che si lamenti in diversi suoni con orribili favelle. Taluno per quei montani sentieri avvertito dallo scroscio del torrente di trovarsi sul ciglione della balza, dava indietro gridando al vicino: – qui è morte; – il quale, tentando dall’altra parte, e conosciuto quivi ancora diruparsi la via, rispondeva: – nè qui è vita; – si prendevano stretti per la mano, ed abbassata la testa, puntando la persona, spesso trapassavano illesi il cammino periglioso: molti però percorsero gran tratto carponi; molti si aggrapparono alle rocce, nè le lasciarono, finchè il temporale non rimise alcun poco dell’impeto: vi furono di tali che ebbero fiaccate le gambe, o le braccia, dagli alberi divelti dalle radici, precipitanti dall’alto; ed anche chi percosso sul capo cadde senza anima, ingombro di terrore ai sopravegnenti: nè mancarono di quelli che poco validi di robustezza, e male assicurati delle orme, traportati dalla bufera non sentirono nè pure la consolazione di manifestare ai compagni la miserevole morte con l’ultimo strido; – lo assorbiva lo elemento imperversato, quasi geloso di partire con altrui la potenza della paura, – come risoluto a fare, che nessuno spavento fosse maggiore del suo.