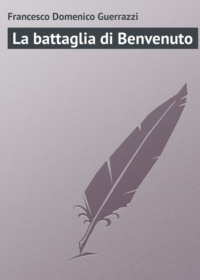Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La battaglia di Benvenuto», sayfa 33
Fra tanto scompiglio il nobile Manfredi montato sopra un generoso cavallo di battaglia, ch’egli aveva tolto a malgrado che l’Amira Jussuff gli avesse fatto osservare essere balzano dal piè sinistro di dietro, e però di tristissimo augurio, procedeva arditamente, affidato all’istinto e al vigore dell’animale; questi, quasi volesse giustificare la fiducia che in lui riponeva il cavaliere, lo portava sicuro con maravigliosa celerità per una via scabrosa, piena d’impedimenti e di pericoli. Gli ufficiali del Re, o per aver sotto più pigro destriere, o per chiudere in petto meno animoso cuore, non gli potevano tenere dietro: egli per lungo spazio cavalcava loro davanti. È fama che le anime dei sepolti lungo quella via sbucassero fuori delle fosse, e recando in mano fiaccole accese lo precorressero trescando una danza infernale, e che il cavallo e il cavaliere nulla temendo di coteste apparizioni si valessero della luce per inoltrarsi sicuri. Aggiunge ancora la Cronaca, che Manfredi avendo esclamato: – abbi i miei saluti, e le mie grazie, qualunque tu sii, spirito infernale, o celeste, che mi rischiari il cammino, – quello splendore allo improvviso cessasse, e indi a poco comparisse uno spettro scettrato, luminoso di un bianco trasparente, come di nuvolo che veli il disco della luna, il quale, – stupenda avventura! – invece di tramandare raggi di luce fosse ricinto di una atmosfera più tenebrosa del buio della notte: rassomigliava lo Imperatore Federigo, come che la sua sembianza non apparisse con precisione descritta, – quasi immagine di sogno, che l’anima non abbia compíto di formare; – non poteva dirsi di vivente, nè di defunto, più tosto di persona desta per forza da lungo letargo, che non ha per anche ben ricovrati gli ufficii della vita. – Afferrava la larva il cavallo pel freno, e con voce, che sebbene superasse lo stridore del turbine, tuttavolta da nessuno fu intesa, fuori che da Manfredi, gridava: – Ben venga il figliuol mio, sono degli anni più di venti che io ti aspettava sopra questa via: – ed alla fine delle parole lo trasportava con tanta veemenza, che il Re, nè credendo nè sentendo di toccare più terra, si avvisasse di correre alla bocca del Vesuvio per essere precipitato dentro l’Inferno: quando ecco rimanersi lo spettro, lasciare il morso, e, protendendo la mano spiegata in atto di respingere, con orribile ululato sprofondare; il cavallo, che fino ad ora se ne andava a rovina, s’impennava; nè per quanto Manfredi v’impiegasse d’arte e di fatica, poteva farlo avanzare di un passo, chè anzi, ricalcitrante, più e più sempre indietreggiava. Sopraggiunsero i cortigiani, e maravigliando che anche i proprii cavalli, aombrando, repugnassero inoltrarsi, cavato un fuoco greco di una lanterna, si misero a speculare per la strada: – un cadavere deturpato vi giaceva traverso; aveva la testa affatto scarnita, meno qua e là qualche straccio di cotenna sanguinosa; la spalla destra divorata fino alla mammella; il fresco sangue diceva chiaro quella strage essersi operata da poco tempo; mostrava il petto macolo dalle pedate dei cavalli, sdrucito in moltissime parti dalle branche e dalle zanne dei lupi, che, porgendo le orecchie, intesero non lontani brontolare, come rabbiosi che avessero loro rotto quel pasto: non vi fu bocca che non mandasse grido a cotesta miseria, non cuore che non sospendesse il suo palpito. Manfredi ordinò che lo togliessero alla paura dei suoi soldati, gittandolo giù pel macchione. Tali, e non altre furono l’esequie che ebbe quell’infelice dai suoi fratelli. Credesi fosse un povero montanaro che andasse di notte per giungere assai di buon tempo in Benevento a vendere certa cacciagione, e prima di terza ritornare a vedere i suoi figliuoli… Avanti di partire, con essi loro ringraziava la Provvidenza che gli aveva fatto trovare tanta salvaggina, unica causa del suo viaggio…
Manfredi commosso, non isbigottito, da tante vicende, guardò il firmamento, e minaccioso parlava: «Ben puoi strapparmi la corona del capo, bene anche il senno, pel quale gli uomini mi hanno esaltato, – ma io ti sfido a levarmi la costanza.»
CAPITOLO VENTESIMOSESTO. IL SARACINO
MESSO.
Fuggite, o triste e sconsolate donne,
Fuggite in qualche più secura parte,
Chè i nemici già son dentro le mura.
SOFONISBA.
Ove si può fuggir? Che luogo abbiamo,
Che ci conservi, o che da lor ci asconda,
Se l’aiuto di Dio non ci difende?
Sofonisba, tragedia antica.
«No, non ha vinto il Provenzale; egli ha varcato il confine, sì come il mercante che dal contado romano trapassa nel Regno: sieno esse queste le sue glorie! non gliene serbi il destino diverse! questo desideriamo, questo speriamo, questo con ogni intento nostro faremo. Esalti nella grossezza della mente la vergogna di sì fatta vittoria; – a lui non concessero i cieli neppure il pudore, che non manca al ribaldo, di godersi in silenzio il frutto dell’infamia: certo, se così non vince, altramente non vince; conosce al mondo qual guerriero è costui: stanno in Egitto le memorie delle sue imprese, dove seppe ricomprare a contanti una vita che non aveva saputo spendere combattendo per Cristo. Oh! causa di Dio in quali mani affidata! Poco era il dolore dei Fedeli nel vedere il tuo santo sepolcro in mano dei cani, che tu dovessi aggiungervi il molto più grave di farti contaminare la venerata bandiera da cotesto masnadiero francese? Male si conquistano i Regni con le arti; nè cammino di sicurezza, bensì di vituperio, è quello del tradimento. Su la via che conduce alla reale Napoli ora sorge Manfredi, armato della spada dello Imperatore Federigo, preceduto dall’Aquila, usa per tanti anni di vittoria a riposarsi nel padiglione dei vinti, ricinto dai fedeli Baroni, che a palmo a palmo ricuperarono prima, e poi gli donarono il Regno. Diverse battaglie ti si apparecchiano adesso dalle tue provenzali: qui non sono vassalli difesi dalla sola innocenza, qui non Baroni tutelati dalla sola giustizia; certo, se queste sole ci assicurassero, ora noi ci daremmo per vinti; – tu sei invincibile, e la gente lo sa, contro la innocenza: ma noi assicurano diecimila tra Pugliesi e Tedeschi, tutti i Saraceni di Lucera, mirabile quantità di saettamento, mura inespugnabili, perigliose paludi, monti inaccessibili. Che andiamo parlando noi di paludi, di monti, di baluardi? Siamo noi forse tali che abbiamo bisogno di bastite per usberghi? Forse tanto dall’antica virtù decaduti, che alle anime nostre desideriamo altra difesa che il proprio petto? Dovrà la superbia francese vantarsi della insperata onoranza? La virtù italiana dolersi della inusata vergogna? A noi duole trattenerci perfino in queste finzioni d’ignominia. Nei campi aperti combattevano i nostri padri, e noi nelle aperte pianure sortiamo, andiamo a dare generosa ammenda al fallo di traviati fratelli, facciamo che mal gustati gli tornino i dolci frutti d’Italia, tocche in mal punto le italiane terre; avverso è il clima, mortifero l’aere nostro al giglio di Francia. Qui assorsero, qui vivono, ed eternamente vivranno alla vittoria le Aquile imperiali: – forse che adesso Carlo, – il Re del nostro Regno! – si consiglia con la paura, e ferma di lasciare, senza pure vederle, queste terre donategli da quel suo romano Pontefice: è tardi, – le Alpi non si varcano indarno. Figlio di padre infelice fu quegli che osò guastare il giardino dell’Impero; vedova prima che sposa, l’amante di colui che offese il retaggio dei discendenti di Costantino: di là dai monti oggimai non vedranno che l’esequie degli stolti che si commisero alla audace intrapresa; – abbiano il lutto da che non ebbero il senno; dopo il fatto, anche il folle diviene sapiente: e già il nostro pensiero, lieto dei favorevoli augurii, lusingato dalla gloria dell’evento, gode affacciarsi al futuro, e contemplarvi venerandi per onorata canizie nelle sale dei vostri castelli, festeggiati dai vostri nepoti, instantemente richiesti a narrare la storia di tanti trofei appesi; voi allora li guarderete sorridendo sì come consapevoli di vivere immortali nella memoria dei posteri; e incomincerete così: – Corrono molti e molti anni che una gente di Barbari mosse d’oltramonte a infestare le nostre belle pianure; pregate, figli, la pace a quell’anime, però che anche elleno fossero di battezzati! – e i corpi lasciarono alla pianura, a noi le armi, ai figli le lacrime, e il cordoglio di non poterli vendicare; – avventurosi in questo, che, morendo, noi non potemmo togliere loro la gloria di perire sotto le nostre spade.»
In questa sentenza favellava Manfredi, arrivato in San Germano al cospetto dei suoi condottieri; e se così avesse arringato per conseguire gloria di oratore, il suo desiderio sarebbe stato compito, perchè con tanto tumulto di mani percosse e di grida gli applaudirono gli ascoltatori, che pareva San Germano ne sobbissasse. Di quelli poi che applaudivano, non tutti prestavano fede alle cose esposte da Manfredi, ed egli medesimo le credeva meno degli altri: assai in ciò somiglievole alla femmina, che più s’ingegna riparare all’avvenenza delle guance e al decoro della fronte, quando più il tempo insiste a sfiorarle quegli ornamenti di troppo caduca bellezza: nondimeno le sue condizioni non volgevano ancora in manifesta rovina, chè forte davvero era San Germano, ed egli attendeva del continuo a maggiormente afforzarlo; nè risparmiava punto a sè stesso, che di giorno e di notte vigilava le sentinelle, faceva le ronde, premiava i diligenti, i neghittosi con amorevoli detti ammoniva: l’uso delle guerre di quei tempi rendeva il luogo inespugnabile, meno che per mezzo di blocco; ma a questo aveva provveduto Manfredi raccogliendovi vettovaglia sufficiente per due anni, nè il nemico poteva circuirlo per modo, che alcuna via non gli rimanesse sempre aperta alla campagna. Queste considerazioni faceva il Conte di Provenza, e quasi disperava: poteva avventurare l’assalto, e lo avrebbe tentato; tuttavolta troppo gli comparivano forti quelle muraglie, e troppo cautamente guardate, per correre il rischio con qualche speranza di buon successo: se ne fosse, come sembrava, ributtato, avrebbe diminuito l’ardore dei suoi Francesi, – soliti a ingigantirsi nella prospera fortuna, a sgomentarsi oltre il dovere nell’avversa, – perduta la fama d’invincibile che sì l’aiutava. Dalla scemata reputazione vedeva scaturire una serie di mali, di cui il meno grave consisteva nel rinunziare affatto alla impresa; – tante durate fatiche, tante concepite aspettative, i lunghi desiderii, i disegni, commettere all’esito incerto di una battaglia, dove nulla gli avrebbe giovato la esperienza della milizia, nulla i buoni cavalieri armati da capo a piedi con sì grave dispendio, non gli sembrava, nè era prudente: conosceva inoltre benissimo che quei molti Romani, che gli si erano aggiunti, non venivano mica per aiutarlo; solo a partecipare delle spoglie conquistate dal valore dei suoi; e che al primo disastro se ne sarebbero andati come erano venuti, spargendo da per tutto per onestare la fuga, la nuova della sua disfatta, con mentito racconto magnificandola. D’altronde la inerzia non gli nuoceva meno della sconfitta; scarseggiavano i cibi, le casse mostravano il fondo, e i Romani, come abbiamo detto, lo accompagnavano per guadagnare, non per rimettere; se il caso non gli apriva qualche via di salute, ei si teneva perduto. Vero è però che nel volto dimostrava il contrario, e diverso dalla sua natura sorrideva spesso, e qualsivoglia capitano o soldato contemplasse sgomento, lo chiamava per nome, e sì gli diceva: – «Fa core, che abbiamo superato il ponte, e con l’aiuto di San Martino supereremo anche il muro; buono studio vince rea fortuna.» – In questa guisa dava animo altrui quanto più il suo era presso a disperare.
Mentre così Manfredi, a malgrado del suo bel discorso di sortire alla campagna, stava riparato dentro la Fortezza, – non perchè gli mancasse il coraggio, chè anzi ne aveva moltissimo, ma perchè dubitava dei suoi fedeli Baroni; – e Carlo, da che non poteva scoprirsi lione, attendeva con la sagacia della volpe a specolare il momento opportuno, accadde in San Germano una avventura grave in sè stessa, più grave per le conseguenze, e fu questa. Camminavano sopra lo spaldo a diporto molti dei principali capitani del Re Manfredi, tra i quali il Conte Giordano d’Angalone, e l’Amira Sidi Jussuff, favellando, sì come i soldati costumano, delle cose della guerra; e secondo che avviene entrando di un particolare in un altro, il Conte Giordano venne sul discorso dei casi presenti, e con molto savie ragioni dimostrava doversi tra breve sciogliere lo esercito nemico, però che inoltrarsi nel Regno con San Germano alle spalle sarebbe, stata impresa più presto stolta che audace, nè il Conte di Provenza intendeva sì poco di milizia da commettere tanto irreparabile errore; essergli l’indugio rovina, perchè sapeva di buon luogo che stava co’ soldati allo stecchetto di vittovaglia e di quattrini; i soldati poi non intendere nulla di promesse; volersi oro per mandarli innanzi, ferro per mandarli indietro; sopra ogni anima al mondo seguitare essi l’antica sentenza, che dove non si guadagna si perde: e qui, aggiunte molte altre novelle, passava a dire come savio consiglio del Re fosse quello di abbandonare Benevento, e accorrere con quante forze aveva in pronto a tutelare San Germano. A questa proposizione rispondeva l’Amira, ch’ei favellava da quell’uomo ch’egli era, ma che però poco rimase che per lui San Germano non si soccorresse; e dove avessero seguitato il suo avviso, la Fortezza, come pare, sarebbe già presa, perchè con Carlo d’Angiò a fronte, ora più, ora meno, poteva benissimo decidere della somma della guerra.
D’Angalone, acerbamente sopportando la rampogna al cospetto di tanti suoi compagni di armi, soggiunse: – non sapere nulla di quanto diceva, mai avere consigliato Manfredi se non a imprese generose; sarebbe stato un tradirlo dove lo avesse trattenuto da soccorrere San Germano; che, salva sua grazia, l’Amira faceva errore. I circostanti prendendo maraviglioso diletto dal garrire di que’ due, li circondarono, e follemente curiosi si apprestarono a vedere come sarebbe andata a finire la contesa. Qui noti il lettore, che sebbene l’espressioni salva vostra grazia, salvo l’onor vostro, temprassero alquanto la mentita, nondimeno i più scrupolosi non se ne chiamavano meno offesi, e procedevano senz’altro al duello: raccontano i ricordi del tempo in che Monsignor Lautrec andò a Napoli, un gentiluomo francese avendo detto ad un italiano: salva vostra grazia, l’Italiano non lasciandolo finire lo percosse sul volto; protestando che un gentiluomo onorato non parla mai contro la fama altrui, non afferma l’incerto per vero, nè dice averne buona scienza dove egli non ne sia pienamente istruito. L’Amira però reputandosi offeso: «Voi dunque, Conte,» esclamava «avete commesso tradimento, quantunque io sosterrei per l’anima di mio padre che non siete traditore; non vi torna alla mente. quando per timore di bagnarvi il collare, o di guastare il sonno, volevate trattenere a Benevento il Re, perchè la notte si metteva al piovoso?»
Si levò all’intorno un riso di scherno, divenne il d’Angalone per la faccia di fuoco, e con amare parole riprese l’Amira: questi dal canto suo non si tacque, e tanto si riscaldò la lite, che il Conte senz’altro rispetto gli disse, – che mentiva per la gola, e gliel’avrebbe provato di santa ragione; che se i matti al suo paese si veneravano per Santi, nel suo si bastonavano perchè apprendessero senno; che assaltare uno squadrone di cavalieri era altra cosa che svaligiare una carovana di mercanti; che condurre gli eserciti diversificava dal condurre gli armenti; – e molte altre cose aggiunse, vituperevoli tutte, che l’Amira non si meritava per niente, come quello ch’era uomo dabbene, e molto virtuoso della persona. Ma la collera non misura i colpi, nè le parole; e all’uomo che fa il volto soverchiamente rosso per ira, conviene poi farlo pallido per vergogna. L’Amira, a malgrado sentisse la mentita quanto una stoccata nel cuore, agitando la bocca di un cotal suo riso pungente, riprendeva beffardo: «Messere il Conte come uomo alto misura la sua fede con le nuvole, e pe’ suoi doveri se la intende con la luna; davvero, Conte, in quella notte temei che il vento la lealtà vostra spengesse per la via; avanti d’ingaggiare battaglia procurate di convenire col nemico di non dare di taglio, nè di punta, – a non farsi male, – e nella testa non conta: – deh! avvertite a non lasciare il mantello, perchè tornando riscaldato dal campo non vi si geli addosso il sudore.» – E in questo metro continuava. Crescevano attorno le risa, i motti moltiplicavansi infiniti: d’Angalone mal destro a quella battaglia di epigrammi, conoscendo che per uno ne aveva cento, gravemente tollerando lo strazio, non vedendo nè ascoltando più nulla, trasportato dall’impeto alza la mano stretta, e lascia andare così pesante colpo sul volto dell’Amira, che sente spezzarglisi sotto il tenerume del naso, dove per avventura lo colse. Jussuff, comecchè dall’acerbo dolore del corpo stesse per cadere, sostenuto dal molto più acerbo dell’animo, pose mano alla scimitarra; lo stesso fece Giordano, e già venivano al sangue, se non che i comuni amici frapponendosi li trattenevano, solleciti adesso a impedire le conseguenze di una contesa che avevano, aizzando l’uno contro l’altro, a diletto promossa: certo costoro non dubitavano dovesse uscirne tanto male; ma gli stolti non conoscevano che quando le passioni si muovono, non sanno neppur elleno dove prenderanno a posare, e che non essendo concessa all’uomo la facoltà di moderarle, tutta la nostra sapienza si riduce a non toccarle?
Menavano l’Amira sanguinoso ai quartieri, e Giovanni Villani racconta, come i Saraceni, vedutolo così mal concio, e intesane la cagione, tanto sdegno gli ardesse, che tolte le armi corressero addosso ai Cristiani, i quali avendoli ricevuti a visiera calata, ne sorgesse una zuffa fierissima con la peggio dei Saraceni: – la nostra Cronaca però espone che ben essi volevano fare il diavolo e peggio, appiccare il fuoco alla terra, mandare a sangue ogni cosa, e poi ne venisse che cosa poteva venirne; ma lo Amira li trattenne, gridando, – non volere che nessuno fosse sì ardito d’intromettersi nei suoi affari, essere quella privata offesa, e privatamente doversi diffinire; a eterno vituperio gli tornerebbe se altri si mostrasse più pronto di lui stesso a vendicare il suo onore; – si rimanessero; – a chi primo si fosse di un solo passo avanzato avrebbe di propria mano fatto balzare la testa dal busto: – onde, aggiunge la Cronaca, i Saraceni persuasi dall’arringa, in particolare dalla perorazione, consentirono, sebbene di mala voglia, a quetarsi.
Alla dimane l’Amira, chiamato il suo segretario, gli consegnava una carta molto bene piegata, odorosa di muschio, suggellata di seta verde, e di cera, ordinando la portasse al Conte Giordano d’Angalone. Il segretario avendo fatto lo ufficio, il Conte ruppe il sigillo, e lesse: «Al lodato nella fede di Sidi Issa, e dei precetti della sua fede imitatore Giordano d’Angalone, Conte, della quarta compagnia dei cavalieri tedeschi capitano. – In San Germano, questo dì ultimo della luna di Gemmadi, anno dell’Egira 643. – Ecco, tu mi hai coperto di polvere al cospetto dei nostri amici, mi hai reso impotente a combattere contro i nostri stessi nemici: si legge in alcuna fede, ovvero comandamento del tuo Dio, percuotere l’amico che non ti offende, o che tu primo hai offeso? Si conviene al tuo valore, avendo fama di buon Cavaliere, che tu facci così ai leali servitori del tuo Re? Or sappia Tua Signoria, se sei valente uomo, ch’io ti sfido a uscire dimani dopo nona sul luogo dove mi hai percosso, affinchè noi combattiamo insieme; vieni solo se vuoi, o con tuo seguito, chè ciò poco importa, e ti proverò con spada e con lancia, che non operi quello si addice a valoroso Barone. Se io, come spero, ti ammazzerò, la mia spada riprenderà contro tutti il taglio, che ora per tua colpa non serba tranne contro di te solo: se non vieni, io non ti abbandonerò, sebbene tu fugga oltremare od oltremonti; se non esci, farò che per tutta Cristianità tu sii tenuto per codardo, e timido nel volere di Dio, e nei suoi comandamenti, in quelli dei Santi in santità, e in quelli di tutti i Cavalieri onorati. – Dio grande e Maometto suo Profeta concedano lunga vita, e facciano bene a chiunque leggerà dirittamente questa lettera, come donino breve la via, e la ambasciata gradita a chi la consegnerà al mentovato Conte, capitano Giordano d’Angalone. – Servo di Dio Jussuff della stirpe dei Ben-izeyen, Amira dei Saraceni di Puglia.»
Il Conte Giordano, letto con molta attenzione il cartello di sfida, aprì un suo forzieretto, e, cavatine alquanti agostari, gli mise in mano all’araldo saraceno dicendogli: «Questi terrai per mio amore.» Quindi con voce più bassa aggiunse: «Dirai al tuo signore che sono parato a compiacergli di quanto desidera, che dimani lo aspetto in cortesia alla mia mensa, e levate le tavole entreremo in isteccato, dove Dio darà la vittoria a chi meglio gli piacerà.»
Il caso non potè di tanto celarsi che non giungesse agli orecchi di Manfredi, il quale, molestamente comportandolo a cagione dei tempi, e volendovi, come savio, porre rimedio, venne a far quello che non avrebbe mai dubitato, cioè a renderlo più funesto a sè, e alle cose sue. – Noi non possiamo, per quante meditazioni vi abbiamo fatto sopra, conoscere da che cosa derivi, nè chi la mandi, ma esiste certo una persecuzione, terribile per le sventure che apporta, molto più terribile pel mistero in cui sta nascosta, la quale converte in opera di scempiezza il consiglio della sapienza, lascia al male il suo amaro, toglie al bene il suo dolce, perverte il cuore e la mente, ti volge in danno l›amore dei tuoi fedeli, ti muta in triboli del corpo ogni oggetto che tocchi, in ispine dell›anima ogni disegno che séguiti; disperata persecuzione, che ti opprime come un peso gravissimo imposto su la tua vita mortale, e che, te consapevole, la costringe a sprofondarsi di mano in mano nella terra che la sostiene, finchè le chiuda, quasi lapida anticipata, la bocca del sepolcro. – Il Conte d›Angalone obbedendo ai comandi si presenta al cospetto del Re, si avanza con passi incerti, a testa dimessa, pallido per la faccia, sicuro di avere incorso nello sdegno del suo signore: non ricevendo cenno d›inoltrarsi, di fermarsi nemmeno, ristette a giusta distanza. – più lontana del consueto però: – una volta ardì levare gli occhi per vedere Manfredi (a cuore bennato come giunge sconfortante l›ira della persona reverita!); non gli bastò l›animo a sostenerne l›aspetto; e di súbito li rivolse al pavimento. Stavasi il Re seduto nella severità della sua giustizia, guardando fisso, accigliato, il povero Conte. – Dopo un buon quarto d›ora di silenzio, nel quale parve, al d›Angalone avere attorno tutte le generazioni dell›uomo da Adamo in poi a contemplare la sua vergogna, e mille volte maledì l›ora del suo nascimento, e sentì come s›incontrino pur troppo occasioni per la vita nelle quali, come sommo bene, si desidera la morte, la voce del Re prese a favellare gravemente in questa sentenza: «Lasciamo a voi, messere Conte, decidere, se dal sospetto del vostro Re, o da altrui, dipenda che egli non sappia oggimai più distinguere gli amici dai nemici suoi. Mentre un esercito di Barbari, cupido delle nostre sostanze, intento al totale nostro esterminio, ci sta schierato di fronte, e c›insegna a vigilare concordi se vogliamo salute, v›ha tale che ardisce avvilire con gli ultimi oltraggi un condottiero a noi per onorevole servitù, per lunga e provata fedeltà, dilettissimo; un condottiero che forma la principale forza delle presenti difese, e che dove egli si ritirasse, o tradisse, a noi non rimarrebbe altro scampo che raccomandarci l›anima ai Santi; e questo tale che l›osa, ardisce poi chiamare infame il Conte di Caserta. A voi, Conte Giordano, lasciamo decidere qual di costoro sia più traditore, e meriti maggior nota d›infamia; – se il delitto si misura dal danno, chè certo si misura, questi ne tolse la sua persona con alcune masnade di vassalli, quegli ne toglie ogni difesa, ne precide la via della vittoria; noi, i nostri figli, e i sudditi nostri consegna avvinti al nemico; nè qui si ferma costui, che, con inudito ardire trascorrendo, sprezza le leggi del Regno, sprezza la persona di un Re, il quale prima scerrebbe seppellirsi sotto la rovina del trono, che soffrire nella più lieve parte vilipesa la sua reale autorità; e manda cartelli, e propone abbattimenti, e sotto i nostri occhi medesimi apparecchia le armi. Tanto insolito e grave affare egli è questo, o Conte Giordano, che noi, come savio signore, dubitando che l›ira non ci turbi la mente, e s›intrometta nei nostri giudizii, abbiamo voluto, prima di pronunziare sentenza, consultarvi della vostra opinione: dite.»
«Messer lo Re,» con tardo e interrotto discorso rispondeva il Conte Giordano «io mi confesso colpevole; il cartello non mandai, ma accettai, perchè così doveva fare chiunque porta sproni, e spada di Cavaliere: ogni più grave pena a cui piaccia alla Serenità Vostra sottopormi accetterò con lieto, non che con tranquillo animo; solo vi prego a non volermi di tanto avvilire ai vostri occhi che me paragoniate a quel vituperato Caserta; ciò non meritano, non dirò le mie opere, sì bene quelle dei miei maggiori, in pro della casa vostra eseguite; ciò non la fama per tanti anni illibata…»
E seguitava quasi lacrimoso. Lo interruppe Manfredi con suono assai meno rigido, tuttavolta sempre severo «Ci piace, Conte, la vostra sommissione. Volete rimettere in noi la vostra querela?»
«Non potrei rifiutare, volendo; persuaso che quanto piacerà alla Serenità Vostra disporre di me, sia secondo i termini dell›onore.»
«Intanto, deponete la spada nelle nostre mani, costituitevi nelle carceri del nostro palazzo; voi siete prigioniere del Re.»
Il d›Angalone, deposta la spada, salutando, partiva. Manfredi, inchinando a bene sperare per l›arrendevolezza del Conte, mandò incontanente per l›Amira, volendo che non passasse quel giorno senza che si fossero composti in pace. Da quell›uomo avveduto ch›egli era, considerando come gli Orientali si lascino sopra gli altri prendere dalle apparenze, chiamò i primarii ufficiali di sua casa, ingombrò di carte le tavole, pose nella prima camera messi, e corrieri; in somma ostentò un gravissimo apparato di faccende del Regno.
Appena l›Amira, senza che lo precedesse l›annunzio, essendo così comandato, ebbe posto il piè nella stanza reale, che Manfredi, licenziati gli ufficiali, gli si fece vicino, favellando in atto cortese: «Ben venga il benedetto nel Signore, Baba Jussuff, inclita stirpe dei Ben-izeyen; – l›aspetto del servo fedele torna gradito al suo Re quanto il profumo della mirra, quanto la pioggia feconda nel mese dei germogli; vieni, siedimi allato, qui alla sinistra: il Re che ode a destra il consiglio dell›Arcangiolo, a sinistra quello dell›amico, e vede, come un segno innanzi alla fronte, il timore di Dio, quel Re cammina nelle vie diritte, nelle vie di coloro ch’egli ha colmato di grazie; i suoi passi volgono alla contentezza, benedizione sarà nella sua casa dai padri nei figli, e nei figli dei figli»
A questo punto l’Amira accennò con la mano il volto pesto, volendo, per quello che ne sembra, cominciare ex abrupto. Non gli lasciò formare parola Manfredi, che di súbito aggiunse: «Se il Profeta ti compiaccia di quello che ami, noi sappiamo, fedele Amira, ciò che vuoi esporne, e ti abbiamo chiamato per questo: nè il nostro sonno fu nella trascorsa notte come il sonno delle precedenti tranquillo, nè così splendida come altro giorno ci apparve stamane la luce, nè così grato il melodioso mattinare degli uccelli del Signore. Ecco che piacque a lui, che può tutto, amareggiare il suo servo, e abbeverarlo nel liquore dell’affanno; – Dio è grande, sia fatta la sua volontà: il raggio dei Ben-izeyen ha cessato d’illuminare la sua progenie; il fedele Jussuff fu vilipeso dove il Creatore ha improntato nella creatura la sua somiglianza; – ma il corvo è nero alla faccia del cielo, la colomba è bianca; nè il rettile, quantunque di sotto l’artiglio abbia levato la testa, ha offeso la carne dell’aquila; solo ne ha contaminato di veleno le penne. Dio protegge la forza del lione, e il nome del giusto, perchè sono cosa sua, e dimostrazione del suo braccio: pure se l’offesa fu nulla, è grave il peccato; come dal grano della polvere alla montagna, così dal pensiero non compíto nel segreto della mente al più grave misfatto, tutto sta alla presenza di Allah e del suo Profeta, e un giorno tutto sarà pesato, e ogni colpa sconterà la sua pena secondo la sua qualità; così prima che paghino i vassalli a Munchir e Nechir la pena del sepolcro, noi Re della terra siamo deputati a far loro scontare la pena della vita, e noi intendiamo punire l’oltraggio che ti fu fatto per modo che ti chiamerai contento…»
Voleva continuare Manfredi; ma l’Amira, sottraendosi da quel turbine di metafore orientali, alzò la voce gridando: «Schiatta d’Imperatori, degno di madre impudica, degno che i suoi figli dimandino un pane d’infamia al nemico della sua vita, è colui che chiama chi lo difenda nella causa d’onore…»
«Forse è la bocca della calunnia che ti vuol vendicare? È il braccio dell’assassino che toglie a difenderti? Non siamo noi il tuo Muleasso, al quale concesse il Profeta dominio intero su la tua vita, sul tuo avere?…»
«Non sopra il mio onore.»
«Dunque se noi ti chiedessimo un sacrificio in pro dei nostri popoli, e di noi, nulla varrebbero presso te i nostri beneficii, e quelli dei nostri maggiori? nulla aver tratto te e i tuoi dalle montagne di Sicilia, dove avevate stanza e vita comuni con le fiere della foresta?»
«A che rammenti quello che io so, nè mi spiace sapere? io ucciderò le mie mogli, i miei figli, il mio cavallo, il mio cane, e me sopra loro, se tu lo desideri…»
«Noi non vogliamo il tuo sangue, anzi la vita e la fama tua desideriamo; tu vedrai un nobile uomo chiederti mercede innanzi un consesso di Cavalieri, vedrai spargersi il capo della polvere da te calpestata, come di una corona di gloria, vedrai starsi ai tuoi piedi come sul trono dei potenti: che vuoi di più? E’ v’ha un confine alla vendetta: che insegna il tuo Koran nel Sura Aaraf? Perdona volentieri, benefica il tuo simile, non contrastare con gl’ignoranti. Non insegna lo stesso il nostro santo Evangelo?»