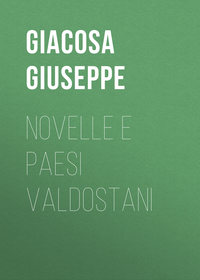Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Novelle e paesi valdostani», sayfa 12
Stetti per pazzo alcuni giorni all'infermeria. Guarito e rinsavito, quella scappata mi fruttò un posto stabile di primo violino nella Cappella Regia di Sua Maestà il Re di Sardegna.
IL RE VITTORIO EMANUELE IN VALLE D'AOSTA
Il Re Vittorio Emanuele piantava le tende per la caccia a pochi passi dalle ghiacciaie del Gran Paradiso. A Valsavaranche ed a Noaschetta l'accampamento sorgeva sovra un altissimo ripiano erboso oltre la regione degli alberi e dei cespugli; a Cogne era in mezzo alla valle in un luogo delizioso chiamato Vallontéj, un prato ingombro qua a là di enormi massi grigi rovinati dalle vette e fiancheggiato da una fitta foresta di abeti. Quando il Re dalla piana saliva al campo, tutta la valle era sulla strada maestra; la notizia della sua venuta si spandeva da per tutto come il rimbombo di una cannonata. Nei luoghi fissati per lo scambio dei cavalli, i pubblici ufficiali davano l'annua lustrata al cappello a staio e le famiglie borghesi levavano dall'armadio la bandiera del 48. Il Re chiamava per nome i sindaci, gli osti, gli stallieri, le guide ed i cacciatori, conosceva gesta e miracoli dei maggiori alpinisti, stringeva la mano al maestro, batteva la mano sulla spalla del mulattiere, dava uno scudo al mendicante storpiato da uno scoppio di mina. Lo scambio dei cavalli seguiva in dieci minuti, perchè il Re amava di non perdere tempo ed era impaziente di giungere ai luoghi freschi. A mano a mano che saliva, le conoscenze si facevano più frequenti e famigliari; a Cogne ed a Valsavaranche non c'era un viso nuovo per lui, egli era al fatto di tutte le minute vicende domestiche di questo e di quello, sapeva della lite fra Pietro ed Ambrogio, della vacca che Anselmo aveva perduto in un burrone un giorno di nebbia e del figliolo che Rosa aveva fatto a Tonio, il quale, briccone, stava ora sui lavori in Francia, senza pensiero della poveretta. I contadini gli si facevano incontro semplicemente sorridendo e attaccavano discorso essi col voi, egli col tu, come vecchi amici.
***
La Domenica, in val di Cogne, egli scendeva dal campo al villaggio per sentirvi la messa cantata nella chiesa parrocchiale. In quella circostanza amava di fare una piccola mostra di sovranità, per rendere il dovuto omaggio ad un Sovrano maggiore di lui: a Domine Iddio nel quale egli credeva. Poneva due carabinieri in gran tenuta, la spada sguainata ritta lungo il braccio rigido, ai due lati dell'altare ed egli stava sul limitare della chiesa, in piedi nel mezzo della porta spalancata, posato fieramente, una mano sullo schienale di una piccola scranna di legno che a volte in distrazione faceva girellare e l'altra nella tasca dei larghi calzoni di frustagno. Finita la messa, portava egli stesso la scranna in piazza, all'ombra e sedutovi cominciava la rassegna di tutto il villaggio che gli si affollava intorno. Discorreva in piemontese intercalandovi qualche sapida parola del gergo valdostano; e i sigari fioccavano in tal quantità che non pareva ne potessero tanti capire le sue saccoccie ed era chiaro che aveva pensato a provvedersene prima di lasciare il campo. Le ragazze più vistose avevano tutte un nomignolo di sua invenzione corrispondente o a qualità fisiche o ad accidenti biografici. E a questa lanciava un'arguzia, a quella un nome che lo chiariva al fatto dei di lei piccanti secreti, a quest'altra pizzicava le gote, e honni soit qui mal y pense.
La risposta valeva la botta; poichè l'arguzia contadinesca non scompariva dirimpetto al frizzo regale, ma scoppiettava sincera ed allegra fra un coro di risate, senza che ne scapitasse la riverenza dovuta al Sovrano. Il Re scordava la sovranità ed i villani la sudditanza, egli scendeva dal trono senza derogare, essi, per non farlo scendere del tutto, mettevano un piede sul primo scalino, ma senz'ombra di arroganza.
L'alpigiano possiede l'istinto della misura e non la soverchia mai, nè il Re Vittorio Emanuele era uomo da tollerare gli si mancasse di rispetto. Bensì sapeva proporzionare gli atti e le parole alla condizione delle persone ed attribuire ad ogni atto o parola altrui il suo giusto valore. Così, se mai, mentr'egli teneva il circolo piazzaiuolo, qualche villano più timoroso cercava di sgattaiolarsela non visto, egli lo chiamava per nome e lo riprendeva scherzosamente di che non lo venisse a salutare; ma una Domenica che una famiglia codina di nobili torinesi, alloggiata per villeggiarvi all'albergo di Cogne, uscì di chiesa mentre egli stava in piazza e non perdonandogli la reggia del Quirinale, passò fra la gente fingendo di non avvertire la sua presenza, egli che bene li conosceva, disse ad alta voce: «Chi sono quei villani che non salutano il Re?» E poi, contento della lezione, riprese la celia.
***
Tutti sanno quale famoso cacciatore egli fosse e come non fallisse mai il suo colpo; quelli che lo avvicinarono, lo narrano gelosissimo della riputazione di buon tiratore e intollerante dell'altrui mediocrità. Se uno dei suoi sbagliava la mira, erano serî rabbuffi in principio e lunghe canzonature di poi, e se ne coglieva troppe o troppo bene, trapelava dalle sue parole una punta di gelosia che durava finchè con un colpo maestro non avesse assodata di bel nuovo la propria superiorità. Ciò avveniva colle persone del seguito, le quali d'altronde erano ben di rado ammesse all'onore di partecipare alla caccia, e rarissime volte poste a tiro dello stambecco.
Lo stambecco era riserbato, per lo più, agli ospiti di riguardo e solo quando le condizioni della caccia erano tali da non correr rischio di perdere la preda. La quale andava in gran parte regalata qua e là, dove il Re sapeva di ufficiali superiori o di magistrati o di uomini politici alloggiati negli alberghi vicini. Chi la riceveva si affrettava a farla imbandire sulla mensa comune, con gran giubilo dei touristes inglesi i quali notavano sul taccuino delle memorie la data del giorno e la provenienza della vivanda, e non mancavano mai di proporre, in fin di tavola, il toast al coronato cacciatore.
***
Il sussiego e l'etichetta non salirono mai oltre i mille metri sul livello del mare: il Re, accampato sopra i duemila, amava di vivervi da gran signore ospitale e magnifico, ma accostevole ed alla mano. Io non ebbi mai l'onore di parlare con lui, ma intesi raccontare fatterelli caratteristici, che tutti lo dipingono ad un modo.
Un anno, fu nel 73 se non erro, l'anno che lo Scià di Persia venne in Italia, uno studente dell'Università di Torino, mezzo artista, era salito a Cogne e vi dimorava per certi suoi studi scientifici che alternava con ricreazioni artistiche da pittore. S'era combinato che nella seconda metà d'agosto saremmo andati a raggiungerlo, suo padre, parecchi amici artisti ed io, per tentare con lui alcune escursioni sulle ghiacciaie del Gran Paradiso. Un giorno degli ultimi di luglio, egli andò per diporto fino all'accampamento del Re a Vallontéj, e poichè il Re era alla caccia e si sapeva non sarebbe tornato prima di sera, pregò il generale Bertolè-Viale che gli lasciasse visitare l'accampamento e farvi alcuni disegni che intendeva mandare e mandò intatti, al Graphicdi Londra. Il generale accondiscese, e, a disegni finiti, avendo mostrato desiderio di averne uno per memoria, gli fu dato a scegliere quello che più gli tornava.
Passano cinque o sei giorni, quando una bella mattina sul fare dell'alba, il nostro studente è svegliato bruscamente da più colpi battuti contro la finestra della sua bassa camera d'albergo. Stanco per qualche gran camminata del giorno innanzi, egli urla un: Chi va là? stizzito che voleva dire: non mi seccate; ma i colpi rimartellano tanto che egli corre in camicia ad aprire la finestra per dare il fatto suo al notturno disturbatore. Pensate come rimase trovandosi di fronte a Sua Maestà il Re d'Italia, il quale da cavallo aveva picchiato ai suoi vetri e rideva ora della sua attonita confusione.
– Prima di tutto si vesta, che a queste arie gelate c'è da pigliarsi un malanno e poi si riaffacci che le voglio parlare.
Come fu vestito e tornato alla finestra, il Re gli disse:
– Senta, ho veduto il disegno che lei ha fatto per Bertolè, e vorrei averne uno che raffiguri tutto il mio campo. Io vado ora a Torino a ricevere lo Scià di Persia; starò al caldo cinque o sei giorni, poi tornerò, non più a Cogne ma a Valsavaranche. La prego dunque di farmi quel disegno e di portarmelo colà fra una settimana. Ho dato ordine che non smontino il campo finchè lei non vi sia salito. È inteso?
L'altro a scusarsi di non saper fare cosa degna del Re e il Re a lodargli il disegno che aveva veduto; breve: si rimase che il lunedì venturo lo studente sarebbe andato ospite della Maestà Sua a Valsavaranche.
Vi andò, valicando in dieci ore il colle del Lauzon, uno dei più alti dell'Alpi e giunse al campo che imbruniva. Era l'ora del pranzo; il Re lo accolse con quell'affabilità bonaria che bandisce il sussiego e pareggia i gradi; era il signor Savoia che riceveva in casa propria il signor X, e lo trattava come si conviene ad un ospite; lo volle vicino di tavola e gliene fece gli onori mettendo il discorso su argomenti che lo potessero interessare, interrogandolo famigliarmente, e famigliarmente rispondendo alle di lui domande, raccontando aneddoti piccanti o avventure di caccia, passandogli i piatti perchè vi tornasse e mescendogli un Barolo squisito, che il giovine disavvezzo alle Corti, aveva fin dai primi sorsi lodato calorosamente. Il Re amava di vantare la propria robustezza. Venuto il discorso sulle caccie in montagna, prese celiando a canzonare quei signori del suo seguito sempre impensieriti del freddo.
– Guardi, sono quasi tutti più giovani di me ed eccoli imbottiti di maglie e flanelle come se fossimo a caccia di foche nei mari polari, mentre io, guardi, e si sbottonava, una camicia di tela e ce n'è d'avanzo.
Era infatti d'una robustezza a tutta prova; dormiva per lo più sotto una tenda soldatesca in un lettuccio dove si coricava bello e vestito. La mattina alle 3, cioè sul primo albeggiare, quando da quelle alture si vede fuggire verso Francia il cielo nero scintillante di stelle, e salire dai gioghi nostrani il chiaro cielo diurno, egli si levava e usciva a passeggiare fumando in mezzo al silenzio del campo e a trarre l'oroscopo della giornata dall'aria nitida sulle ghiacciaie bianchissime, o dai brandelli delle nuvole lacerate alle vette. Poi quell'uomo vissuto per agire, stava gran tempo lo sigaro in bocca, seduto su di uno sgabello pieghevole a guardare intorno sorgere e spiccare agli albori crescenti i dorsi e incidersi i seni della montagna, e il primo raggio del sole fulminare le pareti cristalline e sfolgoreggiare di poi tutti i vasti piani delle ghiacciaie.
Lo Studente fu avvertito che non avesse a parlare di partenza. Aveva portato con sè i colori, e la giornata gli passava a far studi dal vero. Il secondo giorno, venutigli a mancare i cartoncini, ebbe da un domestico per dipingervi, il coperchio di una scatola di sigari d'Avana, e discorrendone a tavola capitò a dire come tali tavolette si prestino mirabilmente agli studi ad olio. Ed ecco l'indomani sera giungere al campo il mulattiere delle provviste, con un carico di scatole da sigari d'ogni forma e d'ogni dimensione; il Re aveva egli stesso telegrafato a Torino perchè gli fossero spedite, e la cosa era seguita con una sollecitudine veramente regale.
Dopo pranzo Vittorio Emanuele soleva passeggiare collo studente nei pressi del campo richiedendogli il nome dei più vistosi fiori, o discorrendo dei grandi fenomeni alpini. Il giovane, incoraggito, lo interrogava alla sua volta intorno a questo o a quel Sovrano o personaggio della storia contemporanea e ne traeva notizie curiosissime e ritratti compendiati in pochi tocchi sagaci e pieni di colore.
Finito il passeggio, buona notte signori: ognuno entrava nella sua tenda fino al domani.
Lo studente era al campo da otto giorni, ed il nono la comitiva che ho detto di sopra, doveva giungere a Cogne, dove ci s'era data la posta.
La sera dell'ottavo giorno il giovane avvertì il generale Bertolè che l'indomani gli bisognava partire e rivalicare il colle del Lauzon.
– Badi – gli disse il generale – che gli ospiti di Sua Maestà non se ne vanno se non quando sono congedati.
– Ma mio padre e gli amici miei non sapendomi qui e non trovandomi a Cogne, staranno in pensiero di qualche disgrazia…
– Manderemo un espresso.
– Abbiamo combinato delle escursioni sul Gran Paradiso.
– Ebbene, stasera parlerò io col Re; lei domattina s'alzi all'ora che vorrebbe partire, troverà il Re in piedi, e sentirà da lui quello che gli conviene di fare.
La mattina, come Vittorio Emanuele lo vide sbucare dalla tenda, gli disse:
– Dunque lei ne ha abbastanza della mia compagnia?
– Oh! ma…
– Lo so, lo so, vada pure, è giusto. Suo padre l'aspetta. Dica a suo padre che oggi andrò ad ammazzare lo stambecco e che glielo manderò domani. Ho dato ordine che le sia preparata una cavalcatura. E mi venga a trovare quest'altr'anno; capiti qui quando saprà che ci sono e mi farà piacere.
Il cavallo era sellato e aspettava. Il Re aggiunse in tono grave:
– Venga qui – e lo prese per le due mani – lei è giovane e ha voglia di studiare. Seguiti sa, perchè il mondo è di chi se lo piglia, specialmente ai giorni nostri.
E gli tenne un gran discorso paterno, buono e fortificante; poi, dopo una pausa:
– Glielo dirà, non è vero, a suo padre che le ho parlato così?
In quest'aggiunta c'è intero Vittorio Emanuele.
Quella sera a Cogne, l'amico nostro ci raccontava ogni particolare del suo soggiorno nel campo del Re e l'indomani un sergente di caccia ci portò il promesso stambecco che divorammo allegramente.
L'avventura andò poi a finire così: Per ringraziare la Sua Maestà del grazioso dono, la nostra brigata si raccolse a consiglio e deliberò di mandare al campo un gran foglio, illustrato a modo di pergamena gotica, dove il Teja disegnò il ritratto di ognuno di noi, e io postillai ogni ritratto con due versi dichiarativi. Il Re ne fu contentissimo e ci mandò ad invitare tutti a pranzo per il giovedì venturo, tempo permettendolo. Ma dopo due giorni cadde una tale nevicata che il colle del Lauzon divenne impraticabile. Tuttavia tre dei nostri vi si avventurarono: lo studente, il Teja ed il Pittara, i quali giunsero a Valsavaranche più morti che vivi. Il Teja raccontò questa sua visita nel Pasquinoed il Pittara ne ricavò un grande e bellissimo quadro che credo sia ora nel Castello Reale di Monza.
TRADIZIONI E LEGGENDE IN VALLE D'AOSTA
Si crede generalmente che le valli alpine, e più quella d'Aosta, siano un semenzaio di leggende e di tradizioni popolari. Ve ne sono invece pochissime e scolorite. Il luogo sarebbe adatto ma non la gente, cui la facoltà immaginativa è pressochè isterilita dalle troppe e troppo gravi fatiche. Oramai le più schiette leggende sono quelle falsificate per intero; dell'altre, le vere, nel loro passar di mente in mente svaporò in gran parte la sostanza e sbiadirono e si ritinsero i colori. Finchè duravano nel popolo, le variazioni erano poche, ma divenute materia letteraria e argomento di libri stampati, furono inzeppate, ingentilite, ammodernate, moralizzate e tirate a forme simmetriche. Dal popolo passarono ai libri; da questi per via dei soldati in congedo e degli operai migranti, tornarono irriconoscibili alle veglie popolari. E non vi tornarono sole: ai Reali di Francia, al Guerrino il Meschino, alla Bella Maghelona e loro discendenti, s'accompagnano e succedono il Saint-Clair delle Isole e il Conte di Montecristo. Anche gli ingegni popolari perdono idealità; amano ancora il maraviglioso, ma lo vogliono spiegabile. Al demonio va scemando credito ogni giorno, l'inferno si spopola, la scienza elementare sopprime i miracoli, le notti diventano sicure, i crepuscoli non hanno stregoni, le strade non hanno malandrini, i cimiteri non hanno fantasmi, le antiche rovine non mandano gemiti e fragore di catene. Qualche vecchia comare parla ancora di Dame o nere o bianche o grigie o rosse, apparse la notte sull'alto delle torri, ma non ne tremano che i bimbi assonnati. Le ragazze ed i giovani menano le vacche a pascolare nei castelli diroccati, scovano le nidiate fra le merlature, si baciano nei vani delle finestre, si calano per buche oscure nei grandi androni stillanti, si attardano la sera fra le rovine discrete sui cuscini di musco senza ombra di paura o di sospetto. I padroni di alcuni castelli disabitati od inabitabili dovettero rifarne la porta e sbarrarla e acciecare le finestre a pian terreno, perchè a notte chiusa proprio nell'ora degli spettri, saliva gente del paese a far man bassa su quel pochissimo durato in piedi, a rubare i colonnini delle finestre e i gradini della scala.
Io interrogai più volte le guide, se mai i ghiacciai e gli altri luoghi mortali dell'alta montagna avessero generato storie fantastiche di genî amici o avversi all'uomo; ma durai fatica a farmi intendere e passai, credo, per insensato. Nemmeno trovai indizio di pronostici, tranne i soliti e sperimentali riguardanti il tempo e questi espressi sempre con saviezza dubitativa. Di credenze in forze o virtù soprannaturali, dalle divine in fuori, non traccia. Non già che quelle genti abbiano un'abitudine di esame, un senso critico o pratico più affinato che altri. A chi raccontasse loro con garbo qualche storiaccia inverosimile darebbero forse, o almeno non negherebbero fede. Richiesti: Ci credete? risponderebbero: è possibile! Non si sa mai! Dacchè lei lo dice! e via su quel tono; ma lo farebbero sopratutto per incuria, come per cosa che non li riguarda e che non torna il conto di considerare.
In sostanza, il montanaro è poco immaginoso. Parlo, ben inteso, del popolo: di quelle classi sulle quali non può, o pochissimo, l'educazione e l'artifizio letterario; le sole presso le quali trovandocela, la leggenda sarebbe genuina e saporita.
Tuttavia, nei tanti anni dacchè mi aggiro per le montagne qualche embrione di tradizione o di leggenda mi venne fatto di trovarla: leggende e tradizioni inedite, ben inteso, perchè delle altre ce n'è a migliaia, ma oramai neanche a raccoglierle dalla fonte popolare non si trovano sincere e per tondarle e mondarle occorrerebbe un lunghissimo studio comparativo.
Una volta stavo a Fenis in Val d'Aosta per cercare e copiare le scritture murali del castello. L'oste del paese discorreva volentieri e mostrava di saperla lunga. Lo domandai degli antichi signori. Mi rispose con molta sicurezza che il Castello era appartenuto al duca di Borgogna. Rimasi. La Valle d'Aosta appartenne realmente al primo ed al secondo reame di Borgogna, ma fino dal secolo XI passò ai Conti di Savoja nè più mutò padrone. Fenis poi, era feudo dei signori di Challant; il castello fu edificato da un Aimone di Challant verso il 1350, nè più uscì della famiglia finchè questa non andò estinta sul principio del secolo corrente. Tutta la vita castellana del castello di Fenis appartenne dunque alla Casa di Challant, spenta la quale, il castello decadde in cascinale ed il padrone, di signore in semplice proprietario. Come mai la remota dominazione borgognona aveva potuto far scordare la recente signoria dei Challant, e la perdurante sovranità Sabauda? Ma l'oste non conosceva nè il primo nè il secondo regno Burgundo, nè il casato dei Challant, nè del Sabauda altro che il nome del Re felicemente regnante; solo del suo duca di Borgogna aveva piena certezza, come se lo avesse conosciuto; e poteva provarne l'esistenza e la signoria mediante una storia, autentica, della quale non era in paese chi dubitasse. Ecco la storia.
Non molti anni addietro, sulla strada che sale a Fenis di qua dal ponte, c'era un vecchio uomo che faceva giorno e notte la guardia ad un grosso serpe. Il serpe non dava fastidio ad anima viva, stava tutto il giorno a crogiolarsi al sole sul muricciolo che fiancheggia la strada e la notte si rannicchiava per la petraia. Un giorno, scostatosi il vecchio per certi suoi bisogni, passò un forestiero il quale ebbe ribrezzo del serpe e lo uccise con una cannata. In quella tornò il guardiano e, veduto il serpe morto, si cacciò disperatamente le mani nei capelli, gridando: Ah! malheureux, qu'avez vous fait? Vous avez tuée Marguerite de France.
Di quale Margherita di Francia intendesse parlare, che relazione corresse fra questa e il duca di Borgogna, come quella favola bastasse ad infeudare il castello alla casa Borgognona, l'oste non mi seppe dire. Mi rifece la storia del serpe tre o quattro volte, sempre colle stesse parole e tirandola sempre alle stesse conclusioni. Il castello era stato dominio del duca di Borgogna perchè il serpe era Margherita di Francia; il serpe era Margherita di Francia, perchè il castello apparteneva al duca di Borgogna: la cosa era evidente, ed io che non capivo o avevo le mie ragioni per mostrare di non capire, o ero corto di cervello.
Le serpi hanno una gran parte nei favolosi racconti valdostani. Un contadino e consigliere comunale d'Issogne mi assicurava e lo avrebbe giurato, che i capelli delle donne morte messi nell'acqua si mutano in biscie. Ma la biscia non vi è considerata per l'animale immondo delle sacre scritture. Già la storia di Margherita di Francia, la mostra oggetto di cura e per poco non di venerazione. Un'altra leggenda la consacra quasi al rispetto delle genti.
Un giorno ero salito al villaggio d'Ussel dirimpetto a Châtillon, e visitata la rocca, sonnecchiavo nell'ora calda, sulla riva del torrentello che fiancheggia il paese. Capita una tribù di formiche rosse e mi assale. Alla prima puntura mi levo stizzito e stropicciando i piedi reco fra di loro lo scompiglio e la morte.
– Ah! Monsieur! vous faites da mal aux bêtes du bon Dieu; il vous arrivera malheur!
Chi parlava era un vecchio capitatomi dietro senza ch'io lo avvertissi. L'accento era così convinto, l'aspetto così venerabile e così grave la voce, che ne rimasi colpito. Mi scusai alla meglio ed egli allora, sedutomi vicino, cominciò a ragionare degli animali, che bisogna rispettarli, che sono creature di Dio, che noi non sappiamo quali spiriti si nascondano in essi. Fiutai un'altra Margherita di Francia e lo feci discorrere. Allora egli mi additò sulla montagna che sovrasta Châtillon, alcuni archi mezzo rovinati di un acquedotto romano.
Di tali acquedotti, miracoli di ardimento, ne rimangono molti in val d'Aosta. Da Châtillon o meglio da Ussel ne appaiono due egualmente maravigliosi, i quali tengono i due versanti della Val Tournanche: uno cinge la costa del monte verso Aosta; l'altro piega verso Ivrea. Il primo menava le acque a Nus, il secondo al villaggio di Saint-Vincent.
– Vedete, – mi disse il vecchio – quel ruscello là in alto? (Chiamava ruisseaux gli acquedotti ed accennava a quello che volge verso Nus). Quel ruscello doveva portare l'acqua di una fonte saluberrima a molti paesi della vallata. Occorsero a costruirlo molte opere costose e difficili: bisognò in parecchi luoghi forare il monte, in altri appoggiare muraglie a pareti liscie e precipitose di macigno. Più volte gli operai scoraggiti furono per abbandonare l'impresa, ma li sostenne e li rincorò lo zelo di un buono uomo di Nus, il quale li stimolava con parole, li allettava con regali e promesse, si metteva primo nei rischi, assicurava primo le travi dei ponti e vi si avventurava, portava i maggiori pesi, durava le maggiori fatiche, non dava pace a nessuno, tanto aveva a cuore il compimento dell'opera. Erano già superati i maggiori pericoli e non rimaneva che poco e facile lavoro, quando il brav'uomo rovinò da un ponte e morì. Come tutto fu lesto e la fonte fu immessa nel nuovo letto, gli operai che ne seguivano il corso videro una biscia nera e sottile precedere l'acqua come a mostrarle il cammino. Un ragazzaccio la uccise e tosto l'acqua che già scorreva allegramente tornò indietro nè ci fu verso di farla scendere mai più. In quella biscia era l'anima del brav'uomo, e Dio ne vendicava così l'uccisione.
Di questa favola, non è difficile rintracciare l'origine. Così in valle d'Aosta, come in altri paesi del Piemonte, i villani credono (non so se a torto od a ragione) che le anguille aiutino a tenere sgombre le vie occulte delle sorgenti. Appena scavato il pozzo, se l'acqua non vi pullula in abbondanza, vi gettano dentro un gruppo di anguille e vogliono che l'effetto sia sicuro. Dall'anguilla al serpe, presso i villani, poco ci corre, e non è a stupire se una volta attribuito il potere di rintracciare le scaturigini sotterranee, qualche savio uomo cercò di proteggerne per via di favolosi racconti l'esistenza.
Un'altra leggenda riguarda l'acquedotto di Saint-Vincent. Mi fu narrata dallo stesso vecchio e dice così:
Una volta quelli di Saint-Vincent, difettando d'acqua, deliberarono di derivarne un ruscello da Val Tournanche e gli uomini del paese si posero all'opera volonterosi. Ma viste le gravi fatiche ed i pericoli, già stavano per desistere, quando le donne proposero di volgere in messe a pro delle anime loro, tutto il filato dell'inverno. E fila, e fila, gli uomini tutto il giorno alla muratura, le donne tutta la notte alla rocca ed al fuso; finchè fu compito il ruscello e il filo venduto fruttò un bel gruzzolo. Il quale fu dato a custodire ad un savio e pio uomo, dei maggiori del paese. Ma costui era un birbo mascherato da santo. Come l'acqua fu messa nel ruscello, egli corse all'osteria con grosso seguito di briaconi e di sgualdrine, e la matassa delle messe fu dipanata dal demonio. Trincando, lo sciagurato cantava: L'eau s'en va et moi je bois. L'eau s'en va et moi je bois. Tanto che l'acqua tornò indietro e il ruscello rimase asciutto per sempre. La favola è meschina ed immorale, ma io spendo la moneta che trovo.
Il vecchio che mi raccontò la storia dei due acquedotti era un bellissimo tipo di leggenda. Vissuto in città, i pittori accademici lo avrebbero tirato a mille esemplari di santi e patriarchi; lassù faceva lo spaccalegna, mestiere caro a molti riputati stregoni e negromanti. Era alto, ben fatto, portava una zazzera unta e liscia, un moncone di codino ed una barba tra il bianco e il giallo, lunghissima e scarmigliata. Le sopracciglia, tra bianche e gialle ancor esse, spiccavano folte, ad angolo retto da una fronte prominente che ombreggiava il viso fino alla bocca. Il viso, anzi il capo intero era tutto peli: ne scaturivano da ogni parte; pareva rimpinzito di crino perdere il soverchio per tutte le vie. Le narici e le orecchie ne avrebbero fornito da fare il pizzo ad uno studente e i baffi lunghi entravano in bocca e ne riuscivano così diritti come se derivassero di gola. La barba saliva sulle gote fin sotto le occhiaie e per il largo collo della camicia la si vedeva ripullulare sul petto. Sull'ultimo lembo carnoso dell'orecchio dov'era infitto l'anello di argento che i vecchi villani portano ancora, giaceva un vero cuscinetto di peli fitti ed ispidi che nascondeva mezzo l'orecchino. La sua figura mobilissima commentava e coloriva ogni parola, anzi il viso preparava quasi le parole e le annunziava; attore drammatico, quell'uomo avrebbe fatto ridere e piangere il pubblico senza profferir verbo, col solo valore della maschera come lo chiamano i comici. Ai movimenti del viso, la barba faceva da indice ingrossatore; ad ogni impercettibile contrazione di muscoli, corrispondeva un agitarsi, un arruffarsi disordinato di peli, ognuno dei quali diventava un braccio di leva obbediente e sensibilissimo. Mentre raccontava le sue storie, correvano per quella foresta vivente, delle vere e proprie burrasche. A volte, in seguito a troppo rapidi mutamenti di fisonomia, le vibrazioni si intralciavano come fanno i cerchi dell'acqua per due pietre lanciate vicine, e ne seguiva uno scompiglio da non dirsi. Io non vidi mai una faccia più strana di quella, tanto che non ristavo di fissarla; ma egli era certo avvezzo a passare per fenomeno vivente, perchè la mia maraviglia non lo maravigliò punto, si lasciò guardare e riguardare senza averne imbarazzo, nè vergognoso nè superbo della propria singolarità.
Parlava a sentenze, in tono misurato, ma che andava a mano a mano accendendosi. Aveva una voce bassa ma limpidissima e vibrante, e raccontava con molta evidenza, mettendo nei punti del maggiore interesse certe soste ansiose piene di mistero. Durante il racconto, vigilava cogli occhi, se gli prestavo fede. A un certo punto, bisogna dire che mi sia sfuggito un risolino involontario, perchè troncò il discorso, mi fissò corrugato e mi disse: – Non credete? – Accompagnò queste parole con un riso così sdegnoso, le profferì con accento di tale superiorità, mi guardò con tanta commiserazione, che mi affrettai a tranquillarlo più per pensiero della mia dignità che per cortesia. Non mi bisognarono molte parole. La verità del suo asserto gli pareva troppo evidente; i fatti che narrava gli risultavano forse da troppo sicura testimonianza, perchè potesse temere a lungo che altri ne dubitasse. Quando gli domandai come egli avesse apprese quelle storie, fece un viso misterioso e non rispose: solo dagli occhi traspariva una superba compiacenza di sè, che mi parve derivare dalla coscienza di un sapere negato al più degli uomini. Seguitando il discorso, mi disse aver egli ricevuto dal cielo il dono di conoscere le malattie e di guarirle, e la scienza umana dei medici non valere nulla appetto alla sua.
Ora quel vecchio è morto da più anni, ed io penso alla memoria che ne dev'esser durata nel suo piccolo villaggio. Là certo in sua vita, le mamme lo additarono ai bambini per indocilirli e questi lo sognarono durante gli incubi delle indigestioni. Se è vero che la paura ingrossa gli oggetti, che lunghezza iperbolica dovette avere nei sogni, quella barba dogale! I bimbi che lo conobbero, non troveranno mai più per il mondo un essere vivente che lo somigli, perchè ne ricorderanno l'immagine fantastica in luogo della reale. Certo i suoi prodigi lasciarono traccia, certo sono vantati anche oggidì, la virtù delle sue erbe e de' suoi sortilegi e lo sprezzo ch'egli faceva del sapere umano. Morti quelli che furono adulti e vecchi con lui, Dio sa quali miracoli gli saranno attribuiti, che potenza verrà via via acquistando il suo nome! A mano a mano che la sua lunga carcassa andrà disfacendosi sotterra, la sua memoria ingrosserà fra i viventi; egli vivrà una seconda vita, impensata, inattesa, piena di vicende strane, una vita a rovescio della reale, che si farà sempre più vigorosa invecchiando. Quel paese che forse non lo elesse nemmeno a consigliere comunale, tremerà di lui, invocherà nei supremi pericoli la sua memoria, lo collocherà a mezza altezza sulla scala degli esseri sovrumani, fra i santi ed il demonio. Egli che del demonio aveva tanta paura!