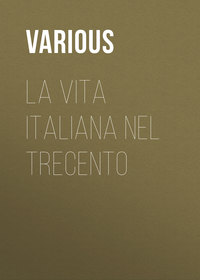Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La vita italiana nel Trecento», sayfa 20
Se grande però era la venerazione del Boccaccio per il Petrarca, egli sapeva anche a tempo parlargli con quella franchezza ch'era propria di lui. Giunse un giorno all'orecchio del Boccaccio che il Petrarca aveva accettato l'ospitalità dei Visconti, e all'uomo povero e onesto parve ciò imperdonabil delitto, tanto più che egli si ricordava come già nel loro soggiorno a Padova avesse udito l'amico gridare contro le tirannide dei signori di Milano. E presa tosto la penna gli scrisse, ricordandogli prima com'egli a Padova parlasse dello stato infelice dell'Italia, e della tirannia dell'arcivescovo Giovanni Visconti; “ti dirò il vero, io sono rimasto di sasso, ed ho detto, è impossibile. Ma poi da una tua lettera stessa sentii la notizia accertata. Oh Dio! chi mai avrebbe potuto aspettarsi tanta mobilità di carattere? Chi avrebbe creduto che per avidità tu potessi così rinnegare la tua fede? Hai forse fatto ciò per vendicarti dei tuoi concittadini? Ma quale uomo di onore, se anche avesse ricevuto qualche torto dalla sua patria, si unirebbe coi nemici di lei? Oh quanto hai tu mortificato con questo atto i tuoi ammiratori ed amici, che non si stancavano mai di lodarti e di proporti ad esempio a ogni virtù?„
Queste parole franche e fiere, questo rivolgersi con tanto coraggio all'uomo ch'ei chiamava maestro, che circondava di tanto rispetto, ch'era per lui quasi un idolo, ci mostra quanto nobile fosse il carattere del Boccaccio, e come egli sentisse altamente gli obblighi dell'amicizia. Non egli certo, che era pure angustiato dalla povertà e che così infelice si trovava sotto il duro tetto paterno, non egli avrebbe sacrificata la propria dignità e il proprio onore, sino a divenire l'ospite dei più feroci tiranni d'Italia. Vero è che il Petrarca con uno di quei gridi d'orgoglio che gli uscivano di tratto in tratto dalle labbra si giustificava dicendo: non sono già io che vivo presso i principi, sono essi che vivono presso di me. Ma queste non erano che frasi. Il Boccaccio nella sua integrità sentiva che l'amico suo era colpevole, colpevole d'ambizione e di cupidigia, e a viso aperto dicevagli quel ch'era il vero, affrontando così lo sdegno dell'uomo che pur gli era supremamente caro.
Nè questo è tutto: a certi superbi disdegni del Petrarca sapeva il Boccaccio opporsi senza tergiversazioni e senza timori. Egli aveva un vero culto per Dante, e doveva sapere che l'amico suo poco l'amava e forse in cuor suo disprezzavalo. Onde un giorno gli mandò un esemplare della Divina Commedia, accompagnandolo con un carme latino, nel quale traspare tutto il suo entusiasmo per l'Alighieri, e nel quale, ancora, non manca un po' di maliziosa ironia per il disdegno Petrarchesco. Accogli, dice, accogli quest'opera gradita ai dotti, mirabile al volgo… nè ti sia duro mirar versi che tengono la loro armonia sol dalla patria favella: sono d'un poeta esule, che, gran peccato della fortuna, non ebbe corone… Accogli, ti prego, questo tuo concittadino e dotto insieme e poeta; accoglilo, leggilo, uniscilo a' tuoi, onoralo, lodalo…
Questa schiettezza, dice il Gaspary, colla quale il Boccaccio riconosce la grandezza degli altri, ce lo rende specialmente simpatico. E l'amor suo a Dante dimostra com'egli meglio del Petrarca intendesse per quale via oramai, dopo il grande poema dantesco, dovesse porsi la letteratura italiana.
E a porla su quella via contribuì egli potentemente. Il Petrarca spregiava il volgare, non si riprometteva fama che dalle opere latine, si vergognava, da vecchio, di avere scritto il Canzoniere. Che sarebbe accaduto della nascente letteratura, se questo concetto avesse prevalso? Ma il Boccaccio seppe tenere in pregio la lingua italiana, ed egli, così fervido amatore de' greci e de' latini, scrisse in volgare la maggior parte delle opere sue, apparecchiandosi così a quella tra esse, che fa di lui uno de' patriarchi della nostra letteratura.
Il Decamerone è, come ben sapete, una raccolta di cento novelle.
La novella era un genere letterario che piacque grandemente al medioevo: che gli piacque per quell'ardente desiderio dei racconti che era comune a tutti nell'età infantile dei popoli europei; che gli piacque ancora, perchè potè usarne largamente per i suoi istinti e pei suoi scopi di misticismo. Tutta una ricca serie di opere ci mostra questo speciale carattere della novella dell'età di mezzo: il carattere cioè di servire ad una data applicazione morale, o più spesso ad un precetto ascetico: ed è notabile il fatto, che, per servire a ciò, essa non rifugge dalla narrazione delle cose più stravaganti e si tuffa anzi ben spesso in tutto quello che può esserci di più ributtante e di più sconcio, di più sciocco e di più immorale. In quei libri è una mescolanza continua di turpe e di ridicolo. Ma cosiffatto è il misticismo dell'età di mezzo: un idiotismo delle menti, rimpiccolite e annebbiate dall'oltremondano, che non sanno uscir mai da quel ristretto giro d'idee, dove inesorabilmente le confina il falso concetto che si son fatto della vita e del mondo; dove le costringe quel deperimento morale della coscienza, quella mancanza del sentimento umano, tutto insomma quell'insieme di condizioni patologiche onde si compone il medioevo. La reazione contro un tale sonnambulismo dei cervelli non mancò: ben presto il giullare francese intuonò il suo fabliau gaio e mordace. Ma il fabliau è tutto quello che può immaginarsi di più ruvido, di più scopertamente basso e triviale. Esso non conosce nè eleganza, nè delicatezza di forma, nè elevatezza di sentimento. È quasi un grido brutale che si sprigiona dall'anima inconscientemente. Per quale ragione dunque, come scrive il Villari, quei personaggi incerti, fantastici, e astratti de' racconti francesi, che traversan come ombre tutto il medioevo, divengono a un tratto personaggi reali nel Decamerone? In esso troviamo, con la più pura ed elegante favella, descritta la intricata e molteplice vicenda delle cose umane. Il maraviglioso e l'impossibile spariscono e ci viene invece riprodotto quel contrasto di capricciosa fortuna e di umane passioni, che crea la mutabilità della nostra sorte. Il poeta ha una grande esperienza degli uomini, ed un continuo sogghigno sulle labbra, poichè egli vede, sotto la sua penna, un mondo di sogni e di fantasmi trasformarsi nel mondo reale di uomini schiavi delle loro passioni e dei pregiudizi che essi medesimi crearono. Quella tendenza che noi osserviamo continuamente nel Boccaccio di dar carattere storico ai suoi personaggi, di determinare la nascita, la patria, la vita, il nome di uomini che vissero solo nella fantasia del popolo, ci prova chiaro il bisogno di realtà e di verità, che è in lui come in tutti i nostri grandi scrittori.
Tutte infatti le figure del Boccaccio sono di rilievo, sono caratteri che egli ha studiato, e che ci mette sotto gli occhi vivi, parlanti. Le sue novelle sono azioni drammatiche ritratte dal vero. Noi possiamo scegliere là dentro quel che vogliamo da ser Ciappelletto a Belcore, da Calandrino a Griselda, da Masetto da Lamporecchio a frate Alberto: troveremo sempre una grandezza di rappresentazione, una pittura così oggettiva, dei tratti di pennello così franchi, decisi, presi dal vero; una grandiosità d'insieme e una cura minuta dei particolari che inutilmente si cercherebbero nelle produzioni dei tempi anteriori.
Il Decamerone è una grande opera d'arte, è la commedia umana in tutti i secoli, in tutti i paesi, in tutte le condizioni, disegnata sul fondo della natura al lume della ragione. Niuno dopo Dante e prima dello Shakespeare creò come il Boccaccio tante figure diverse, in tante diverse posizioni11. Se in un luogo egli rappresenta scene colte sul vivo nella più abietta vita napoletana, altrove si piace novellando dar prova che amore è fonte d'ogni virtù; e contro il medioevo che malediceva la donna egli se ne fa difensore, e contro il medioevo adoratore de' cherici, egli se ne fa flagellatore indomabile: non flagellatore colla satira terribile dell'Alighieri, ma col riso beffardo, ond'ha reso immortali le figure di frate Alberto, del prete di Varlungo, del proposto di Fiesole e d'altri mille.
Io non posso entrare, davanti a voi, o signore, in particolari minuti sulle novelle del Decamerone, o almeno su quelle che più meriterebbero studio. Ma per darvi un'idea della geniale malizia, della finezza comica di messer Giovanni vi citerò due esempi: quello di ser Ciappelletto e del giudeo Abraam. Ser Ciappelletto (che noi sappiamo oggi essere stata persona reale) è dipinto come un grande bestemmiatore, un falsario, un ladro, un usuraio, il quale persino sul letto di morte inganna il confessore. Eppure ser Ciappelletto quando è morto diventa un santo e tanto cresce la fama della sua santità che a lui tutti si votano: ed affermasi, dice il Boccaccio, “molti miracoli Iddio aver mostrati per lui e mostrare tutto giorno a chi divotamente a lui si raccomanda„: segno questo della infinita misericordia divina. Vedete voi spuntare un sorriso motteggiatore sulle argute labbra di messer Giovanni, mentre scrive quelle parole? Come meglio poteva egli deridere le facili credenze del volgo negli impostori e negli ipocriti, come meglio smascherare le arti dei bricconi che voglion passar per santi?
Più acuta e tagliente ancora la satira nella novella di Abraam, il quale è un giudeo che istigato a farsi cristiano vuol prima andare a Roma “e quivi vedere colui il quale tu di' che è Vicario di Dio in terra e considerare i suoi modi e i suoi costumi, e similmente de' suoi fratelli cardinali; e se essi parranno tali che io possa comprendere che la vostra fede sia migliore che la mia„ io mi farò cristiano. Ora cosa accade? Il Giudeo va infatti a Roma, osserva il papa e i cardinali, vede che essi sono golosi, bevitori, ubriachi, avari, simoniaci, coperti insomma d'ogni più ignominioso peccato; e allora si fa davvero cristiano, poichè, egli dice, se tanti prelati e lo stesso pastore supremo si affaticano instancabilmente a distrugger la Chiesa, e ciò nondimeno essa vive ancora, segno è che lo Spirito Santo ne è fondamento e sostegno.
Se Dante aveva dannati tragicamente papi e cardinali all'inferno, comicamente ora il Boccaccio li metteva alla gogna; più atroce pena, forse, di quella, perchè traentesi dietro uno scroscio di risa, non cessato ancora traverso i secoli.
E se delle risa che suscita il Decamerone sui preti, sui frati, sugli amanti, sui mariti, sulle donne cattive e sugli uomini gonzi, su tutta una turba infinita che ci passa davanti viva, vera, sublime nella sua comica realità, io potessi parlarvi, sentireste quanto sia vero quello che disse un moderno, essere stato il Boccaccio il più terribile vendicatore dei diritti umani contro le ascetiche malvagità. Ma il silenzio mi è imposto su questa che è certo la più bella e caratteristica parte del Decamerone. Permettetemi solo ch'io vi dica ancora come sapesse il Boccaccio mirabilmente infondere uno spirito nuovo nell'antica leggenda, e anche qui innestare la nota comica nel tragico racconto, creato dalle malate fantasie medioevali. Tutti i volghi d'Europa tremarono un giorno al racconto della caccia infernale. Un povero carbonaio, mentre vegliava nella sua capanna a guardia della fornace, sentì, a mezzanotte, alte grida di dolore. Uscì per vedere quello che fosse, e vide venir correndo e stridendo una femmina scapigliata e ignuda e dietro le veniva un cavaliere in su un cavallo nero correndo, con un coltello ignudo in mano, e dalla bocca e dagli occhi e dal naso del cavaliere e del cavallo uscia fiamma di fuoco ardente. Giunta alla fornace, la femmina corre intorno ad essa, ed ivi è raggiunta dal cavaliere, che l'afferra per i capelli svolazzanti, la trafigge col coltello nel petto e la getta nella fossa ardente, dalla quale poi la ritrae viva e fugge con essa. Quella donna e quel suo persecutore erano stati nella vita una dama e un cavaliere che si erano amati ardentemente, e per lui la donna aveva ucciso il marito, onde era stata condannata ad essere ogni notte uccisa ed abbruciata dall'amante, che provava egli stesso quei tormenti dei quali era esecutore.
Tale, in una delle sue svariate versioni, la leggenda della caccia infernale, narrata da Elinando, da Vincenzo di Beauvais, dal Passavanti e da altri, e procedente forse dal mito nordico del dio Wuotan cacciatore demoniaco inseguente la donna selvaggia.
Sentite ora il Boccaccio: Nastagio degli Onesti, da Ravenna, amava perdutamente una fanciulla de' Traversari, la quale sempre si era all'amor suo rifiutata, ponendo il giovane alla disperazione. Per tentare di dimenticarla o di mitigare almeno la sua cocente passione, partì egli da Ravenna per Chiassi, e, quasi inconsapevole di quel che faceva, s'inoltrò una sera nella pineta, sempre pensando a colei ch'era verso di lui tanto crudele. “Quando (son le parole stesse del novelliere) subitamente gli parve udire un grandissimo pianto e guai altissimi messi da una donna; perchè rotto il suo dolce pensiero, alzò il capo per vedere che fosse… e vide venir correndo verso il luogo dov'egli era una bellissima giovane ignuda, scapigliata e tutta graffiata dalle frasche e da' pruni, piangendo e gridando forte mercè; ed oltre a questo le vide ai fianchi due grandissimi e fieri mastini, li quali duramente appresso correndole, spesse volte crudelmente dove la giungevano la mordevano; e dietro a lei vide venire, sopra un corsiero nero un cavalier bruno, forte nel viso crucciato, con uno stocco in mano, lei di morte con parole spaventevoli e villane minacciando.„ Il cavaliere, da Nastagio interrogato, gli disse esser stata quella donna ribelle all'amor suo, ond'ei si uccise: ed essere stati ambedue condannati all'inferno con questa pena: “a lei di fuggirmi davanti, ed a me, che già cotanto l'amai, di seguitarla come mortal nimica, non come amata donna; e quante volte io la giungo, tante con questo stocco col quale uccisi me uccido lei, ed aprola per ischiena, e quel cuor duro e freddo nel qual mai nè amor nè pietà poterono entrare, coll'altre interiora insieme le caccio di corpo e dòlle mangiare a questi cani. Nè sta poi grande spazio ch'ella, sì come la giustizia e la potenza di Dio vuole, come se morta non fosse, risorge, e da capo comincia la dolorosa fuga e i cani ed io a seguitarla; ed avviene che ogni venerdì in su quest'ora io la giungo qui, e qui ne fo lo strazio che vedrai.„ Nastagio degli Onesti, udendo queste parole, pensò di trar profitto per sè della strana avventura, fece in modo che la fanciulla de' Traversari assistesse il venerdì successivo all'orrendo spettacolo; e questa tanto spavento ne ebbe e tanto temè che un giorno potesse accadere a lei il simigliante, che all'amor suo arrendendosi divenne sua moglie. “E non fu, conclude il malizioso Certaldese, non fu questa paura cagione solamente di questo bene, anzi sì tutte le ravignane donne paurose ne divennero, che sempre poi troppo più arrendevoli a' piaceri degli uomini furono, che prima state non erano.„
Questa novella, osserva un moderno, par quasi la parodia della leggenda. Quella finisce col terrore degli ascoltatori, e coll'esortazione alla penitenza; la novella Boccacesca consiglia alle donne d'esser pieghevoli all'amore e si chiude con una risata. Il mondo leggendario tramonta; ciò che prima aveva atterrito i cuori diventa ora un sollazzo per la mente.
Il gran libro del Certaldese è insomma un documento del più alto valore per la storia del pensiero umano. In esso noi troviamo i più forti e caratteristici segni della reazione contro tutte le idee medievali, sia nelle novelle che ci mostrano il Boccaccio ardito propugnatore della libertà di coscienza, sia in quelle dove flagella gli ipocriti, i falsi spacciatori di miracoli, i preti attentatori all'onore delle famiglie, le monache nasconditrici delle loro debolezze nel segreto de' claustri profanati. Ci sono nel Decamerone certi tipi immortali, che a ricordarli solo, si sente come per essi fosse colpita a morte tutta un'età; ser Ciappelletto, fra Cipolla, Martellino, Masetto da Lamporecchio, Rustico Monaco, frate Alberto celebrano il gaio funerale del medioevo, cantano l'alba del mondo moderno. Oramai i nuovi tempi sono maturi. Si torna ad avere un concetto più giusto della vita e della natura: il mondo non è più nè disprezzato nè maledetto, non è più fatto antitesi del bene, della felicità, della virtù; dalle nebbie del paludoso misticismo, s'innalzano gli uomini a più serene e luminose regioni, dove la verità e la bellezza si abbracciano, immortali sorelle. L'uomo rinasce, e con lui riprende i suoi diritti l'umana ragione e più vasti orizzonti si aprono al suo emancipato pensiero. Le ricche forme del mondo greco-latino, le sue rosee immagini, i suoi caldi colori, riconciliano natura e spirito, idealità e materia; e al contatto di esso tutto si rinnovella, la politica, la religione, l'arte e la letteratura. Vedete: già sono sulla soglia della storia il magnifico Lorenzo, nel quale così mirabilmente si armonizzeranno la tradizione e l'attualità, e il dotto Poliziano che sarà come la sintesi vivente dell'elemento classico e popolare; il Masaccio che studierà gli effetti del rilievo, il chiaroscuro, lo scorcio, il colorito: il Pollaiuolo che scorticherà i cadaveri per cercare i muscoli. Questo ringiovanire delle forze umane, estenuate nell'affannosità dei sospiri ascetici e dei sillogismi scolastici, questo ricongiungersi del pensiero alla terra e all'umanità e staccarsi dal simbolismo e palpare con mano amorosa la natura ignuda, era ben necessario perchè potessero educarsi alla scuola della ragione e della esperienza i politici, i riformatori, i filosofi, tutti i grandi preparatori della moderna civiltà.
E a questo nuovo mondo, uscente dalla tetra necropoli del medioevo, diede alito vivificatore il Boccaccio; il buono e tranquillo messer Giovanni, che fu dispregiatore degli onori, sempre sereno nella sua grande coscienza di artista, innamorato sopra tutto della gloria e delle belle donne, e che scese nel sepolcro povero, egli che lasciava al mondo i tesori della sua prodigiosa ricchezza.
IL TRAMONTO DELLE LEGGENDE
DI
ARTURO GRAF
Signore e Signori,
Uno dei fatti più notabili della storia intellettuale e morale dei popoli cristiani nel medio evo si è la produzione di quello sterminato numero di leggende, varie d'indole, di significato e di forma, che furono allora tanta parte della credenza e della letteratura; e uno dei fatti più notabili della storia intellettuale e morale degl'Italiani in quella età si è che, meno di ogni altro popolo dell'Occidente, essi cooperarono a tal produzione. Non già che abbiano, generalmente parlando, ignorate o sgradite quelle pie od eroiche finzioni; ma il più delle volte si contentarono di riceverle dai vicini, già belle e formate: e se le ripeterono spesso con devozione ed amore, tradotte nella loro favella; se, non di rado, le rimaneggiarono e le ampliarono, acconciandole ai propri sentimenti e bisogni, non però si diedero gran fatto pensiero di accrescerne la vasta e prestigiosa congerie. Rubando i vocaboli al linguaggio delle industrie e dei traffici, si potrebbe dire che gl'Italiani consumarono molte leggende e ne produssero poche; ne importarono in copia e ne esportarono assai scarsamente.
Le maggiori leggende, così sacre come profane, le quali ebbero corso nel medio evo, e furono, per secoli, patrimonio comune della cristianità, nacquero, pressochè tutte, e crebbero fuori d'Italia. Delle ascetiche, molte, che più strettamente si legano alle Scritture, sono antichissime, e apparvero dapprima in Oriente, dov'era stata la culla della fede, e d'Oriente passarono a mano a mano in Occidente, seguendo alcuna volta assai da presso la predicazione e la diffusione dell'Evangelo. La leggenda della penitenza di Adamo ed Eva; quella, ben più famosa, del legno onde fu formata la croce; quelle ancora di Giuda e Pilato, della discesa di San Paolo all'Inferno, dei Sette Dormienti, della Vendetta del Salvatore, di San Silvestro che sanò e convertì Costantino imperatore, dell'Anticristo, che alla fine de' tempi verrà a porre in grande travaglio la Chiesa e il mondo, e altre parecchie, le quali sarebbe lungo ricordare, ebbero per lo appunto, in tutto o in parte, sì fatta origine e sì fatta vicenda, e alcune di esse non penetrarono, a quanto sembra, in Italia, se non dopo che si furono sparse per varie province d'Europa. Nella storia necessariamente oscura e confusa di queste finzioni, non è sempre possibile, gli è vero, rintracciare i primi cominciamenti, seguire le derivazioni e i trapassi; ma l'incertezza che non si scompagna da' singoli casi non muta però l'indole del fatto generale. Molte altre leggende ascetiche ebbero diffusione in Italia, le quali indubbiamente sorsero fuori dei nostri confini, qua e là per l'Europa, spesso tra genti assai remote da noi, e talvolta quasi ancora barbare. Tali quelle meravigliose e paurose Visioni del mondo di là, che precedono il poema di Dante, e, in un certo senso, il preparano. Parecchie, come la Visione di San Furseo, la Visione del cavaliere Tundalo, la leggenda del Pozzo di San Patrizio, ebbero divulgazione e celebrità grandissima, e furono note e ripetute anche in Italia; ma quando se ne tolgano alcune poche di minor conto, riferite da Gregorio Magno e da san Pier Damiano, e quella, assai tarda, del monaco Alberico, tutte l'altre, così, le maggiori come le minori, avemmo dagli stranieri. Altrettanto dicasi di quella singolare peregrinazione dell'irlandese san Brandano, che acconciamente fu chiamata una Odissea monastica, e di molte altre leggende ove si narrano viaggi miracolosi al Paradiso terrestre.
Se, lasciate da una banda le leggende ascetiche, ci volgiamo all'eroiche e romanzesche, vediamo che le condizioni dell'Italia, per rispetto alla produzione loro, non mutano. Tutta, o quasi, la poesia epica nostra è nudrita di tradizioni e di leggende non nostre. Le storie favolose di Alessandro Magno, i romanzi di Apollonio di Tiro e di Fiorio e Biancofiore sono orientali d'origine; e, come tutti sanno, le leggende epiche del ciclo carolingio e del ciclo brettone, o, secondochè usò dirsi nel medio evo, la materia di Francia e la materia di Brettagna, ci vennero appunto di Francia.
In tutto ciò, se v'è del notabile, non v'è però nulla di strano; ma bene vi parrà essere alcun che di strano nel fatto che sienci venute di fuori, e di gran lontananza talvolta, leggende nelle quali di proposito si parla di cose nostre, o che a cose nostre si legano strettamente. Concedete ch'io rechi di ciò alcuni esempi.
Tutti sanno a quale curiosa trasformazione sia andato soggetto Virgilio nel medio evo, e quale rigogliosa leggenda gli sia cresciuta d'attorno. Di poeta che fu, egli divenne a poco a poco maestro di tutte le scienze, e poi mago, operator di miracoli e dominator di demoni. Si mostravano in Roma e in Napoli gli edifizi meravigliosi da lui costruiti, i talismani e gli amuleti da lui congegnati, in benefizio e a tutela dell'una o dell'altra città. Una gran fabbrica, detta Salvatio Romæ, fatta per arte magica, e mercè la quale i Romani erano incontanente avvertiti di qualsiasi ribellione che avvenisse tra i popoli sottoposti al loro dominio, era opera sua; opera sua la strada che correva da Roma a Napoli; opera sua la Grotta di Posilipo, ecc., ecc. E molte meraviglie si raccontavano della sua conversione, della sua morte, della portentosa virtù che conservavano le sue ossa. Ora, sebbene sia più che probabile che molte di queste immaginazioni abbiano origine popolare, e siano primamente sorte in Napoli, dov'era e si venerava il sepolcro del poeta; e sebbene parecchie si annodino a una tradizione letteraria già cominciata anticamente in Italia, non è men vero che altre (non posso indugiarmi qui a fare le distinzioni opportune) nacquero fuori d'Italia; come, da altra banda, gli è certo che e quelle e queste si trovano ricordate la prima volta da stranieri, da Giovanni di Salisbury, da Giovanni di Alta Selva, da Corrado di Querfurt, da Gervasio da Tilbury, da Alessandro Neckam, tre inglesi, un francese, un tedesco.
Altro esempio. Sapete che cosa l'antica leggenda epica racconti del re Artù, che mortalmente ferito in battaglia, fu dalla sorella Morgana, la famosissima fata, portato nell'isola di Avalon, e quivi serbato miracolosamente in vita. Orbene, in sul principio del secolo XIII, e probabilmente anche assai prima, Artù, non mai guarito delle sue ferite, è in Sicilia, e abita sul monte Etna, o nell'interno di esso, in un palazzo di mirabile fattura, cinto di deliziosi giardini. Ma da chi sappiamo noi ciò? dal testè ricordato Gervasio da Tilbury, inglese, da un monaco tedesco, che aveva il capo pieno di diavolerie, Cesario di Heisterbach, morto verso il 1240; dall'innominato autore di un poema alquanto più tardo, il Florian et Florète dove si legge ciò che quegli altri due debbono sapere, ma non si curano di dire, cioè, che l'Etna è una specie di regno fatato, pieno di meraviglie e di delizie, consueta dimora di Artù e della sua corte. Gli è probabile che questa forma nuova data all'antica leggenda si debba alla fantasia dei Normanni: comunque sia, non se ne trova cenno in scritture italiane, salvo che in una bizzarra poesia, composta, come pare, nel secolo XIII, nella quale n'è uno assai fugace ed oscuro.
E poichè sono a parlar di vulcani, siami concesso di ricordare come i vulcani si credessero comunemente nel medio evo luoghi di pena per le anime dannate o purganti. Parecchie leggende s'inspirarono di quella credenza; e poichè l'Etna, il Vesuvio, l'Epomeo, lo Stromboli, sono in casa nostra, parrebbe che quelle leggende dovessero essere sempre, o quasi sempre, italiane, e riferite da autori italiani. Eppure non sono; o se, quanto all'origine, sono alcune di esse italiane, non però trovano, o di rado trovano luogo in libri italiani. Gregorio Magno, romano, narra di un solitario dell'isola di Lipari, che vide precipitare nella bocca di quel vulcano il re Teodorico, dannato; ma questa novella, ripetuta poi da innumerevoli stranieri, appena trova in Italia, durante tutto il medio evo, chi la voglia ripetere. Altre leggende simili si narrano del re Dagoberto di Francia, di Bertoldo V, duca di Zäringen, di Attone, vescovo di Magonza, di altri parecchi; ma sono sempre stranieri coloro che le narrano. L'Etna è l'Inferno, o un vestibolo dell'Inferno, al quale i diavoli portano quotidianamente a volo le anime dei dannati; ma è un cronista francese del secolo XIII colui che lo afferma, Alberico delle Tre Fontane. In fondo al lago d'Averno, presso Pozzuoli, si vedono le porte di bronzo dell'Inferno, divelte e infrante da Cristo quando penetrò nel limbo; ma se tutti le vedono, chi ne parla è il già ricordato Gervasio.
Se questa litania non v'annoia troppo, io seguito un altro po' perchè non mi par che sia inutile.
In un anno del secolo undecimo che, discordando gli storici, non si sa precisamente qual fosse, avvenne nell'aurea città di Roma un caso nuovo, strano e memorabile. Un giovane patrizio, avendo il giorno stesso delle sue nozze posto in dito a una statua di Venere, per poter più liberamente giocare alla palla, l'anello nuziale, fu poi, per lunghissimo tempo, perseguitato e tribolato dall'antica dea mutata in demonio, la quale, allegando il fatto dell'anello, pretendeva di essere sua legittima sposa e di togliere il luogo all'altra. Ci volle tutta l'arte di un solennissimo mago per strappare all'intrusa l'anello indebitamente ricevuto e restituire il giovane alla libertà e a più naturali amori.
Questa novella piacque oltre modo nei due secoli che seguirono, e fu narrata da molti cronisti; ma tra i molti inglesi la più parte e frati, voi cerchereste inutilmente un italiano; o dovrò dire che a me non riuscì di scovarlo. Solo molto più tardi, in pieno secolo XVI, se ne vede fatto ricordo in un libro del piemontese Simone Majolo.
Un altro bel caso ci si offre nella leggenda di Gerberto, il quale non fu italiano, ma molti anni visse in Italia, e da ultimo fu papa in Roma, dal 999 al 1003. Non v'è dubbio che la persona e gli atti di lui dovettero stare molto a cuore agl'Italiani di quel tempo, e più particolarmente ai Romani. La leggenda narra di lui cose singolari, spaventose ed incredibili: che, essendo in Ispagna per cagion di studio, rubò a un negromante saraceno un libro magico di mirabile virtù e pregio; che fece un patto col diavolo; che fu il drudo di una diavolessa, che si faceva chiamar Meridiana, ed era, al vedere, più bella di un angiolo; che con l'ajuto, non del Cielo, ma dell'Inferno, salì tutti i gradi della ecclesiastica gerarchia, finchè s'assise, con sacrilega tracotanza, sulla cattedra di San Pietro, e fu vicario di Cristo; che essendo in Roma, penetrò per sua avvedutezza in certi sotterranei meravigliosi, ov'erano raccolti, e custoditi gelosamente, gl'immensi tesori d'Ottaviano Augusto imperatore; che sentendo prossima la sua ultima ora, rientrò in sè, si pentì, e con atroce e non più udita penitenza riscattò l'anima dalle mani dei demoni, che già gli si affollavano intorno furiosi, facendosi, vivo ancora, tagliare a pezzi. Io non so dire, e nessuno, credo, saprebbe se qualche parte di tale storia sia prima germogliata in Italia; ma gli è certo che essa si trova da prima solo in libri stranieri. I cronisti italiani non cominciarono a riferirla se non nel secolo XIV, quando già da oltre due secoli essa correva l'Europa, e i racconti loro non sono se non ripetizioni, e più spesso abbreviature dei racconti d'oltr'alpe.
Come non ricordare, dopo la leggenda di un papa, quella di una papessa, della famosa papessa Giovanna? Se si dovesse dar fede a certi manoscritti, il primo a darle lo spaccio sarebbe stato quell'Anastasio Bibliotecario, che visse in Roma nella seconda metà del secolo IX, fu abate di Santa Maria in Trastevere e scrisse certe Vite dei pontefici assai cognite agli storici di professione; ma, prima di tutto, non si conosce con sicurezza s'egli fosse italiano o greco; poi quei manoscritti sono di genuinità peggio che sospetta, e si ha buona ragione di credere che l'intera novella sia una interpolazione o aggiunta di tempi posteriori. Nacque essa in Italia? Nessuno può dirlo, e non è gran fatto probabile perchè se si trova in iscorcio in alcuni dei nostri cronisti, e se in tempi già assai tardi la narra malignamente, per disteso, il Platina, sono assai più gli storici forastieri che la raccontano, l'adornano, la commentano.