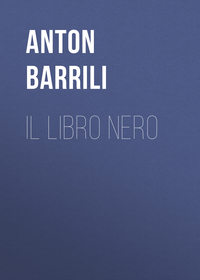Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Il Libro Nero», sayfa 11
– Sia fatta la tua volontà; nel primo lampo di folgore che solcherà l'aria, noi partiremo. Ma in questa partenza è l'ultimo saluto di Helel. La sua dimora è sulla terra; egli non ti seguirà dove vai.
– E dove andrò io dunque?
– Non so! – disse lo spirito, a cui il volto si dipinse di profonda mestizia.
E raccolto Ugo il felice nelle sue braccia, gl'impresse sulla fronte il bacio dell'addio.
Il bagliore d'un lampo illuminò in quel punto la camera; la folgore scoppiò sulla torre del Negromante, che crollò con orribile frastuono dalle sue fondamenta.
CAPITOLO XIX
Qui si narra dell'ultima sbevazzata di frate Gualdo cisterciense
Torniamo, se non disgrada ai lettori, un passo indietro, e dalla torre del Negromante rechiamoci nella gran sala del castello.
Qual mutamento! La sala di giustizia, sala severa, dalle cui pareti pendevano i pennoncelli dei Roccamàla, i loro stemmi e quelli delle famiglie ad essi congiunte per vincoli di parentado, dove si ammiravano le armi dei valorosi antenati, dalla corazza di Ugo il negromante fino alla spada di Ruberto il taciturno, era diventata una cantina, e delle peggio ordinate, per giunta. Idrie, guastade, anfore d'ogni forma e d'ogni misura, occupavano i ripiani degli armadii spalancati, le lastre dei canterani, l'ammattonato del pavimento. Una botte, colà recata per maggiore comodità, faceva bella mostra di sè in un cantuccio, con la sua spina pronta a spillare i liquidi topazii di Cipro. Un'altra botte stava seduta nel mezzo sulla scranna feudale; ed era fra Gualdo, il sozio fedele del conte Anacleto Benedicite, tondo come l'O di Giotto, vera effigie di Sileno in tonaca da cisterciense.
Fra Gualdo era il vero padrone di Roccamàla. Egli aveva piantato, come suol dirsi, la labarda nel castello, nè s'era più mosso di lassù, dopo la malattia dell'amico, il quale era tocco nel nomine patris e non c'era verso di fargli ricuperare la ragione smarrita.
Il vecchio strozziere soleva alzarsi per tempo, innanzi l'aurora, e, memore del suo primo mestiere, andava a curare i falconi, con grandissima consolazione del nuovo falconiere, il quale poteva dormir della grossa. Questa era l'unica ora del giorno che mastro Benedicite, non ricordandosi d'altro, potesse parer sano di mente. Tornato di là, egli impazziva da capo; non faceva che ridere mostrando i denti, come un melenso; stava le intiere giornate seduto, o ritto in piedi nella strombatura d'una finestra, con le mani raccolte sul petto, e le dita intrecciate, facendosi girare i pollici l'uno intorno all'altro, e non si smuovendo da quel suo lavoro, se non per tracannare le ciòtole di vino che gli ministrava l'amico.
Il nipote Anselmo da parecchio tempo non dimorava più a Roccamàla. Desideroso di spendere utilmente la vita, egli s'era dato al mestiero delle armi, e militava sulle galere della repubblica genovese capitanate da Enrico di Mare. Mastro Benedicite non avea dunque più altri che il monaco, e questi lo curava a modo suo, tanto più volontieri, in quanto che beveva egli pure le medesime pozioni.
Talfiata il pazzo ci aveva i suoi lucidi intervalli. E allora vedeva conte Ugo, vedeva il demonio; aveva paura di frate Gualdo, che gli pareva lungo lungo, e gridava come un ossesso, chiedeva mercè e cadeva spossato sul pavimento. Altre volte aspettava il cavaliero di Lamagna; comandava che fossero messe in pronto le stanze migliori del castello per accogliere degnamente il nuovo signore; borbottava di mali consigli del monaco, di testamento falso, ed altre cose simiglianti, che faceano correre i brividi per l'adipe a fra Gualdo e gli mettevano le ali a' piedi per andare alla botte, spillarne una coppa e darla a bere al disgraziato castellano.
– Bibe, fili mi, – diceva egli, – In vino veritas, e non dirai più sciocchezze.
– Vade retro, Satana! vade retro! – urlava sovente Benedicite, respingendo il ventre del cisterciense e facendogli rovesciare il vino sulla tonaca.
Quella povera tonaca era proprio inzuppata degli umori di Bacco, e tra pel vino e pel grasso delle vivande che ogni giorno le sgocciolava su, s'era coperta di frittelle. A cagione delle quali, e degli occhi sempre luccicanti come carbonchi, e del naso bitorzoluto che appariva sempre rosso come un peperone maturo, i famigli, già rotti allo spropositare latino, solevano chiamarlo col nome di Pater Vinosus; nè egli mostrava adirarsene.
D'altra parte, il corruccio non gli sarebbe tornato a vantaggio; che anzi!.. Avete a sapere che frate Gualdo, di giorno, alla luce del sole, ci aveva un cuor di leone, ma alla sera, e segnatamente a notte inoltrata, diventava un coniglio. Però suonata l'avemmaria, incominciava a bere per quattro; chiamava al simposio i famigli; li teneva a bada con cento chiacchere e con versate continue; poi, quando fosse ben cotto, era portato di peso nella sua stanza e issato a gran forza di braccia nel letto. Nè permetteva che lo lasciassero subito; voleva che stessero un tratto in preghiera con lui, alternando le sorsate co' paternostri, e finalmente si addormentava, dicendo loro:
– Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem!
Cotesto farà intendere ai lettori che paura s'avesse in corpo fra Gualdo la sera del 29 novembre. La tempesta s'era proprio tutta addensata su Roccamàla. Per le ampie finestre era un lampeggiare continuo; il tuono assordava; e' pareva l'inferno scatenato, alla distruzione del castello.
Il pazzo stava immobile accanto ad una finestra e sembrava non addarsi di nulla, nè della tempesta che incalzava di fuori, nè del tramestìo di allegrezza e di spavento che regnava dentro la sala.
Lo spavento era del monaco, che biascicava testi latini ad ogni guizzo di lampo; l'allegrezza era dei famigli, che cioncavano alla sua salute e gli davano la baia.
– Reverendissimo pater Vinosus, o perchè non bevete? – gridava il capo degli arcieri, che i nostri lettori rammenteranno ancora, per un certo suo dialogo con mastro Benedicite sul principio di questa storia. – Vinum bonum laetificat cor hominis.
– Ah sì! egli c'è altro da pensare in questi momenti – rispondeva il monaco. – Pregare bisogna, pregare che Domineddio ci abbia in custodia. Siete eretici, voi altri?
– Che dimanda, pater Vinosus! – entrò a dire un altro della brigata. Noi siamo tutti credenti; non è egli vero, Guercio?
– Sicuro! – rispose quegli ch'era stato chiamato in causa con quel nome e che ben lo meritava, a cagione di un occhio assente. – Io sono credente come il patriarca Noè, buon'anima sua. Nel buon vino ho fede, e credo che sia salvo chi ci crede.
– Optime! optime! come dice il nostro fra Gualdo, quando è di buon umore.
– A proposito! – soggiunse un altro. – Fra Gualdo, quando è di buon umore, ci canta un certo salmo…
– Ah sì, un inno della Chiesa! Io lo so per filo e per segno, e se vi garba…
– Figliuoli! figliuoli! – interruppe fra Gualdo, che stava come rannicchiato nel mezzo. – Non mettete in tavola le marachelle di un povero peccatore, il quale ora ne domanda perdonanza a Dio. Pregate, pregate per voi e per lui! Ah! Domine salvum fac servum tuum! —
Le interiezioni e il testo latino del monaco erano cagionati da uno scroscio di folgore, che, a giudicarne dalla simultaneità del lampo e del tuono, doveva aver dato lì presso, sull'erta della rocca. Il pauroso s'era fatto bianco nel volto come un cencio lavato; le sue mani avevano esclusivamente afferrato uno dei famigli che gli stava vicino.
– Coraggio, pater Vinosus, coraggio! Gli è nulla… un tuono più asciutto degli altri… Suvvia, bevete questo cordiale, che vi rimetterà un po' di sangue nelle vene.
– Sì, figli miei, forse avete ragione; date qua!
– Oh! così va bene. E adesso mandate giù quest'altro; repetita… repetita… O come dite voi che non me ne ricordo più?
– Repetita juvant, – soggiunse il monaco. – Sì, veramente, io penso che mi faccia bene.
– Bevete dunque, e state di buon animo!
Rinfrancato da quelle chiacchiere e dal vin di Cipro, fra Gualdo incominciava a respirare. La tempesta di fuori pareva anche rimettere un tratto della sua furia. L'allegrezza della brigata cresceva, e il nostro pauroso frate non si scandolezzò punto, quando il capo degli arcieri intuonò l'inno che egli aveva insegnato.
– Ave color vini clari!
Ave sapor sine pari!
Tua nos inebriari
Digneris potentia. —
E tutti in coro, seguendo il ritmo e imitando la voce nasale del sacro cantore, ripeterono il ritornello:
Tua nos inebriari
Digneris potentia.
– La seconda strofa! la seconda strofa, Tebaldo!
– Riempite le ciòtole e ci vengo:
Primum gotum bibe totum!
Ad secundum vide fundum!
Tertium erit sicut primum;
Et sic semper bibe vinum.
– E adesso, figliuoli, tutti in coro, da bravi!
Bibitores exultemus
Vinum bonum quod habemus;
Adaquantes condemnemus
In æternam tristitiam.
– Amen! – cantò istintivamente fra Gualdo.
E tutti a ridere sgangheratamente, in quella che il loro Sileno vuotava d'un fiato la ciòtola.
– Sì, figli miei, state allegri; lo raccomanda anche il Salmista: servite Domino in lætitia. In fondo in fondo, che cos'è il vino? Una orrevol bevanda, che al figlio di Dio, sceso in terra per le nostre peccata, non dispiacque di assumere a simbolo del suo santissimo sangue. Beviamo dunque, e adoriamo i decreti della divina provvidenza. Tebaldo, riempitemi la tazza! —
Il capo degli arcieri fu sollecito ad obbedirlo. Ma in quella che fra Gualdo stava per accostar la ciòtola alle labbra, il pazzo mise un grido acuto, che gliela fece rovesciar sulla tonaca.
– Che è stato? – diss'egli, alzandosi a stento per andare verso la finestra. – Messere Anacleto, che avete voi ora?
– Ah! – gridò il pazzo, con le braccia tese e gli occhi sbarrati. – Non vedete voi? —
E accennava fuori della finestra.
– Ma che? ma dove? – dimandò il monaco. – Io vedo i lampi che solcano l'aria e abbarbagliano la vista. Non temete, messere Anacleto, io reciterò la preghiera contro la tempesta. Domine Jesu qui imperasti ventis et mari, et facta fuit tranquillitas magna, exaudi preces familiæ tuæ, et præsta ut, hoc signo sanctæ crucis, omnis discedat sævitia tempestatum.
– No la tempesta! no la tempesta! – gridava il pazzo. – Vedete, vedete, là nella torre! Ah, egli è là dentro, lo spirito punitore!.. —
Guidato dalle parole di Benedicite, fra Gualdo aguzzò gli occhi verso la torre, e nell'intervallo di due lampi, vide la finestra del Negromante illuminatad'una luce rossastra.
Anche i famigli erano corsi ai veroni, per vedere che fosse che metteva tanto spavento al castellano.
– To'! – disse Tebaldo, – C'è lume nella torre.
– Gli è un brutto segno! – sclamò un altro.
– Baie, di tanto in tanto lo si vede, e il mondo non si muta per ciò.
– No, ti dico; sono anni ed anni che il prodigio non si è più ripetuto. È l'anima del vecchio conte che viene a visitar casa sua, e ogni qual volta ci viene, una disgrazia accade in Roccamàla.
– Raccontale a' tuoi bambini… quando ne avrai!
– Ma vedi, vedi quella ombra nera che passa in mezzo alla luce!
– Sì, e che perciò? Adesso andremo a vedere che diavol c'è. Il bernardone sa a menadito tutte le formole per cacciare i demonii, e la faremo finita con questo. Ohè, pater Vinosus!
– Che dite, voi, Tebaldo?
– Che noi si va alla torre, e che voi ci avete a venire in compagnia, per dire una parolina a questo spirito, il quale si piglia spasso de' fatti nostri.
– Che vi salta in mente, figliuol mio? Andare alla torre…
– O che volete che faccia a voi il demonio, se pure gli è un demonio e non un capo scarico che ha voglia di ridere? Voi portate la tonaca del glorioso san Bernardo, e i diavoli hanno paura di essa come dell'acqua santa.
– Non dico di no… Ma adesso, in verità…
– Suvvia! suvvia! Che peccati vi pesano sull'anima, che avete più paura di noi? —
Con queste e con altre simiglianti esortazioni, e meglio ancora, mandandolo innanzi a furia di spintoni, gli avvinazzati arcieri condussero il frate nel corridoio che metteva alla torre. Il povero Sileno tremava a verghe; un sudor freddo gli sgocciolava dalla fronte giù per le gote paffute; e tra spinte e sponte andava pure innanzi, facendo crocioni in aria, l'un dopo l'altro, e borbottando parole latine.
Giunto a poca distanza dalla porta temuta, si fermò, e tirandosi a fianco qualchedun altro, disse alla brigata:
– O non vedete, figli miei? L'uscio è aperto.
– Tanto meglio! – rispose Tebaldo. – Segno che qualcuno c'è entrato, od è uscito.
– Ma vedete! c'è lume!
– Che novità! Una lucerna accesa; ecco il grande prodigio che vi fa tremare così. Io metto pegno che sarà qualche sguattero, il quale avrà portato quassù i suoi amori di cucina, e adesso, udito il nostro avvicinarsi, avrà scantonato. Ma noi gli metteremo le mani addosso, e voi, Pater Vinosus, li congiungerete debitamente in facie Ecclesiæ, perchè non si dia scandalo alla comunità. —
Una risata universale accolse l'arguzia dell'arciero.
– Avanti, fra Gualdo, avanti, e benedite gli sposi!
– Adjuro te, Satana… – borbottava intanto il povero monaco, già più morto che vivo.
– Suvvia, l'uscio è questo, e non dalla parete… —
Fra Gualdo, come il lettore avrà indovinato, voleva entrare in compagnia di qualchedun altro; però rallentava il passo e si tirava da un lato. Ma un ultimo spintone di que' capi scarichi gli fece, a suo malgrado, varcare la soglia.
– Ah! – gridò egli; e fu l'ultimo grido.
Ma la gaia brigata non lo intese; esso andò perduto in un lampo, in un rombo, in un frastuono, in un polverio, che fecero balzare indietro e cader tramortiti gli arcieri.
Quando si riebbero, un gran vuoto era dinanzi a loro; i lampi, rischiarando l'aria, mostrarono il vasto cielo nuvoloso. La torre del Negromante s'era inabissata, e fra Gualdo, il malo consigliero di mastro Benedicite, si era sprofondato con essa.
CAPITOLO XX
Come espiasse il suo fallo la dama di Torrespina
Povera donna! Bene avea detto Ugo, la notte che fu di sua morte, pensando ai dolori che le erano serbati.
Povera donna! Tutto ciò che Helel avea presagito di lei, era pure avvenuto. Il morir subito, dopo ciò che ella seppe, le sarebbe stato ventura.
Che cuore fu il suo, come rimase di sasso, allorquando Fiordaliso si scusò a lei del non essere salito al ritrovo, il lettore potrà indovinare, non io per fermo descrivere. E colui che aveva scalato il verone? Non aveva egli il volto, la persona, i modi tutti del giovine trovatore? Poteva ella forse ingannarsi?
Ma il suo stupore divenne terrore, allorquando Fiordaliso, stretto dalle sue dimande, soggiogato dalla sua ansietà, ebbe a narrarle dell'incontro notturno, dello spirito malvagio e del cavaliero sconosciuto che gli stava daccanto. Chi era costui? Se lo infausto pellegrino di Roccamàla era tornato, il cavaliero sconosciuto non poteva esser altri che Ugo, venuto ai suoi danni, orrenda visione, dal regno della morte.
A mutare il dubbio in certezza, giunse due giorni di poi una paurosa novella. Il fulmine aveva distrutto la torre del Negromante in Roccamàla, facendola precipitar nel torrente. I messaggieri raccontavano, coi capegli ritti sul fronte e colla voce tremante, i particolari della luce rossastra che i famigli del castello avevano veduta apparire dal luogo maledetto, e come fosse fatto uno scongiuro, e come nella rovina della torre fosse perito fra Gualdo. I monaci del vicino convento erano andati il giorno appresso a rovistar le macerie per disseppellire il compagno. E l'avevano rinvenuto, orrendamente sfracellato, per modo che soltanto dai brandelli della tonaca s'era potuto chiarire chi egli fosse. Ma in quel mezzo (cosa da far raccapriccio!) i pietosi cisterciensi avevano trovato altresì il corpo d'un giovine cavaliero, che fu da tutti agevolmente riconosciuto per Ugo, conte di Roccamàla, morto e sepolto sei anni innanzi, da un altro lato del castello. Quel cadavere era fresco ed intatto; soltanto mostrava una cicatrice, quasi un marchio rosso, nel mezzo della fronte.
Cotesto aveva grandemente turbati gli animi dei vassalli della rocca. A tutti allora era sovvenuto della notte del 29 novembre, di sei anni innanzi, e della ospitalità concessa al maledetto romèo. Andati incontanente alla tomba di Ugo, l'avevano scoperchiata: era vuota! Impossibile il dubitare più oltre; quel cadavere fresco ed intatto era del conte Ugo. Un nuovo arcano recava la spiegazione del primo.
Ma dov'era stato per sei anni, e che cosa avea fatto il conte redivivo? Questa era la dimanda che tutti facevano. Fu allora che Enrico Corradengo venne fuori con una storia che mai fino a quel giorno aveva ardito narrare. Ansaldo di Leuca era vissuto pochi istanti ancora, dopo la partenza dei due vincitori dalla quercia di Marenda, ed egli aveva raccolto le sue ultime parole, nelle quali il nome di Morello era alternato col nome di Ugo di Roccamàla, come se il morente volesse dire di aver ravvisato l'estinto Ugo nel volto del vincitore, quando s'era inginocchiato su lui, per dargli il colpo della misericordia. Egli, Corradengo, l'aveva creduta sempre una ubbìa di Ansaldo, l'effetto di una allucinazione dell'agonìa, epperò non ne aveva mai fatto parola ad alcuno. Ora intendeva ogni cosa; e come fosse stato ucciso Ansaldo, e come egli, Corradengo, il forte Corradengo, avesse potuto esser vinto e beffato da un Rambaldo di Verrùa. Quello era un giuoco infernale, la vendetta di uno spirito.
Dopo queste novelle, era venuta in campo la pazzia del vecchio strozziere; la storia del cavaliero di Lamagna, che, comparso una volta, non era più tornato a ripetere il suo; il falso frate che, dopo avere straziato co' rimorsi il cuore di Benedicite, si era dileguato ghignando, e simili altre novità che poco lume avrebbero potuto recare da sole, ma che unite, disposte intorno ad un fatto, lo rischiaravano in ogni sua parte e ne faceano balzar fuori il concetto recondito.
Dolorosa, senza fine dolorosa, fu nella mente di quella povera donna la ricostruzione del passato, operata a stento con tutti que' particolari che giungeva tratto tratto a risapere. Che significavano tutte quelle vendette? Perchè Ugo il felice aveva eletto di finire a quel modo? La leggenda di Roccamàla, da lui reputata uno spauracchio d'anime volgari, era dunque vera? Lo spirito familiare del Negromante era venuto, e gli aveva fatto scorgere la vanità d'ogni cosa? Tutti coloro che la sua collera avea colpiti, tutti avevano obliato l'estinto. Ella stessa!.. Il falso Morello… Il falso Fiordaliso… Già col primo infedele, sebbene nel pensiero, alla memoria dell'estinto, ella aveva ceduto al secondo!.. Lo spirito esacerbato era stato mai sempre daccanto a lei; aveva vuotata a lenti sorsi la coppa del suo disinganno.
Così guidata da un tenue filo, ella avea indovinato, quantunque imperfettamente, ogni cosa. E ricordava allora le amare voluttà di una notte d'amore, certi sospiri, certe occhiate malinconiche dell'innamorato, che parea sopraffatto dalla sua medesima felicità; com'egli la stringesse forte nelle sue braccia, quasi volesse soffocarla, come si dimostrasse tenero, come tremasse all'avvicinarsi dell'alba. Ah, ma se ad Ansaldo di Leuca, all'amico traditore, egli si era fatto scorgere nell'ultima stretta, perchè a lei pure non s'era mostrato? Perchè non l'aveva uccisa allora, nel suo ultimo amplesso? Qual pietà era mai quella, che la condannava a struggersi lentamente di terrore, di rimorso e di vergogna?
Povera donna! povera donna! Sentirsi morire, e dover dissimulare la sua agonia al cospetto della sua gente, del marito e degli ospiti! Sapersi colpevole verso due, scorgersi involta in una trama mezzo umana e mezzo infernale, era un supplizio orribile ch'ella non potea a lungo durare.
Versò la piena delle sue angoscie a' piedi d'un santo monaco. Frate Alberto era santo perchè umile; la sua mente non era ricca d'ingegno, ma il suo cuore aveva tesori di pietà, e le sue labbra spandevano sulle ferite i balsami del perdono. Il povero vecchio udì quel lungo e doloroso racconto, tremò tutto e vide a quante orribili prove fosse dannata la creatura; levò gli occhi al cielo, adorò l'ignoto, l'incomprensibile, e assolse quella donna, a gran pezza più infelice che rea.
Quasi sarebbe inutile il dire che il biondo Fiordaliso, fallita la prima occasione, non ottenne più il farmaco invocato al suo male d'amore. E' lo portò altrove, farfalla vagabonda, il suo male, e parve aver trovato un farmaco in Provenza, alla corte del Poggio. Ma il suo risanamento non piacque al marito della gentil medichessa; il volto del biondo trovatore fu orridamente sfregiato, e insieme con la bellezza andò la fortuna. Il paggio infedele di Ugo, diventato un vile borsiere, morì di mala morte, dopo aver trascinata una lunga ed ignominiosa vita, non di castello in castello, ma di tugurio in tugurio.
Madonna Giovanna rimase in vita, ma peggio che morta. Ella aveva apparenza di spettro, anziché di creatura vivente. La morte di messer Corrado, avvenuta qualche anno di poi, la sollevò del peso di mentire e le diede agio a struggersi in pace. Era tempo!
Ella comperò da Anselmo, rimasto erede di Benedicite che s'era spento in silenzio, la signoria di Roccamàla, e colà si ridusse a vivere, dopo aver ceduto il manièro e le ville di Torrespina ad un congiunto del marito. Aveva i capegli bianchi come neve; la persona pareva una statua di cera, che si muovesse per sottile artifizio d'ordigni nascosti. Per tutti i paesi circonvicini, nei quali ella spendeva ogni suo avere in limosine ai poverelli ed alle più bisognose famiglie, era chiamata la Santa di Roccamàla.
La sera del 29 novembre dell'anno 1295 aveva termine il suo martirio sulla terra. La notte innanzi ella aveva avuto una visione, la prima dopo cinque anni che recasse qualche sollievo alla sua anima travagliata. Ugo, il diletto Ugo, le era apparso, le avea perdonato, e la chiamava con sè. Svegliatasi, le parve di sentirsi meglio; passeggiò a lungo per la collina; sorrise e diè la mano da baciare a tutti i vassalli che s'abbattevano in lei e si ponevano ginocchioni sul passaggio della santa. La sera si recò a pregare presso la tomba di Ugo; la mattina vegnente vi fu trovata morta, distesa supina, le mani giunte, come esemplare all'artefice che doveva effigiarla sul sarcofago a lei preparato sotto la medesima vôlta.
Roccamàla, per suo testamento, convertita in monastero, durò ancora tre secoli; poi cadde, come tutto cade quaggiù, sotto i colpi del tempo e delle umane vicende. Di presente ell'è un ammasso di rovine, neppur visitato da' viaggiatori eruditi, poichè non si trova sulla via consueta di Firenze, o di Roma, e gli italiani conoscono a menadito i castelli del Reno, sanno ogni leggenda delle montagne svizzere, ma non si danno un pensiero al mondo delle antichità, nè delle memorie paesane.
Cotesto è forse pel loro meglio; imperocchè, fatti più dimestici con le antiche storie e con le forti schiatte vissute prima di loro, avrebbero troppa ragione di arrossire.
Me i casi della giovinezza, più che curiosità d'antiquario, condussero a quelle, come a tant'altre rovine di castelli vicini. Il signore di que' luoghi, che è il marchese di Ponzone (non si dolga l'ottimo gentiluomo che io scriva il suo nome e paghi un tributo di lode alla sua cortesia co' vivi ed al suo rispetto pei trapassati), ha con imitabile esempio fatto restaurare quanto più si poteva dell'antico manièro, dando onorato luogo alle lapidi sparse, e facendo un ossario di tutte le umane reliquie male sepolte qua e là sotto le macerie.
Ho letto, non tutte bene, poiché ve n'ha di assai guaste, le iscrizioni sepolcrali di Roccamàla. Eccovi questa, che era la più grande tra tutte, scolpita in caratteri gotici, la quale fa fede della barbara latinità monastica del secolo XIII:
Postquam lux abiit vigesima nona novembris,
Mille ducentis quinque et nonaginta peractis
Annis a Christo, tumulo requiescit in isto
Mente pia cunctis praestans comitissa Joanna
Quae potuit dici tamquam sine labe Susanna.
Praeteriit sed non obiit; Deus ille deorum
Hanc rapuit simul et statuit super astra polorum.