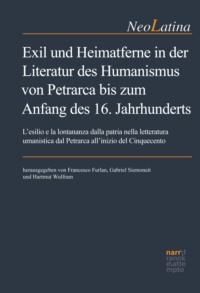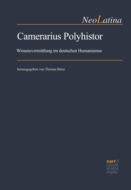Kitabı oku: «Exil und Heimatferne in der Literatur des Humanismus von Petrarca bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts», sayfa 4
Bibliografia
Afribo, Andrea: Petrarca e petrarchismo: Capitoli di lingua, stile e metrica, Roma 2009.
Agamben, Giorgio: Nymphæ, in: Image et mémoire: Écrits sur l’image, la danse et le cinéma, Traduit par M. Dell’Omodarme, S. Doppelt, D. Loayza et G. A. Tiberghien, Paris 2004, 37–69.
Antognini, Roberta: Il progetto autobiografico delle Familiares di Petrarca, Milano 2008.
Ariani, Marco: Petrarca, Roma 1999.
Blanc, Pierre: Le discours de l’intellectuel comme parole d’exilé: Psycho-poétique de l’exil chez Dante et chez Pétrarque, in: Jacques Heers / Christian Bec (edd.): Exil et civilisation en Italie (XIIe–XVIe siècles), Nancy 1990, 49–59.
Cachey, Theodor: Il lettore in viaggio con Francesco Petrarca, in: Luca Marcozzi (ed.): Petrarca lettore: Pratiche e rappresentazioni della lettura nelle opere dell’umanista, Firenze 2016, 143–155.
Carrai, Stefano: Il mito di Ulisse nelle Familiari, in: Claudia Berra (ed.): Motivi e forme delle Familiari di Francesco Petrarca, Milano 2003, 167–173.
Coletti, Vittorio: Storia dell’italiano letterario: Dalle origini al Novecento, Torino 22000.
Contini, Gianfranco: Preliminari sulla lingua del Petrarca [Paragone aprile 1951], in: Id.: Varianti e altra linguistica, Torino 1970, 169–192.
De Robertis, Domenico: Petrarca petroso, Revue des é tudes italiennes ns. 29, 1983, 13–37.
Fenzi, Enrico: Saggi petrarcheschi, Fiesole 2003.
Fenzi, Enrico: Petrarca e l’esilio: Uno stile di vita, in: Anna Fontes Baratto / Marina Gagliano (edd.): Écritures de l’exil dans l’Italie médiévale, Arzanà 16–17, 2013, 365–402.
Filippini, Célia: v. Telesinski, Anne-Marie.
Gentili, Sonia: Solitudine, in Luca Marcozzi / Romana Brovia (edd.): Lessico critico petrarchesco, Roma 2016, 308–320.
Grimaldi, Marco: Petrarca, il «vario stile» e l’idea di lirica, Carte romanze 2, 2014, 151–210.
Guérin, Philippe: Autour des Rerum vulgarium fragmenta: Poésie et pensée de la ruine, in: Paolo Grossi / Frank La Brasca (edd.): Sul Canzoniere di Francesco Petrarca, Atti della giornata di studî (25 novembre 2005), Paris 2006, 101–137.
Guérin, Philippe: De l’image au texte et du texte à l’image: Sur les puissances de la peinture chez Boccace, in: Johannes Bartuschat (ed.): Boccace à la Renaissance: Lectures, traductions, influences en Italie et en France, Actes du Colloque international Héritage et fortune de Boccace, Université Stendhal Grenoble 3 (12–14 octobre 2006, Cahiers d’Etudes Italiennes. Filigrana 8, 2008, 13–39.
Guérin, Philippe: Pétrarque, ou de l’écriture comme odyssée, in: Voyages de papier: Hommage à Brigitte Urbani, Revue d’ é tudes italiennes du CAER, Aix Marseille Université 17/18, 2014, 31–57.
Guérin, Philippe: Poesia, in: Luca Marcozzi / Romana Brovia (edd.): Lessico critico petrarchesco, Roma 2016, 244–259.
Guittone d’Arezzo: Le Rime di Guittone d’Arezzo, A cura di Francesco Egidi, Bari 1940.
Manni, Paola: Storia della lingua italiana: Il Trecento toscano, Bologna 2003.
Marcozzi, Luca: Retorica dell’esilio nel canzoniere di Petrarca, Bollettino di italianistica ns. 8.2, 2011, 71–93.
Marcozzi, Luca: Petrarca e l’esilio nel tempo, in: Elisa Brilli / Laura Fenelli / Gerhard Wolf (edd.): Images and words in Exile: Avignon and Italy at the beginning of the 14th century, Firenze 2015a, 223–237.
Marcozzi, Luca: Petrarca testimone dell’esilio di Dante, in Johannes Bartuschat (ed.): Dante e l’esilio, Ravenna 2015b (Letture classensi, vol. 44), 97–126.
Marcozzi, Luca: Tempo, in Luca Marcozzi / Romana Brovia (edd.): Lessico critico petrarchesco, Roma 2016, 321–332.
Patota, Giuseppe: La grande bellezza dell’italiano: Dante, Petrarca, Boccaccio, Roma / Bari 2015.
Perrus, Claude: La sextine LXXX du Canzoniere, Chroniques italiennes 61, 2000, 5–15.
Petrarca, Francesco: Opere: Canzoniere, Trionfi, Familiarum rerum libri [testo latino secondo l’edizione critica curata da Vittorio Rossi e Umberto Bosco per l’Edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca, Firenze, Sansoni, 1933–1942, X–XIII], Firenze 1992a.
Petrarca, Francesco: Secretum / Il mio segreto, A cura di Enrico Fenzi, Milano 1992b.
Petrarca, Francesco: Les remèdes aux deux fortunes / De remediis utriusque fortune, Texte établi et traduit par Christophe Carraud, Commentaire, notes et index par Christophe Carraud, 2 vol., Grenoble 2002.
Petrarca, Francesco: Canzoniere, A cura di Ugo Dotti, 2 vol., Roma 22004a.
Petrarca, Francesco: Canzoniere, Edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milano 22004b.
Petrarca, Francesco: Canzoniere: Rerum vulgarium fragmenta, A cura di Rosanna Bettarini, 2 vol., Torino 2005.
Petrarca, Francesco: Lettres de la vieillesse / Rerum senilium, Édition critique d’Elvira Nota, Traduction de Claude Laurens, Présentation, notices et notes de Ugo Dotti, Mises en français par Frank La Brasca, 5 vol., Paris 2002–2013 [I, 2002; II, 2003; III, 2004; IV, 2006; V, 2013].
Petrarca, Francesco: Res seniles: Libri V–VIII, A cura di Silvia Rizzo con la collaborazione di Monica Berté, Firenze 2009.
Rico, Francisco: I venerdí del Petrarca, seguito da Profilo biografico del Petrarca in collaborazione con Luca Marcozzi, Milano 2016.
Rigo, Paolo: Petrarca esule? Un (non) esilio per ritrovarsi, in: Peter Kuon / Enrica Rigamonti (edd.): Narrarsi per ritrovarsi: Pratiche autobiografiche nelle esperienze di migrazione, esilio, deportazione, in collaborazione con Monica Bandella e Daniela Baehr, Firenze 2016a, 79–87.
Rigo, Paolo : I motivi dell’Itinerarium di Francesco Petrarca e il destinatario della Fam. XXIII 11, Le tre Corone 3, 2016b, 75–92.
Santagata, Marco: Per moderne carte: La biblioteca volgare di Petrarca, Bologna 1990.
Santagata, Marco: I frammenti dell’anima: Storia e racconto nel Canzoniere di Petrarca, Bologna 22004.
Stroppa, Sabrina: Petrarca e la morte tra Familiari e Canzoniere, Roma 2014.
Telesinski, Anne-Marie / Filippini, Célia: Métaphores et métamorphoses de l’exil dans le Canzoniere de Pétrarque, in: Anna Fontes Baratto et Marina Gagliano (edd.): Écritures de l’exil dans l’Italie médiévale, Arzanà 16–17, 2013, 141–155.
Tonelli, Natascia: Varietà sintattica e costanti retoriche nei sonetti dei Rerum vulgarium fragmenta, Firenze 1999.
Tonelli, Natascia, Fisiologia della passione: Poesia d’amore e medicina da Cavalcanti a Boccaccio, Firenze 2015.
Torre, Andrea: Memoria, in: Luca Marcozzi e Romana Brovia (edd.): Lessico critico petrarchesco, Roma 2016, 182–194.
Ungaretti, Giuseppe: Il poeta dell’oblio, in: Mario Diacono / Luciano Rebay (edd.): Vita d’un uomo: Saggi e interventi, Milano 1974, 398–422.
Vecce, Carlo: Francesco Petrarca: La rinascita degli dèi antichi, in: Gian Carlo Alessio (ed.): Il mito nella letteratura italiana, vol. I: Dal Medioevo al Rinascimento, Brescia 2005, 177–228.
Vitale, Maurizio: La lingua del Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta) di Francesco Petrarca, Padova 1996.
«Cacciato e isfolgorato dalla fortuna»: Variazioni sul tema dell’esilio, e gli inizî della novella italiana
Piotr Salwa (Roma)
Tra gli studî critici dedicati alla novellistica «di stampo boccacciano» numerosi sono quelli dedicati alle cornici, anche in àmbito europeo e non solo in lingua italiana.1 La cornice, infatti, rappresenta una caratteristica essenziale di un determinato tipo di raccolta narrativa: alcune antologie e/o storie dei generi letterarî la trattano addirittura come un fondamentale criterio tipologico, distinguendo le raccolte «a cornice» dalle sillogi che ne sono sprovviste. Considerata un tempo anzitutto come un espediente formale in grado di conferire all’opera letteraria la necessaria «unità», ma in buona misura di per sé sprovvisto dell’interesse artistico ravvisabile nelle novelle stesse, ha poi attirato l’attenzione dei critici sia come istanza narrativa atta a suggerire una lettura o un’interpretazione dei racconti, sia come discorso in un certo senso metanarrativo che inquadra e modifica ciò che vien veicolato a livelli testuali «inferiori».
Tra i varî aspetti e motivi presenti nelle cornici, merita un momento di riflessione la frequente ricorrenza – quasi un luogo comune del genere – delle trame che hanno il loro nucleo nell’allontanamento dei protagonisti dai luoghi e dalle situazioni abituali della loro esistenza «normale» e quotidiana. Il «novellare» fa parte di solito di un dialogo che si svolge in circostanze insolite o addirittura singolari e drammatiche.2 Prima tuttavia di soffermarci sui casi concreti che si riscontrano in alcune narrazioni novellistiche, sarà utile ricordare una tipologia, anche sommaria, relativa all’allontanamento da un luogo considerato «naturale» per l’individuo.
Il fenomeno vanta ormai una Sekundärliteratur sterminata, ma in questa sede vorrei riferirmi in particolare a un modesto studio di Janina Abramowska che, ispirandosi ai suggerimenti di Michail Bachtin e di Jurij Lotman, propone talune distinzioni elementari che sembrano, ai nostri fini, poter costituire un buon punto di partenza.3 Anche se possono apparire ovvie o addirittura banali, esse permetteranno di tracciare una specie di mapping e di collocare le situazioni concrete riscontrate nelle cornici nell’ambito di un vasto spettro di possibilità virtuali. In primissimo luogo, «allontanarsi» significa dunque abbandonare lo spazio chiuso e familiare rappresentato dalla propria casa per affrontare una realtà piú o meno sconosciuta. Può trattarsi di una decisione libera oppure di una costrizione di vario tipo, mentre la destinazione può essere deliberata, casuale o forzata. Fuori dell’ambiente domestico ci si può limitare a essere osservatori passivi, ma si può anche diventare, volontariamente o meno, protagonisti di vicende eccezionali. Le opposizioni casa vs. mondo, immobilità vs. movimento, stabilità vs. rischio, abituale vs. nuovo, proprio vs. forestiero, etc., si possono associare a valutazioni diverse e contrarie, ognuno dei poli assumendo, a seconda dei casi, un valore positivo o negativo, anche alla luce di pregiudizî e stereotipi di carattere ideologico. Si aggiunga infine che chi abbandona la propria casa può esser percepito come individuo che séguita ad appartenere alla propria collettività, ma altresí come un forestiero. Anche al ritorno a casa, del resto tutt’altro che scontato, si possono attribuire segni diversi: esso può equivalere negativamente a una sconfitta, a una rinuncia o alla ricerca d’un rifugio, ma nella tradizione letteraria il ritorno è di norma connotato piuttosto positivamente, essendo un indiscusso happy end vissuto senza riserve. Esso coincide con il superamento degli ostacoli, con la vittoria sull’avversario (che aveva messo a repentaglio la pace domestica preesistente), con il ritorno all’equilibrio. Il ritorno a casa può tuttavia funzionare come un happy end soltanto nelle società che godono d’una certa stabilità, in cui si avverte univocamente e positivamente la consapevolezza d’avere nel mondo un posto proprio e stabile, e un forte legame con la collettività, con la casata e con la famiglia. L’allontanamento è, indipendentemente dalle motivazioni, un’esperienza chiusa ed eccezionale, non una regola.
In questo vasto e generico panorama l’esilio nel senso più specifico, benché storicamente impossibile da quantificare come fenomeno sociale, assume tuttavia un significato del tutto particolare, non foss’altro perché toccò in sorte a personaggi illustri e di primo piano. La condizione di esule segnò infatti profondamente l’esistenza o l’esperienza di grandi figure della storia e trovò espressione in opere di grande valore e lunga durata. In una prima e ristretta accezione, l’esilio significherebbe inizialmente l’allontanamento forzato d’un cittadino dalla patria, una forma di punizione o repressione, dunque, ma il campo semantico del termine è andato notevolmente estendendosi, certo sotto le pressioni delle svariate situazioni reali. Esso può riferirsi ugualmente a un allontanamento apparentemente volontario, ma in realtà imposto dalla logica dei fatti principalmente per evitare violenze o persecuzioni, le negative conseguenze d’una determinata situazione politica o sociale, ma anche per fuggire problemi fiscali o legali. L’esilio può riguardare singoli individui o intere etnie, può esser interno o interiore, senza uno spostamento fisico e limitato alla sfera psicologica, oppure esterno. Talvolta la differenza tra esilio ed emigrazione non sembra affatto scontata. Per evitare definizioni restrittive, nelle nostre considerazioni potremmo definire l’esilio in modo assai generico, come quello spostamento da un primo luogo «abituale» a un secondo luogo diverso ed estraneo in cui il desiderio d’abbandonare l’uno prevale decisamente sul desiderio di raggiungere l’altro.
*
Nella novellistica italiana i motivi connessi a quel complesso insieme d’idee o di concetti emergono fin dall’inizio.4 Nell’esaminarne le varianti piú significative ci sembra d’uopo ricorrere a un breve questionario, in cui proponiamo di prendere in considerazione i seguenti criterî:
1 esilio volontario / esilio involontario (forzato)
2 motivazione
3 luogo di partenza (caratteristica dominante)
4 luogo d’esilio (caratteristica dominante)
5 tipo di contrasto (peggioramento / miglioramento delle condizioni di vita)
6 ritorno / non ritorno
7 esperienza positiva / esperienza negativa.
Di là da ogni dubbio giustificato o persino (in questo genere di confronti) obbligatorio, il nostro principale punto di riferimento sarà ovviamente fornito dalla cornice del Decameron. In questa sede sarebbe superfluo il ricordarne dettagliatamente la trama. Si tratta del volontario e ben ponderato allontanamento dalla propria città – o patria – d’un gruppo di parenti, vicini e amici le cui motivazioni vengono esplicitate in un articolato discorso dell’«ideatrice» dell’impresa: Pampinea. La sua lunga giustificazione dimostra che si tratta d’una decisione tutt’altro che scontata. È un allontanamento privo di qualsiasi riferimento di carattere politico – la politica è in generale poco presente sulle pagine del Decameron – e di qualsiasi forzatura umana, ma volontario, in realtà, soltanto «in superficie», in quanto a uno sguardo piú attento si rivela condizionato e operato sotto l’ineluttabile costrizione del destino, dato che la vita dei protagonisti si trova in costante pericolo, minacciata com’è dalla peste che infuria in città e dal degrado sociale che vi s’accompagna. Richiamandosi, dunque, sia alla «natural ragione» che alle leggi e all’esempio altrui, i protagonisti affermano il loro diritto di difendere la propria incolumità e – visto che rimanere sul posto si ridurrebbe a un inutile e assurdo «essere testimonie di quanti corpi morti ci sieno alla sepoltura recati […] o ascoltare se i frati di qua entro […] alle debite ore cantino i loro uffici»5 – decidono che la miglior loro difesa consiste nel partire. Allontanarsi sarà inoltre utile dal punto di vista morale, in quanto nella città devastata regnano la dissolutezza e la corruzione; la morte corporale vi s’accompagna alla morte spirituale, ugualmente minacciosa. E anche questo contribuisce a creare quel clima d’insopportabile oppressione in cui l’autoesilio risulta essere l’unica degna soluzione. Pampinea non manca di notare, del resto, come anche sotto tale aspetto la realtà fiorentina sia del tutto contraria alla normalità:
veggiamo coloro i quali per li loro difetti l’autorità delle pubbliche leggi già condannò ad essilio, quasi quelle schernendo, per ciò che sentono gli essecutori di quelle o morti o malati, con dispiacevoli impeti per la terra discorrere […].6
Se in città trovano rifugio quelli che ne son stati giustamente esiliati, devono cercar rifugio in esilio coloro che non vogliono arrendersi di fronte alla corruzione dilagante.
Del resto i protagonisti della cornice decameroniana non fanno altro che seguire l’esempio di molti concittadini:
io giudicherei ottimamente fatto – dice Pampinea – che noi, sí come noi siamo, sí come molti innanzi a noi hanno fatto e fanno, di questa terra uscissimo, e fuggendo come la morte i disonesti essempli degli altri, onestamente a’ nostri luoghi in contado, de’ quali a ciascuna di noi è gran copia, ce ne andassimo a stare, e quivi quella festa, quella allegrezza, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare in alcuno atto il segno della ragione, prendessimo.7
La preoccupazione nei confronti dell’onestà da servare ritorna altresí nel breve dibattito che segue la proposta:
se alla nostra salute vogliamo andar dietro, trovare si convien modo di sí fattamente ordinarci, che, dove per diletto e per riposo andiamo, noia e scandalo non ne segua.8
L’esilio scelto dai narratori decameroniani ha una durata ben limitata. Al momento della partenza la questione non desta troppe preoccupazioni e vi s’accenna solo in maniera indiretta: la discretissima Filomena dubita fortemente «se noi alcuna altra guida non prendiamo che la nostra, che questa compagnia di dissolva troppo piú tosto e con meno onore di noi che non ci bisognerebbe», mentre Pampinea si dichiara pronta a dar a tutti l’esempio «per lo quale di bene in meglio procedendo la nostra compagnia con ordine e con piacere e senza alcuna vergogna viva e duri quanto a grado ne fia».9 Trascorsi quindici giorni dalla partenza, la gentile brigata decide di tornare sui proprî passi, non senza però – ci si dice – un animato dibattito: «i ragionamenti furon molti tralle donne e tra’ giovani, ma ultimamente presero per utile e per onesto il consiglio del re […]».10 Di contro alla dettagliata argomentazione addotta per convincere i protagonisti alla partenza all’inizio dell’opera, alla sua fine bastano poche e generiche affermazioni:
acciò che per troppa lunga consuetudine alcuna cosa che in fastidio si convertisse nascer non ne potesse, e perché alcuno la nostra troppo lunga dimoranza gavillar non potesse, e avendo ciascun di noi, la sua giornata, avuta la sua parte dell’onore che in me ancora dimora, giudicherei, quando piacer fosse di voi, che convenevole cosa fosse omai il tornarci là onde ci partimmo.11
Nulla fa invero pensare che siano cessate le disastrose condizioni che erano state all’origine della decisione di partire e le preoccupazioni or ora menzionate non hanno certo, in quel preciso momento, una ragion d’essere piú fondata che per l’innanzi. La chiave della svolta sarebbe piuttosto da ricercarsi nel fatto che in quel breve arco di tempo s’è compiuto il senso ed è stato conseguito l’obiettivo ideale dell’allontanamento. Si conclude il ciclo che aveva dato a ciascun componente della brigata la possibilità d’essere per una giornata «onorato e ubbidito come maggiore»,12 e con esso prende forma anche un ideale ciclo narrativo, in modo più discreto vengono messi in risalto due aspetti di quel volontario e breve esilio, con un leggero ma significativo spostamento d’accenti rispetto al momento della partenza. L’obiettivo principale della partenza – quello di «dovere alcun diporto pigliare a sostentamento della nostra sanità e della vita, cessando le malinconie e’ dolori e l’angoscie, le quali per la nostra città continuamente […] si veggono»;13 viene confrontato con il modo in cui esso è stato raggiunto:
il che secondo il mio giudicio noi onestamente abbiam fatto; per ciò che, se io ho saputo ben riguardare, quantunque liete novelle e forse attrattive a concupiscenzia dette ci sieno, e del continuo mangiato e bevuto bene e sonato e cantato (cose tutte da incitare le deboli menti a cose meno oneste), niuno atto, niuna parola, niuna cosa né dalla vostra parte né dalla nostra ci ho conosciuta da biasimare; continua onestà, continua concordia, continua fraternal dimestichezza mi ci è paruta vedere e sentire.14
Ciò che si riferiva alla realtà fisica e corporea si trova ora in secondo piano, mentre si evidenzia l’aspetto morale e quella che potrebbe definirsi come l’«arte del vivere». Lontano dalle frenetiche preoccupazioni della vita cittadina, e consapevoli del fatto che «le cose che sono senza modo non possono lungamente durare»,15 i protagonisti hanno saputo creare durante quel breve periodo un ambiente cortese e raffinato, alto e nobile, sereno e dedito a onesti piaceri.
Trovandosi per forza di cose in una situazione del tutto eccezionale, liberi loro malgrado dalle preoccupazioni della routine quotidiana, avendo a disposizione tutto il loro tempo e giornate intere, i protagonisti della cornice creano un rituale in cui uno spazio significativo viene dedicato al piacere, sia esso rappresentato dal «continuo mangiare e bere bene» o da «liete novelle» e risate, oppure da passeggiate tra paesaggi incantevoli e, ancora, da balli e canti. La narrazione che ci offre il Boccaccio mette in risalto soprattutto l’importanza del dialogo.
Infatti, al lettore del Decameron, anche poco attento, non possono sfuggire le aperture al dialogo segnalate in varî luoghi del testo. L’opera si presenta già nel titolo come relazione di una serie d’incontri e di conversazioni: «Comincia il libro […] nel quale si contengono cento novelle, in diece dí dette da sette donne e da tre giovani uomini».16 Sin dall’inizio della narrazione il Boccaccio assume apertamente un atteggiamento dialogico, intendendo istituire rapporti diretti con il pubblico da lui privilegiato, le donne, rivolgendosi direttamente a esse: «Quantunque volte, graziosissime donne, meco pensando riguardo quanto voi naturalmente tutte siete pietose[…]».17 Alla partecipazione al dialogo e al dibattito attorno al libro invitano palesemente le stesse, impegnate pagine dell’introduzione alla Quarta giornata e della Conclusione dell’autore, ove si richiamano alla memoria le voci, anche e soprattutto quelle ostili, che già corrono e che dialogano con il Boccaccio narratore, e ove si ribadisce l’importanza della benevolenza e dell’appoggio che l’autore attende dai proprî interlocutori.
Il dialogo non soltanto caratterizza la relazione che l’autore del Decameron intende istituire con i lettori, ma al tempo stesso funziona come parte integrante dei dibattiti che si svolgono tra la lieta brigata. A metterlo in rilievo serve l’accuratissima forma da tutti rigorosamente rispettata. Il dialogare è regolato da una precisa etichetta di norme e di civiltà. Gli incontri hanno luogo sempre alla stessa ora e nello stesso luogo, si svolgono secondo procedure formalizzate e sempre uguali. La cura costante della forma fa sí che nessuno manchi di rispetto al re o alla regina della giornata, nessuno trasgredisca l’ordine nel parlare, nessuno proponga temi estranei ai limiti prestabiliti, nessuno dimostri impazienza nell’ascoltare o, peggio, interrompa l’oratore. Il senso di un tale dialogo consiste fra l’altro nell’opporsi con imperturbato ordine alla disgregazione della civiltà dalla quale i narratori fuggono. L’unico disturbo viene provocato dall’irruzione, all’inizio della Sesta giornata, dei due rozzi servitori Tindaro e Licisca, respinti non solo con risa carnevalesche, fragorose ma chiaramente impregnate di un senso di superiorità, ma altresí dalla ferma decisione della regina: «mentre la Licisca parlava, facevan le donne sí gran risa, che tutti i denti si sarebbero loro potuti trarre […]. […] la reina con un mal viso le ‘mpose silenzio e comandolle che piú parola né romor facesse».18 Al dialogo possono partecipare soltanto coloro che rispettano degli alti criterî morali. Perciò, tra i rischi connessi al prorogare oltre misura l’esilio, Panfilo cita anche il seguente: «Senza che, se voi ben riguardate, la nostra brigata, già da piú altre saputa da torno, per maniera potrebbe multiplicare che ogni nostra consolazion ci torrebbe».19
L’esilio serve dunque, principalmente, in quanto prova di carattere ed esperienza che arricchisce chi la vive soprattutto grazie a una «civil conversazione» ante litteram. L’essersi sottratti alle costrizioni del quotidiano permette un dialogo piú libero, uno scambio d’idee piú aperto e piú innovativo, nonostante il rispetto delle forme. Il ritorno alla normalità avviene in una condizione morale, fisica e spirituale migliore di quella iniziale. Di nuovo, è un percorso in qualche misura analogo a quello che sono chiamati a compiere i lettori del Decameron nell’auspicio dell’autore:
Questo orrido cominciamento vi fia non altramenti che a’ camminanti una montagna aspra e erta, presso alla quale un bellissimo piano e dilettevole sia reposto, il quale tanto piú viene lor piacevole quanto maggiore è stata del salire e dello smontare la gravezza. E sí come la estremità della allegrezza il dolore occupa, cosí le miserie da sopravegnente letizia sono terminate.20
Il gran motivo della cornice riecheggia poi – e la cosa sembra piuttosto scontata – in alcune novelle della raccolta. Sebbene a volte non sembri chiara la linea di demarcazione tra esilio ed emigrazione, il senso dell’allontanamento dalla patria risulta piuttosto evidente, a cominciare dalla novella di apertura (Dec. I, 1), raccontata «acciò che, quella udita, la nostra speranza in lui [sc. Dio], sí come in cosa impermutabile, si fermi e sempre sia da noi il suo nome lodato».21 I suoi protagonisti sono italiani residenti da tempo in Francia, accomunati da un certo senso di solidarietà di fronte ad un ambiente «forestiero», anche se lontanissimi gli uni dagli altri per il loro status sociale e per le motivazioni che li hanno spinti a vivere all’estero: per ser Musciatto Franzesi, «di richissimo e gran mercatante in Francia cavalier divenuto»,22 si trattava d’una brillante carriera politica; per i fratelli fiorentini in Borgogna, «li quali quivi a usura prestavano»,23 della possibilità di svolgere una sospetta ma lucrativa attività economica; per ser Ciappelletto, «il piggiore uomo che mai nascesse»,24 con ogni probabilità della fuga da qualche persecuzione penale, da una esplicita condanna o magari da una vendetta privata. Per tutti, l’allontanamento dalla patria offriva la possibilità di portare alla perfezione il proprio carattere: di grand’uomo d’affari, spregiudicato ed efficace, o di minuto ma spietato sfruttatore o, ancora, di perfetto depravato. Tra emigrazione ed esilio si definisce altresí lo status dei tre fratelli fiorentini (Dec. II, 3), i quali decidono di lasciare la loro città natale per non far vedere la povertà in cui erano caduti per lo smisurato e dissennato loro spendere. Anche per loro il vivere lontano dalla patria è una prova di carattere che riescono a superare, una chance che non si lasciano sfuggire di rifarsi dell’avvilimento di cui sono essi stessi colpevoli.
Il modo d’intendere la funzione dell’esilio diventa piú palese nel confronto di altre due varianti del motivo, l’una ambientata nel mondo aristocratico, l’altra nel mondo comunale.25 Le due novelle sono situate direttamente l’una dopo all’altra: nella prima (Dec. II, 8), il virtuoso conte d’Anguersa parte all’estero per fuggire le possibili e minacciose conseguenze di false accuse (si tratta essenzialmente del motivo noto dalla biblica vicenda della moglie di Putifarre); nella seconda (Dec. II, 9), a fuggire, sempre per via di false accuse connesse alla sfera erotica, è la virtuosa moglie del mercante Bernabò da Genova. Anch’essi superano la prova di carattere, e benché in entrambe le novelle sia in definitiva la Fortuna a decidere del lieto fine «oltre alle speranze» dei protagonisti,26 per i narratori e per il lettore ciò non è altro che una giusta ricompensa per la loro integrità morale. Né molto diverso sembra il caso di Tedaldo degli Elisei (Dec. III, 7) che, respinto dall’amata, dopo varî e vani tentativi per riacquistarne l’amore perduto,
a doversi dileguar del mondo, per non far lieta colei che del suo mal era cagione di vederlo consumare, si dispose. E, presi quegli denari che aver potè, segretamente, senza far motto ad amico o a parente, fuor che ad un suo compagno il quale ogni cosa sapea, andò via […].27
Non tutti protagonisti decameroniani sono tuttavia in grado di superare la prova. Cosí, la fuga di tre coppie d’innamorati in cerca della libertà necessaria a vivere le loro passioni (Dec. IV, 3) finisce in una sanguinosa tragedia. Ciò non cambia, tuttavia, la prospettiva generale: l’esser lontano da casa propria è piuttosto un’occasione da sfruttare, che di solito si rivela utile; e si vedano persino casi cosí «radicali» quali il rapimento della moglie di messer Ricciardo da Chinzica (Dec. II, 10), che trova nel rapitore che se la porta via un uomo preferibile al vecchio marito, e nel rapimento l’occasione di liberarsi di lui.
L’impostazione che il Boccaccio ci propone merita evidentemente il confronto con quella lunga tradizione testuale, e con l’immaginario a essa connesso, in cui l’allontanamento dalla casa e soprattutto il viaggio o la peregrinazione rappresentano metaforicamente un’acquisizione d’esperienza vitale per la statura spirituale del protagonista: a partire da racconti mitologici e biblici, attraverso le fiabe e la poesia epica, fino a Dante, ammirato maestro del Certaldese. Come sempre accade per le strategie narrative minuziosamente elaborate e poi precisamente messe in opera dal Boccaccio, il loro senso andrebbe ricercato in un sottile gioco di analogie e innovazioni, di continuazione e rottura, di consenso e contraddizione. Si tratta, tuttavia, di un confronto che esula dai limiti del breve saggio presente.
Il grandioso tessuto narrativo del Decameron diventa presto, com’è noto, una sorta di «tela aida» sulla quale dei cosiddetti epigoni s’applicheranno a sovrapporre i loro «ricami», non sempre di grande eccellenza. La distanza che separa le loro narrazioni dalla raccolta boccacciana non sembra tuttavia esser sempre l’effetto di un’inconsapevole mediocrità, e potrebbe ben risultare sia da una loro particolare – e assai diversa dalle nostre – interpretazione delle novelle, sia da un calcolato tentativo di piegare il modello ai loro intenti, diversi da quelli del pur ammirato autore. In tale chiave si possono leggere anche i riferimenti al motivo che ci interessa in questa sede. Vediamone due esempî significativi.