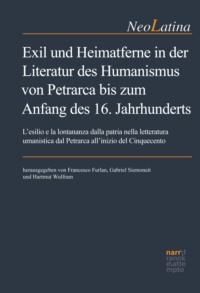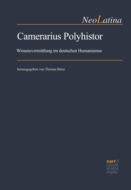Kitabı oku: «Exil und Heimatferne in der Literatur des Humanismus von Petrarca bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts», sayfa 12
In un altro epigramma, poi, il poeta confermava che la dolce Parthenope lo aveva generato dalla stirpe dei Pandoni, non senza confessarvi, ai vv. 3–6, probabilmente in risposta a chi lo credeva veramente nato a Roma,21 di non essere romano per nascita e di non potersi, perciò, dire discendente di Enea:
Non sum, confiteor, Romana natus in urbe
nec pater Æneas sanguinis auctor erit;
sed me Pandonio peperit de sanguine dulcis
Parthenope, patrio virgo sepulta solo.22
Dedicato al cardinal Prospero Colonna,23 per lunghezza, contenuti e varietà d’intonazione l’epigramma proemiale esibisce una caratteristica Gattungsmischung: l’autobiografia nel solco della poesia esilica di Ovidio, la satira moraleggiante d’intonazione patetica derivata da Giovenale, l’ekphrasis erudita alimentata da interessi antiquarî specifici e attualmente oggetto di particolare attenzione da parte degli studiosi dell’umanista.24 Il poeta motiva (nei versi 173–196 UV=145–168 B) la propria partenza da Napoli lasciando intendere d’aver preso una decisione non facile, costretto da nemici che gli avevan reso la vita impossibile nella corte napoletana nonché dall’imbarbarimento suscitato dai costumi importati da príncipi stranieri, estranei all’austero mos maiorum della nobiltà napoletana; e annuncia, inoltre, il progetto di trasferirsi presso la corte del duca Sforza (vv. 1–10 UVB):
Ibit ad Insubrum superatis fluctibus urbem,
Ibit ad Anguigerum Musa beata ducem.
Nec sine te tumeant pictæ data vela carinæ,
o decus, o sacræ relligionis honor.25
Non tamen incipiam divina a prole tuorum
Nec quantum volites docta per ora virum:
Ad mea si quando spirabunt carmina Musæ,
cantabo generis nomen et arma tui.
Namque ubi Phœbeo fuerim percussus œstro,
Gaudebit tanti nominis auctor avus.
Nel congedarsi dal cardinal Colonna, membro della famiglia illustre e potente cui s’era legato sin dagli anni della formazione romana,26 il poeta saluta Roma, sua seconda patria, descritta passo passo in una mappa di antiquitates connotanti la città, care insieme a lui e al destinatario del carme (vv. 15–30 UVB):27
Destituo septem collis urbemque Quirinam
Et qui Tarpeia summus ab arce tonas;
Destituo delubra deum et laquearia tecti
Ærea et æratas per loca sacra fores;
Destituo insignes arcus mirasque figuras
Et conscriptorum marmora viva patrum,
Quin et cælatas mira novitate columnas,
in quibus Augusti Cæsaris ossa cubant;
Destituo celebris spectacula vana theatri
quin etiam veterum monumenta virum,
et vos, o Phidiæ divi opus aut Polycleti,
marmora Salmatica [sic!] candidiora nive.
Destituo Charites Pario de marmore nudas,
par quibus est ætas, par quoque forma quibus;
destituo tandem pompas clarosque triumphos
et vetus imperium cæsareosque deos.
Ci troviamo qui dinanzi a una vera e propria mappa di Roma che parte dall’ovvia celebrazione dei sette colli e del mito di fondazione della città stessa, e si snoda in un itinerario che illustra monumenti mirabili e connotanti il panorama dell’antica capitale, ma rende anche omaggio al cardinal Colonna, ai suoi interessi di collezionista e antiquario, alla storia della sua casata.28 Nell’ordine il poeta cita infatti anzitutto il tempio di Giove Capitolino (v. 16 UVB) attraverso l’apostrofe diretta al dio che tuona dall’alto della rocca Tarpea,29 e poi il piú importante luogo della città santa, la basilica di San Pietro, evocata attraverso preziose e allusive perifrasi nel distico 17–18 (destituo delubra deum et laquearia tecti / ærea et æratas per loca sacra fores, UVB).30 La visuale piú generale del distico successivo, 19–20 UVB, che apre uno squarcio sul panorama delle rovine della città attraverso le ovvie citazioni d’archi, statue e ritratti degli eroi della storia antica, inclina poi di nuovo nel distico successivo (vv. 21–22 UVB) al riferimento puntuale e dettagliato, attraverso la rievocazione della colonna di Traiano (Quin et celatas mira novitate columnas, / in quibus Augusti Cæsaris ossa cubant), resa ben identificabile dall’artificio della decorazione e dalla notizia che le ossa d’un imperatore vi riposano nel basamento.31 La citazione della colonna Traiana, ben inserita nel panorama d’antiquitates romane, è anche un omaggio al dedicatario, il cardinal Colonna, e alla sua potente famiglia, che secondo una tradizione proprio da quella colonna aveva tratto il nome, dal momento che la dimora storica della famiglia Colonna era situata sul Quirinale, in prossimità proprio dell’antico monumento.32 Emerge una peculiare tensione celebrativa, esplicita nei vv. 7–8 UVB nei quali il poeta promette per l’appunto un’opera in cui, se opportunamente ispirato dalle muse, canterà generis nomen et arma del cardinal Colonna. Nei due distici successivi (vv. 23–26 UVB) egli menziona ancora in termini allusivi un teatro famoso che senza troppi problemi può esser identificato nell’anfiteatro Flavio, e una scultura di marmo attribuibile a Fidia o a Policleto, di piú problematico riconoscimento.33 Nel distico successivo (vv. 27–28 UVB) l’autore dice addio anche a un monumento rappresentante le Cariti scolpite nude nel marmo pario, e ancora (vv. 29–30) alla storia stessa di Roma, ai suoi trionfi, all’antico potere e agli dèi protettori dei Cesari. Anche questo passo cela un’allusione celebrativa alla famiglia Colonna, e nello specifico al cardinal Prospero che, appassionato archeologo, nel palazzo romano di famiglia sul Quirinale, la cosiddetta Loggia dei Colonnesi,34 esponeva già alla metà del Quattrocento un’antica scultura raffigurante le Cariti rinvenuta nel giardino del palazzo stesso o forse in un sito archeologico sui colli Albani posseduto dalla famiglia.35
La porzione successiva inclina a toni piú drammatici e sentimentali, e apre in maniera inattesa uno spaccato della vita familiare del poeta, che nelle tristi circostanze dell’addio evoca le figliolette e la devota e schiva moglie (vv. 31–36 UVB):
Præterea dulces, patris pia pignora, natos
Desero et uxoris ora pudica meæ
Bisque duæ flebunt, me discedente, puellæ,
quarumque maior nunc patris orat opem.
Ut cito labenti succrescunt gramina rivo,
sic adolet nostra virgo quaterna domo.
La scena (segnata dall’unica similitudine che si registra nel carme) apre uno spiraglio sulla poco nota dimensione intima e domestica del Pandoni: le quattro figlie (quattro appunto, come si ricava anche da altri carmi, cui va aggiunto il figlio maschio Laurentius o Laurus, come il poeta alternativamente lo chiama)36 sono presentate dal poeta in lacrime, mentre la maggiore di esse reclama giustamente il conforto e la presenza del padre. La similitudine, che accosta le figlie all’erba che cresce veloce lungo il corso d’un ruscello, riconcinna con abilità il ricordo d’Ovidio, Amores 2, 16, 9–10 (versi non a caso autobiografici che rievocano Sulmona fertile di biade e di viti, ricca d’erbe sempre rinascenti per lo scorrere di ruscelli), e in realtà l’intero passo è tramato di tessere classiche che mostrano di prediligere Ovidio (cfr., per esempio, gramina rivo e Ov., Met. 9, 656; patris pia pignora natos e Ov., Fast. 3, 775: patres sua pignora natos), un auctor ben presente al Pandoni, anche nella sua produzione piú ardua, rappresentata per esempio dai Fasti di cui il poeta reclamava copie agli amici corrispondenti.37 Ovidio vi risulta un modello di calzante ispirazione soprattutto nei passi in cui piú incisiva risulta la topica dell’addio, della lontananza, del congedo disperato: la specifica movenza dell’addio alla moglie e alle figlie risulta infatti, a mio avviso, ispirata da reminiscenze ovidiane, che restano sullo sfondo come apporti tematici (per esempio, Ov. Trist. 3, 3, 18; o 3, 4, 59 per il riferimento alla moglie), ma forniscono anche piú decisivi apporti (per esempio, Trist. 1, 3, 17 per l’addio alla moglie).38
All’addio alla moglie e alle figlie39 segue il congedo dalla cerchia degli amici romani, che mostra quanto il Pandoni fosse inserito nei circoli culturali della città, e in particolare negli ambienti della curia pontificia (vv. 37–62 UVB):
Quinetiam linquo tristes abiturus amicos,
de quorum multis Cambius unus erat.
Mirantur patres abitus interque loquuntur
Deque patrum sermo plurimus ore cadit.
Nemo tamen potuit tacitam cognoscere mentem,
Nemo meæ potuit certior esse viæ.
Consilium solus nosti et mea pectora solus,
Melchior, o phidibus altera Musa meis.
Me quamvis Tybris, me quamvis Martius ultro
Sæpe vocet Campus et vocet urbis amor,
Etsi nulla meam succendit gloria mentem,
Ibit ad Anguigerum Musa vocata ducem.
Iam tandem ad vates deflexit lumina divus
Cæsar: adeste novem numina magna deæ!
Imperat Augustus vivitque hoc tempore Cæsar:
Surge, age, Musa, redi; surge, age, vive, Maro.
Inde mihi venient animo vigilata sereno
Carmina fatidico, carmina digna deo.
Hic tuus, hic vates dicar, dignissima coniunx,
Ne careas titulo nominis ipsa mei.
Cessabunt luctus, suspiria nulla subibunt,
Nulla tuas tinget roscida gutta genas.
Hic stringunt lachrymas trepidæ, mea cura, puellæ,
Nullaque de patris omine tristis erit.
Accedo miræ laudis succensus amore
Me trahit Anguigeri gloria summa ducis.
Laddove di difficile identificazione risulta il Cambius pur citato con particolare enfasi, il Melchior del v. 44 (UVB) potrebbe invece esser facilmente identificato in Melchiorre Bandini da Camerino, cavaliere del Sacro ordine gerosolimitano, segretario e visitatore per l’Ordine in Francia nel 1446, presidente e procuratore generale nella curia di Roma sotto Paolo II, nel 1451 sicuramente legato di Niccolò V, e amico carissimo del poeta che in piú luoghi dell’opera ne tesse le lodi.40 A quei passi che aprono uno spiraglio sulla dimensione piú intima e affettiva del poeta, l’orditura poetica affianca poi versi d’atmosfera cortigiana, una dimensione cui il Pandoni sintonizzò la sua vita, la sua poesia, la sua attività culturale. L’arrivo alla corte di Milano è immaginato da lui come l’approdo agognato che metterà fine alle sue miserie e alla disperazione della moglie e delle figlie (55–58 UVB):
Hic tuus, hic vates dicar, dignissima coniunx,
ne careas titulo nominis ipsa mei.
Cessabunt luctus, suspiria nulla subibunt,
nulla tua tinget roscida gutta genas.
L’ultima sezione del carme è animata da una ispirazione drammatica, fortemente invettiva e satirica, che si traduce anche in una strenua orditura retorica e in forti coloriture che rimandano al modello della satira di Giovenale. Un modello che, di contro al canone satirico classico che dichiarava sempre gli archetipi, non è mai esplicitamente citato dal poeta, ma emerge nell’intensa, violenta e sofferta intonazione. Il contesto improprio in cui è calata l’ispirazione invettiva ci mette dinanzi a uno dei tanti risultati della contaminazione di generi e forme cui gli umanisti amarono sottoporre la lezione dei classici, riattualizzandola e rifunzionalizzandola.41 E d’altra parte il Pandoni non era nuovo al genere satirico, dal momento che nel codice Conv. Soppr. J IX 10 (240) della Biblioteca Nazionale Centrale fiorentina, una delle piú complete raccolte dell’opera in versi del Pandoni, si legge alle cc. 44r–55r un lungo e complesso componimento (tuttora inedito) che reca sin dal titolo la definizione di Satyra (inc. Mene tibi facilem quondam caput orbis et una; expl. casta cupidine penetrarant tela sagictæ). A Giovenale riconduce senz’altro la tragica pittura della dilagante corruzione sociale che imbarbarisce Napoli (173–176 UV→145–148 B):
Nam mea Parthenope iam facta est barbara: mores,
Lingua habitusque virum barbariem redolet.
Non possum mores patriæ sufferre vetustæ,
Non possum Crassos Tantalidesque pati.
Da un lato, la satira III di Giovenale – con il suo complesso quadro di Roma come città in cui non c’è piú luogo per lavori onesti; anzi, in cui chi è onesto non può piú vivere42 – offre una trama su cui poggiare la denuncia del decadimento di Napoli; dall’altro, la prima satira dello stesso Giovenale, soprattutto nei vv. 87–117, fornisce l’apporto retorico dell’indignatio. L’uso del modello classico non è un mero ricalco, ma è come incanalato a rappresentare, in un’intensa attualizzazione, comportamenti e atteggiamenti (177–188 UV→149–160 B):
Hic nullus rerum pudor aut reverentia divii
Nullaque servatur gratia, nulla fides.
Strangulat hic omnes funesta pecunia, vincit
Bella Venus, vincit et Ganymedis amor.
Es leno impurus, placet alea, fallis amicos,
Es tandem dignus fulmine? Divus eris!
Quid refert viris tanto indulgere labori
Quidve bonas artes edidicisse iuvat?
Non est virtuti quisquam locus, usquam triumphat
Sanguinis atra sitis et comes invidia.
Corrupti mores, corrupta tempora magni
Principis in patriam qui tulit arma meam.
La matrice giovenaliana è svelata nella contaminazione dei versi 12–13 della decima satira: «sed pluris nimia congesta pecunia cura / strangulat et cuncta exuperans patrimonia census», che dà vita al verso sentenzioso Strangulat hic omnes funesta pecunia (v. 179 UV→151 B). Il recupero della preziosa tessera giovenaliana definisce il contesto poetico in cui l’autore intende muoversi nel costruire il complesso epilogo del carme: l’appoggio alla satira retorica di Giovenale legittima a un tempo l’orditura retorica dei versi e il temperamento incline al patethikon, in cui s’incunea anche la reale esperienza esistenziale dell’uomo e del poeta. L’alta moralità di cui il poeta si fa rappresentante e che lo costringe ad allontanarsi da una patria pure amata, onorata ed esibita come cifra d’identità e d’appartenenza vi spiega l’assoluto predominio della feroce denuncia moralistica, della decadenza del costume e della politica a Napoli e alla corte dei sovrani aragonesi. Il lusso d’oltremare importato dalla corte aragonese, la magnificentia esaltata dagli umanisti come la cifra connotante il regno di Alfonso, sono proposti in una luce negativa e considerati come la causa del disfacimento e della decadenza morale della città, dove non c’è piú posto per la virtú e su tutto trionfa la sete di sangue e l’invidia sua compagna, sanguinis atra sitis et comes invidia.43 Il riferimento a mores, lingua habitusque virum che puzzano di barbarie ha una sua pregnanza: si appunta infatti sugli specifici cambiamenti che investirono la società napoletana con l’entrata d’un sovrano straniero (e barbaro) che portava con sé i suoi funzionari da una terra lontana, innestando Napoli e il regno all’interno del sistema politico e amministrativo della corona d’Aragona.44Il Pandoni si appropria di motivi precisi della propaganda filo-aragonese e li rilegge in una prospettiva satirica e negativa alla luce del tipico moralismo suntuario che condannava le innovazioni di comportamenti sociali come mode cortigiane e ne identificava, cosí, la paternità nei costumi d’una corte allogena, estranea al mos maiorum napoletano. Ci troviamo, dunque, dinanzi a una vera e propria palinodia con doppia partitura, politica e moralistica, che pare voler rinnegare un decennio e piú di lodi e celebrazioni per Alfonso composte dal poeta, a partire dal Triumphus Alfonsi regis, il poemetto con cui l’umanista si presentò al Magnanimo ottenendone il favore.45 Un passo del secondo canto proprio del Triumphus ci offre un significativo termine di paragone per tale palinodia (vv. 94–120):
Sed tua Parthenope regum certissima sedes
Quæ tibi Romanos dederit servata triumphos,
Hanc cecinit regis memorandam in sæcula laudem:
‹Rex, decus Hesperiæ, genus alto e sanguine regum
Innumeros populos et regna ingentia centum
Qui subigis, proavos imitatus et alta parentum
Nomina, quo incolumi nullum sperare timorem
Possumus, o Siculi, spes tandem et gloria, salve.
Salve iterum dive Cæsar, salve omnibus une,
Une tamen dilecte Deis. Tibi sidera et auster
Militet æthereus, tua Mars tibi vota secundet,
Fortunetque armatus iter seu lætus ad Indos,
Ad Thetidis seu pergis aquas gelidosque Triones,
Seu Libyem irrigui terres trepida ostia Nili,
ut tua Cæsareis veneremur gesta triumphis.
Te mage nemo pius, bello nec clarior; adde
Iustitiam sanctamque fidem et moderamina rerum.
Dicam equidem in medium felicia tempora, dicam
Felicem hanc patriam et qui te sub Cæsare vivunt.
Te duce, parta quies populis, te pacis amatæ
Auctoremque ferunt; duce te, virtusque pudorque
Iam subeunt; periere simul scelus omne nefasque
Et scelerum damnata fides, periere tyramni,
Et, duce te, fulvi redierunt sæcla metalli.
Tu pacis fundator ades, nisi numina fallant,
Læta vetus veteres faciet tibi Roma triumphos
Altaque Cæsareas statuent Capitolia pompas›.46
Il poeta vi poneva sulla scena la città di Napoli che, personificata, prendeva la parola per rivolgere al vincitore Alfonso una lunga e accorata apostrofe celebrativa all’interno del trionfo allestito per il re conquistatore. I vv. 96–120 del Triumphus celebravano infatti Alfonso non solo quale re di stirpe essa stessa regale e guerriero vittorioso, ma anche quale pacis fundator, secondo uno dei motivi piú fortunati del mito del Magnanimo, quello del re pacificatore e garante di pace.47 L’iconografia alfonsina acquisí a tal punto il motivo che nelle medaglie coniate dal Pisanello il ritratto d’Alfonso è accompagnato dall’epigrafe Triumphator et pacificus; nelle iscrizioni dell’arco di trionfo Alfonso volle che fosse posta l’epigrafe «Alphonsus rex Hispanus, Siculus, Italicus, pius, clemens, invictus»; e nella pagina iniziale splendidamente miniata del codice 831 della fiorentina Biblioteca Riccardiana contenente i Gesta di Bartolomeo Facio, campeggia affianco alla figura di un guerriero su un cavallo bardato di rosso la scritta «Alfonsus rex pacis».48 All’esaltazione del valore guerriero del Magnanimo il poeta fa seguire nel Triumphus – ancora per bocca di Parthenope – il catalogo delle virtú di pietas, iustitia, fides, temperantia che il re incarna, annunciando poi i tempi nuovi che la città s’accingeva a vivere sotto la guida del re e della sua dinastia come novella e tà dell’oro (v. 116: Et duce te fulvi redierunt sæcla metalli), un’epoca di pace, priva di scelleratezze e di tirannie, secondo un topos particolarmente caro alla storiografia dinastica aragonese.49
Di contro al preludio celebrativo contenuto nell’antico poemetto composto un decennio prima, tra il ’43 e il ’44, in questo componimento il poeta individua nello sfarzo della corte alfonsina l’esca della dissolutezza che aveva travolto senza limiti la città, in piena sintonia con la letteratura non allineata (188–196 UV→161–168 B):
Emicat Astræi pennata per æthera virgo
Virgoque virginibus it comitata tribus.
Hei mihi, nulla sacris dantur sua dona poetis,
Virtutum nulla præmia, nullus honos.
Unus adulator socium ducit agmina et aures
Principibus hic solus datque adimitque sacri.
Non sic cognomen Tarquinum odere Quirites,
nomen ut exorret nescia turna meum.
Rispetto al mito della Napoli alfonsina il capovolgimento è perfetto: alla città sede di scuole d’antica tradizione sapienziale, alla capitale d’un regno governato da un principe che incarna un ben definito sistema di virtú sociali e politiche comprendente la clementia, la pietas e la iustitia, a quel locus d’edenica bellezza,50 il poeta oppone un luogo di disfacimento morale abbandonato dalla giustizia significata dalla dea Astrea, da ogni senso di religiosità e di rispetto significato dalle tre dee che formano il corteggio di Astrea, ovvero Fede, Speranza e Carità; insomma un luogo dove non c’è piú spazio per lo ius, per le arti liberali e, soprattutto, per la poesia. Al mito dell’età alfonsina come novella e tà dell’oro, come tempo di rinnovamento e di pace, il Pandoni contrappone un’attualità fatta da corrupti mores nei corrupta tempora d’un principe che ha osato volgere le armi contro la sua patria. E la contrapposizione, tutta giocata su di una precisa identità morale della città rinnegata e decaduta, trova nella figura d’Alfonso il suo fulcro, sicché al sovrano di cui la letteratura di corte vantava la provenienza spagnola, da una terra che aveva partorito a Roma una schiera d’illustri imperatori (di cui il Magnanimo sarebbe stato l’ultimo e piú eccelso rappresentante),51 il Pandoni oppone un principe straniero, sí, ma anche barbaro, che con i suoi costumi ha contaminato un’intera città;52 al sovrano connotato da una purezza quasi monacale dei costumi,53 il Pandoni contrappone il monarca d’una città dissoluta e in preda a devianti brame sessuali;54 al sovrano che si vuole l’incarnazione perfetta di un sistema di virtú comprendente fortitudo, clementia, iustitia e gravitas, protettore di artisti e poeti, giusta il mito costruito da Bartolomeo Facio nei Commentarii e da Antonio Panormita in quell’opera singolare e sfuggente che fu il De dictis et factis Alfonsi regis,55 il Pandoni sostituisce qui la figura di un principe aggressore (v. 188 UV→160 B: in patriam qui tulit arma meam), ma debole, in quanto assoggettato alla volontà di un adulatore che ne disserra e richiude a proprio piacimento le orecchie. La citazione dell’adulatore, poi, non è solo mera rievocazione letteraria della adulandi gens prudentissima di Giovenale 3, 86, ma anche rappresentazione icastica della realtà subita dall’umanista: l’adulatore subdolo la cui figura vien posta all’apice del fosco quadro di dissolutezza che coinvolge insieme corte e città va infatti identificato in Antonio Panormita, influente consigliere del Magnanimo e nemico giurato del Pandoni:56 l’incompatibilità tra i due che, determinata da radicali differenze di carattere, di gusti poetici, di schieramenti ‹politici›,57 si fa risalire persino al 1432–33, seppur intervallata da periodi d’apparente non belligeranza rese sempre tumultuose le loro relazioni.58
Il disperato sfogo autobiografico si condensa poi in una nota sentenziosa di sapore liviano (cfr. Liv. 2, 2, 3), in cui il poeta dichiara che ormai a Napoli il suo nome è odiato piú di quanto fosse quello dei Tarquinii a Roma. Il doloroso addio a Napoli s’acquieta allora solo nella speranza d’esser accolto alla corte sforzesca e nella promessa finale di un canto (tipica prassi del Pandoni) che avrà a oggetto i fortia facta del duca (vv. 197–204 UV→169–176 B):
Ergo vale, o præsul, divina e prole Columnæ,
solus honestatis splendor honorque lyræ.
Et vos, o nati, vos, coniugis ora pudicæ,
Turba puellarum, quæ mea corda premis.
Nam mea Sforcigenam plenis petet aurea velis
Musa ducem, cuius fortia facta canam.
Hic pacem bellumque gerit sub fortibus armis:
Dat Latio leges et favet ingeniis.
Ma anche quei versi che modellano il ritratto dello Sforza su quello di condottieri e sapienti politici dell’Antichità (Hic pacem bellumque gerit sub fortibus armis: / dat Laio leges et favet ingeniis) è una palinodia di versi antichi in cui il poeta s’era scatenato contro lo Sforza dipingendolo come un tiranno perverso e ingiusto59 – contraddizione, questa, concessa dalla pragmatica etica adottata da un intellettuale alla ricerca di mecenati, di stipendî e di privilegi.